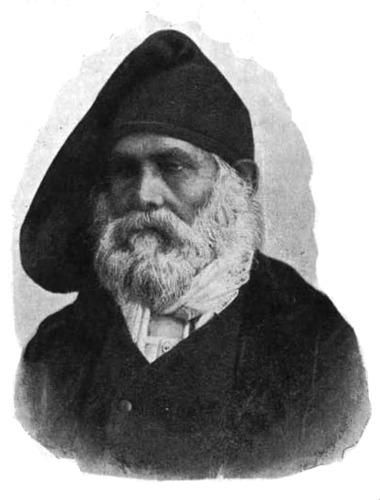
Title: Giovanni Tolu, vol. 1/2
Storia d'un bandito sardo narrata da lui medesimo
Author: Enrico Costa
Release date: July 27, 2025 [eBook #76574]
Language: Italian
Original publication: Sassari: Dessì, 1897
Credits: Barbara Magni and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by Sardegna Digital Library)
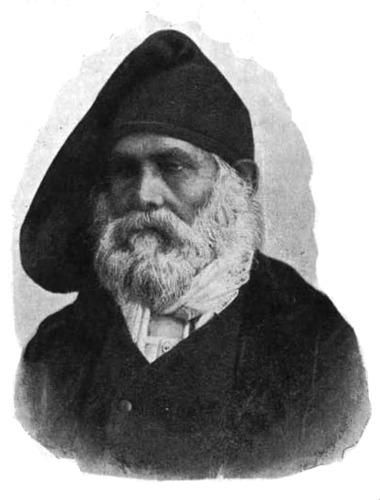
ENRICO COSTA
GIOVANNI TOLU
STORIA D’UN BANDITO SARDO
NARRATA DA LUI MEDESIMO
PRECEDUTA DA CENNI STORICI
SUI BANDITI DEL LOGUDORO
Con Vignette di Dalsani
Volume Primo
SASSARI
PREMIATO STABIL. TIP. G. DESSÌ
1897.
[5]
Verso gli ultimi di novembre dello scorso anno, rientrando nel mio studio, vi trovai un vecchio, che da mezz’ora mi aspettava.
Chiestogli il motivo della sua venuta, mi rispose con una domanda:
— È egli vero che lei ha scritto la storia di Giovanni Tolu, il bandito? Avrei piacere di leggerla.
— Non ho mai scritto storie di banditi viventi — risposi.
Il vecchio, senza punto scomporsi, ripigliò con sussiego:
— Se lei non l’ha scritta, è certo che ben presto la scriverà!
— E perchè dovrò scriverla?
— Perchè glie la dirò io, che sono Giovanni Tolu in persona.
La strana presentazione mi sorprese non poco; tuttavia risposi:
— Non so davvero perchè lei voglia narrarmi la sua storia, nè perchè io debba scriverla.
[6]
— Le dirò sinceramente, che ormai sono stanco e infastidito delle fandonie che si vanno spacciando sul mio conto. Lungo la mia vita di bandito e d’uomo libero — per oltre quarant’anni — si dissero e si stamparono sui miei casi inesattezze tali, che mi preme rettificare. Non voglio colpe, nè virtù che non mi spettano. Fui intervistato da un numero infinito di curiosi, italiani e stranieri, ma non volli finora aprire l’animo mio ad alcuno. Oggi solamente mi sono deciso a fare una confessione generale, schietta, veridica, senz’ombra di vanità, nè di secondi fini. Esporrò lealmente i casi della mia vita, persuaso che il racconto delle mie avventure desterà nel pubblico una curiosità non infeconda di ammaestramenti; di ammaestramenti per tutti: per le famiglie, per i giudici, per i disgraziati miei pari, ed anche per il Governo se vorrà trarne profitto. A settantaquattro anni non si hanno più speranze, nè timori; ed è perciò che io voglio presentarmi al pubblico tutto intiero, quale realmente fui, spogliando la mia vita da tutti gli episodi fantastici e bugiardi, di cui volle infiorarla il volgo... ed anche i signori. Ecco perchè voglio narrare la mia storia — ed ecco perchè lei dovrà scriverla!
La lunga tirata del bandito — che ho riportato parola per parola — mi colpì vivamente; tuttavia il mio proposito fu quello di sottrarmi ad un fastidio penoso, che non mi tentava per alcun verso.
Risposi francamente al vecchio bandito: che il narrare simile storia non era facile com’egli credeva; che bisognava studiare il modo conveniente di presentarla al pubblico; e che infine, prima di accingermi a scriverla, era necessario intendersela con un editore.
[7]
— Intendiamocela pure! — esclamò il Tolu col tono di un uomo incrollabile ne’ suoi propositi.
All’amico Giuseppe Dessì — l’editore da me consultato alla presenza del bandito — non spiacque l’idea; e mi pregò di accingermi all’opera.
Stabilite le condizioni, Giovanni Tolu si fermò in Sassari fino a tutto gennaio. Ebbe la pazienza di recarsi ogni sera nel mio studio, e mi dettò la sua lunga storia, che io trascrissi fedelmente.
Seduto dinanzi al camino, caricando o scaricando la sua pipa, il vecchio bandito (ora in buon sardo, ed ora in cattivo italiano) prese a narrarmi i casi della sua vita, risalendo ai nonni; e filò sempre diritto per venticinque giorni, con un ordine ed una chiarezza, ch’io non mi aspettava. Circostanze minuziose, dialoghi, nomi di persone e di località, episodi d’ogni genere, tutto egli mi espose scrupolosamente, senza mai confondersi, nè contraddirsi.
— Io voglio narrarle il bello ed il brutto — mi diceva ogni tanto — A lei buttar via ciò che crede inutile o insignificante.
Lo confesso: la semplicità, la schiettezza, l’ordine della narrazione, nonchè la varietà degli episodi, mi fecero lieto di aver aderito al desiderio dell’editore e del mio protagonista. Nessuna storia di bandito fu narrata finora con tinte più vere e con particolari più intimi; poichè non capita due volte il caso di un bandito famigerato, che, assolto dalle Assise di Frosinone (e meno male che non lo fu in Sardegna!) si decide a confessare coraggiosamente le sue colpe, senza tema che possa immischiarsene l’autorità giudiziaria.
[8]
La storia del Tolu abbraccia, fra gli altri, il tristo periodo che corse tra il 1850 e il 1860 — periodo ancor vivo nella memoria del popolo, poichè in esso appaiono le figure di Spano, di Derudas, di Cambilargiu, d’Ibba — tutti banditi famosi, che il Tolu ebbe a compagni, e di cui ci narra non poche gesta.
Mio primo proposito fu quello di servirmi dei copiosi materiali fornitimi dal Tolu per tessere una storia vera, ma tutta mia nell’ordine e distribuzione delle scene. Non tardai, in seguito, a rinunziare al mio disegno.
Io dissi a me stesso: — Perchè dovrò io torturarmi la mente, creando situazioni che possono cadere nel convenzionalismo? Perchè accingermi allo studio di artifizi letterarii, quando non pochi sono i testimoni viventi dei fatti che andrò esponendo? Perchè assumere la responsabilità di giudizi, che potrebbero glorificare od avvilire la figura d’un uomo disgraziato, ma colpevole sempre? Perchè, infine, dovrò io narrare la storia di Giovanni Tolu, quando con più efficacia può narrarla lui stesso?
Non trovando ragioni da opporre a tutte queste domande, rinunziai a scrivere un lavoro d’arte, e decisi di riportare fedelmente la confessione del Tolu, seguendo l’ordine da lui tenuto, e servendomi quasi sempre de’ suoi modi di dire. La storia del vecchio bandito (sebbene più prolissa e forse più noiosa) potrà così conservare tutta la natia semplicità, tutto il colore locale, e quella vergine impronta che darà maggior risalto al carattere del tempo, degli attori e dell’ambiente. Mi limiterò solamente ad apporre qua e là qualche breve nota appiè di pagina, quando la crederò necessaria.
[9]
Ho voluto visitare, in compagnia del Tolu, alcune località che furono teatro delle scene più salienti; ed ho quindi eseguito alcuni schizzi, sui quali il valente Dalsani di Torino studiò le macchiette riportate in questo libro. Dobbiamo al Turati di Milano la riproduzione in fototipia del ritratto recentissimo del vecchio bandito, fatto eseguire dall’editore.
Nel mio libro non si narrerà la storia di un semi-eroe, quale il poeta suol narrarla — nè la storia di un volgare assassino, come crudamente la registrano gli atti del tribunale. Si narrerà la storia di un uomo co’ suoi vizi, le sue virtù, le sue passioni. Certo è, che il lettore vi troverà molte cose ignorate, le quali potranno offrire argomento di profondo studio al psicologo ed allo storico.
Chi è Giovanni Tolu? — Un figlio di umili agricoltori florinesi, pieno d’intelligenza e di buon senso, ma educato nei modi che i tempi e l’ambiente consentivano; datosi giovanissimo alla campagna, dopo aver tentato di vendicarsi di un prepotente, da cui si credette maltrattato e deriso; punto nell’amor proprio di marito; deluso negli affetti di famiglia; errante per trent’anni di balza in balza, senz’amici, senza un consiglio pietoso, senza una parola di conforto; vivente nella solitudine come un selvaggio, oppure in compagnia di malandrini, dai quali non poteva attingere che eccitamenti a delinquere; odiato dai nemici, circondato da spie, perseguitato dai carabinieri; carezzato da deboli e da prepotenti per bisogno o per paura; glorificato insanamente dal volgo; fatto segno talora ad una curiosità entusiastica, fatalmente corruttrice; un misto, insomma, di bontà e di tristizia, di generosità e di ferocia, [10] di fede e di superstizione, di saggezza maravigliosa e d’intolleranza superba, senza neppure la coscienza del male che taceva agli altri ed a sè stesso.
Tutto questo il lettore dovrà considerare prima di leggere la storia di Giovanni Tolu; e quando l’avrà letta, studiando a mente serena l’uomo più che il bandito, saprà trarne altri ammaestramenti, i quali gli riveleranno quante leggere siano le cause che trascinano alla perdizione un’anima nata buona, e quanto facili siano i mezzi che potrebbero strapparnela.
Prima di dare la parola a Giovanni Tolu[1], infliggerò al lettore alcune pagine di storia sui banditi sardi in genere, e su quelli del Logudoro in ispecie.
Ho detto infliggere, ma devo dichiarare che la mia chiacchierata potrebbe omettersi, con vantaggio di chi legge... ed anche di chi scrive.
Sassari, maggio 1896.
Enrico Costa.
[11]
[13]


La storia del banditismo è vecchia quanto il mondo. Essa risale a Caino, e forse ai nostri primi padri.
Caino, dopo il fratricidio, esclamò: — Io, dunque, sarò vagabondo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi troverà mi darà la morte!
Adamo ed Eva, appena commesso il primo fallo, si affrettarono a coprirsi ed a nascondersi; e da quel giorno tutti i bambini, appena rompono qualche piatto in cucina, sentono il bisogno di scappare e d’intanarsi, sperando che i sospetti ricadano sulla serva di casa.
L’uomo non è altro che un bambino ingrandito.
La sete di sangue, che tormenta l’uomo, lo eccita alla pugna: — istinto feroce, che i selvaggi [14] manifestano apertamente, ma che i popoli civili hanno bisogno di mascherare col sentimento convenzionale d’una partita d’onore, e magari d’una guerra santa, in cui la forza e l’astuzia soverchiano quasi sempre la ragione, col tristo risultato di un offeso, che il più delle volte soccombe — e di un offensore, che riporta quasi sempre la palma della vittoria.
Fu in ogni tempo sentito il bisogno di sottrarsi al fastidio delle leggi per battere la campagna, dando prove di abilità e di valore, col togliere al prossimo la vita, e la borsa insieme.
Come i Crociati corsero entusiasti in Palestina per coprirsi di gloria e di blasoni; come i nostri mercanti logudoresi, per ottenere dai re di Spagna onori e feudi, uscivano armati dal paese ad espugnare i vecchi castelli, o per dar la caccia ai saraceni sulle spiaggie di Gallura, così non mancarono i baldi giovani, che si univano in masnade per cimentarsi in battaglie temerarie e sanguinose, solleticati unicamente dalla gloria vanitosa di diventar celebri.
Furono ugualmente in gran voga le delizie della pirateria. Inseguire e depredare un legno, per impadronirsi del bottino, fu creduto, in tempi non barbari, un diritto delle genti: — prova questa, che l’uomo ha gli istinti del tigre e della gazza, ed è nato ladro e feroce.
Quando nel 1651 il Vicerè cardinal Trivulzio — uomo sordido e avaro — dopo averne fatto [15] delle grosse in Sardegna, salpò dal porto di Alghero per restituirsi in Spagna, s’imbattè in alto mare in una nave straniera. Ordinò al capitano d’inseguirla; la raggiunse, la catturò, e s’impadronì senza rimorsi della fatta preda. Ed era un cardinale!
La rapina di mare, più tardi, cedette l’impero a quella di terra; e qui mi dispenso dal segnalare tutte le bravate dei masnadieri d’Europa, i quali svaligiavano eroicamente vetture, trucidavano passeggieri, e rapivano le belle per farne dono ai propri capitani innamorati
Leggesi nelle storie, che le masnade avventuriere destarono nei primi tempi un entusiasmo sì morboso, che molti giovani di distinta famiglia abbandonarono la casa paterna, allettati dalle gloriose gesta degli eroi del furto e dell’assassinio. L’ignoto li attraeva, perocchè il pericolo ha le sue seduzioni. L’uomo si accora quando è solo; ma nella vita collettiva irride alle avversità della sorte, attingendo in esse la forza e l’audacia. Gli artisti ed i poeti disgraziati, per poter sghignazzare sulle ingiustizie del mondo, non fondarono forse la Bohème?
Corsari e masnadieri, banditi e briganti ebbero il loro culto e il loro momento di celebrità, molto più che i menestrelli e i cavalieri erranti. In essi fu ammessa — insieme alla forza semi-irresistibile — una certa qual baldanza cavalleresca. Quei valorosi infiammarono siffattamente [16] la fantasia, e destarono sì intensa l’ammirazione, che i poeti e i musicisti si credettero in dovere di farne argomento dei loro canti, aggiungendo fuoco a fuoco.
Corrado, il corsaro di Byron; Carlo Moor, il masnadiero di Schiller; Ernani, il bandito di Victor Hugo; Fra Diavolo e Luigi Vampa, i briganti di Auber e di Dumas, per tacere di molti altri, strapparono pietose lagrime a migliaia di fanciulle, e invogliarono non pochi giovani a seguire i bellicosi ardimenti. L’uomo, trascinato dal magisterio dell’arte, prova assai spesso di queste singolari e nobili aspirazioni!
Le spoglie del vinto furono in ogni tempo considerate patrimonio legale del vincitore — e da ciò il furto e l’assassinio, in nome sempre del diritto.
Quanto poi al sentimento del farsi giustizia da sè, fu anch’esso ritenuto come un diritto naturale. A che pro, infatti, ricorrere ai tribunali? Vi ricorre forse la Nazione incivilita, quando credesi offesa nell’onore e nel suo diritto da un’emula rivale? La guerra è allora dichiarata santa, ed ogni religione benedice le proprie armi — forse per attutire il rimorso di qualche coscienza scrupolosa.
Ammesso il principio fondamentale, è chiaro come il soldato abbia il dovere di uccidere il fratello nemico, non solo colla coscienza di non essere un omicida, ma col diritto al plauso ed [17] alla gloria dei benemeriti vincitori. L’amor di patria giustifica ogni efferatezza; e se una differenza vi ha da essere fra la vendetta dell’uomo individuo e quella dell’uomo collettivo, non potrebbe essere che questa: — sul campo di battaglia noi uccidiamo a sangue freddo un uomo che non ci ha offeso, mentre nella vita privata, acciecati dall’ira o dal risentimento, uccidiamo sempre, a torto od a ragione, un uomo che ci ha leso nell’onore o negli averi. La società, però, la pensa altrimenti; e mentre al primo concede la medaglia al valore, prepara la forca al secondo. — Non vi sembra, per lo meno, che tutti e due dovrebbero aver torto, o ragione?
Ma il mondo è così fatto, e neanco il Creatore si darebbe oggi la briga di rifarlo. — Chi non lo sa? Il vecchio Dio incoraggiava le battaglie, mentre Gesù Cristo non fece che bandire la crociata della pace, predicando il perdono ai nemici. Pare dunque che il babbo avesse più esperienza e più buon senso del figlio, poichè i popoli tennero per lui, e trascurarono il nuovo testamento per attenersi alle clausole del vecchio.
La Nazione istituisce i tribunali per il bene dei popoli, ma viceversa essa non se ne serve, poichè preferisce la forza alla ragione e non si fida della Giustizia. Gli antichi signorotti si circondavano di bravi, e li mantenevano per farsi rispettare: sempre per quel principio intangibile, che il torto è del debole, e la ragione del più forte.
[18]
Chi non lo vede? la guerra è un bisogno; anzi, dobbiamo ammetterla come un istinto, se la scienza e la civiltà non sono ancora riuscite ad abolirla.
D’altra parte (ragionando sul serio) noi dobbiamo lealmente riconoscere, che tutti i malanni, le passioni, i pregiudizi ci vennero unicamente concessi per poter sbarcare il lunario della vita. Se gli uomini mai non peccassero, se fossero tutti concordi, tutti galantuomini, tutti santi, come camperebbero i preti, i giudici, gli avvocati? — Se vi fosse una verità assoluta, indiscutibile, dove andrebbero a finire le diverse opinioni che dànno vita e colore a un mondo di uomini politici e di giornalisti? — Se, infine, si vivesse sempre in pace coi propri fratelli, contento ciascuno del proprio lembo di terra, a che servirebbero gli eserciti permanenti, e in che s’impiegherebbero migliaia di giovani?
Dobbiamo dunque ammettere, che le imperfezioni del corpo, dello spirito e dell’umano intelletto non servono che a dare il pane quotidiano alla metà dei viventi: la quale campa alle spalle dell’altra metà, creando le disuguaglianze, le lotte e le diverse opinioni, perno dell’equilibrio sociale. Possiamo conchiudere: che un mondo di gente savia finirebbe col morir di fame e di noia!
Queste saranno forse stramberie; ma come faremo a pensarla altrimenti, quando nei casi pratici della vita noi vediamo il moralista filosofo, [19] che fa proprio il contrario di ciò che va predicando? — quando per ogni dove non c’imbattiamo che in tartufi politici, in tartufi religiosi, in tartufi domestici, in tartufi scienziati, industriali, mercanti? È cosa ormai assodata, che la più grande soddisfazione di colui che predica e scrive contro la vanità e le frivolezze umane, è unicamente riposta nella frivolezza e nella vanità di credere, che il mondo gli dica bravo! — Noi non diventiamo ricchi, dotti, saggi ed onesti, che a spese dell’altrui miseria, dell’altrui ignoranza, dell’altrui credulità, dell’altrui dabbenaggine.
Fermiamoci ora, per poco, sull’indomabile sentimento che ci trascina, nostro malgrado, ad ammirare quanto d’orrido e di truce esce fuori dalla cerchia dei fatti comuni e delle abitudini quotidiane.
Perchè negarlo? La belva ci tenta e il sangue ci ubbriaca. Il valore, la temerità, l’astuzia, in tutte le loro manifestazioni, buone o cattive, esercitano sul nostro cervello un fascino morboso, inesplicabile.
Entriamo in un circo antico. Dinanzi al gladiatore valoroso, anche la donna si esalta, e depone per un istante l’innato sentimento della pietà. Tutta palpitante, battendo le mani al vincitore, ella, col pollice verso, lo incita a squarciare le viscere del vinto che fu atterrato. Le figlie di Eva, così deboli e così timide, amano di preferenza i forti e gli audaci; esse magari [20] svengono dinanzi ad un salasso, ma offrono il cuore e la mano all’eroe di un torneo, che torna vincitore col brando insanguinato.
La ferocia, valorosa o temeraria, e con essa tutte le scene di sangue, esercitano sull’animo umano un’attrattiva che si subisce e non si discute: c’è in esse un fondo d’ipnotismo, o di suggestione. Non per nulla lo spettacolo di un’esecuzione capitale (che i Governi credettero, scioccamente, salutare esempio) attrasse in ogni tempo una folla di curiosi sotto ai patiboli. Nelle fredde notti invernali, mentre al di fuori urla la tempesta, noi vediamo le famiglie popolane raccogliersi intorno al focolare domestico, per ascoltare con curiosità paurosa le storie dei morti e dei feroci briganti. Il fantastico e il sovranaturale furono per parecchi secoli il tema prediletto degli artisti e dei poeti.
Chi mai, avendone l’occasione, non ha tentato di vedere da vicino un famoso bandito, un truce assassino, una belva feroce?
Una brava e gentile artista milanese, venuta lo scorso anno a Sassari, implorò dal prefetto la grazia di poter visitare le carceri, unicamente per vedervi il feroce bandito Derosas e il suo compagno Angius. — So che fu soddisfatta nel suo desiderio, ma non so quale gradevole impressione abbia potuto riportarne!
Questo turbine d’idee bislacche e di anomalie paradossali si scatenò sul mio cervello, mentre [21] andavo spigolando le gesta brigantesche del continente europeo, e più ancora delle isole, dove i banditi hanno sempre allignato in numero maggiore.
***
Sospendo le malinconiche meditazioni, per riportare alcune note storiche sui malviventi, sulle squadriglie e sui banditi principali del Logudoro (o meglio del Capo di Sassari) che ho riassunto in gran parte da documenti ufficiali, da me consultati nel R. Archivio di Stato.
Nel Codice della Repubblica sassarese, del 1316, è cenno dei banditi che si davano alla macchia; e mentre si esorta qualunque persona ad ucciderli, si infliggono pene rigorose contro chi dava loro consiglio ed aiuto.
Pene pecuniarie infligge anche la Carta de Logu (promulgata nel 1395 da Eleonora d’Arborea) contro ai villaggi ed alle persone che davano aiuto e consigli ai banditi, o che non si adoperavano a dar loro la caccia.
Il secolo XV non fu avaro di celebri masnadieri. Ne noto uno a caso — Verso il 1422 si ha menzione di certo Barzolo Magno (o Manno, secondo alcuni storici) — il famoso leggendario e misterioso logudorese, nemico giurato di Leonardo Cubello marchese di Oristano, non si sa per qual ragione. A capo di numerosa masnada, [22] questo gentiluomo bandito, o bandito gentiluomo, si era annidato ed afforzato dentro al famoso castello di Burgos; e di là scendeva di tanto in tanto per devastare e saccheggiare le terre dei dintorni. Il marchese riuscì ad assediarlo dentro l’inespugnabile rocca; ma i masnadieri, compagni del Magno, vedendo il loro capo risoluto a resistere, fecero complotto, e lo trucidarono barbaramente per ottenere grazia dal signore d’Oristano.
Come nel medioevo i Principi fabbricavano sontuose chiese e numerosi santuari in remissione dei propri peccati (e ne avevano di grossi sulla coscienza!) così più tardi gli stessi prìncipi condonavano ai sudditi fedeli molti delitti, mediante il corrispettivo sborso di poche centinaia di lire. Dal 1450 al 1540 sono molte le somme versate nelle casse del Regio erario per condono di ribalderie. Per citarne un esempio, dirò che il Governatore del Capo di Cagliari e Gallura (Don Giacomo Aragat) nel 1456, per tremila Ducati buoni veneziani, condonava a Bartolomeo Manno, cavaliere sassarese, tutti i delitti che avesse mai potuto commettere.
Erano questi i bei tempi in cui i monarchi rifornivano le casse dello Stato colla vendita della nobiltà e colla remissione dei delitti. Non essendo a quel tempo inventati gli esattori, si ricorreva al mezzo di sfruttare i vanagloriosi ed i birbanti, che pare fossero in numero ragguardevole.
Dal 1560 al 1567 si verificarono molte ribalderie [23] nella città di Sassari e dintorni. Vennero carcerati un buon numero di cittadini facoltosi, accusati di aver formato una società di mutua assistenza, con impegno di fornire i fondi in comune per far fronte alle spese di giustizia, in favore e difesa dei ribaldi.
Il secolo seguente non fu meno famoso per scorrerie di ribaldi, poichè l’invenzione del fucile aveva reso più attraente e più geniale il banditismo.
Nel 1600 gli odî privati e le vendette giungono a tanto, che i consiglieri di Sassari rinunziano alla gita notturna del Mezz’agosto, per il numero infinito delle uccisioni fra i cittadini. L’anno 1607 registrò più di trecento omicidi, consumati nel solo Logudoro.
Nel 1612 il famigerato bandito Manuele Fiore si aggira colla sua masnada nei dintorni di Sassari, e getta lo sgomento fra i cittadini. Il Governo manda incontro a quei ribaldi alcune compagnie di militi, divise in centurie.
Don Diego Manca di Sassari, nel 1635, si era dato alla macchia dopo aver ucciso pubblicamente, in una piazza della città, il proprio cognato con un colpo di pistola ed una pugnalata. Temendo che ne facesse delle più grosse, il Vicerè promise venti scudi (?) a chi consegnava quel bandito alla giustizia. L’esiguo prezzo concesso, dimostra che i cacciatori di malviventi erano in buon numero!
[24]
Molti cavalieri e cittadini facoltosi del Logudoro vennero designati come protettori dei banditi; e il Vicerè, nel 1645, li chiamò a Cagliari per dar loro una paternale.
Nel 1659 abbiamo il terribile bandito Salvatore Anchita e il suo acerrimo nemico, pur bandito, Francesco Brundanu, entrambi di Sedini. La storia del primo è una vera leggenda di prodezze, di ferocie e di generosità insieme. Inseguito il Brundanu dai soldati, sfugge ad essi cacciandosi in una spelonca, dove fra gli altri banditi trova per caso il suo nemico Anchita. Egli depone l’arma e grida: — Sono in tuo potere: puoi uccidermi! — «Non sono così vile! — gli risponde Anchita — qui sei l’ospite mio. Per ora faremo causa comune contro ai soldati — più tardi aggiusteremo i conti fra noi!»
I banditi si slanciarono tutti contro le soldatesche, ma l’Anchita e il Brundanu caddero fulminati nella mischia.
Tre anni dopo — nel 1662 — un altro terribile bandito, famoso per le sue gesta, sgomenta il Logudoro: Giovanni Galluresu, capo di potente squadriglia. I sassaresi chiudono spaventati le porte, nè osano uscire di casa quando lo sanno nei dintorni. Il Vicerè, volendo distruggere quella banda, prende un’estrema risoluzione. Egli prescrive con un editto il disarmo generale nel Logudoro, con pena capitale al detentore d’un fucile o di un pugnale. Misura puerile, che ottenne il [25] risultato opposto: accrebbe l’audacia dei malfattori e rese più facile la distruzione dei galantuomini, che vennero spogliati ed uccisi, perchè inermi. La forza non riuscì ad impadronirsi del Galluresu, e si ricorse allora all’astuzia. Saputo che il bandito era in relazione amorosa con una bella osilese, fu colto ed ucciso nel suo nido d’amore. Indispettita la giustizia per non averlo vivo, si sfogò sul cadavere, di cui fece uno scempio.
Verso il 1665 le squadriglie dei banditi crescevano — e ve n’erano di tutte le condizioni sociali. Il Governo incaricò il barone Matteo Pilo Boyl della distruzione dei facinorosi; ed egli ne fece appiccare da per tutto, alle forche ed agli alberi. Fra i capi squadriglia di quel tempo, noto Don Giacomo Alivesi, datosi alla macchia dopo un omicidio commesso. Nel giugno del 1668 veniva intanto assassinato a Cagliari il marchese di Laconi; ed i supposti rei (l’infelice marchese di Cea, Don Silvestro Aymerich, Don Francesco Cao e Don Francesco Portugues) si erano rifugiati nel continente italiano od all’estero. Per impadronirsi di costoro il Governo si era rivolto al bandito Don Alivesi, a cui venne promessa l’impunità ed un premio, ove fosse riuscito ad attirare i fuggiaschi in Sardegna. L’Alivesi accettò; fu creato Commissario della spedizione; chiese ed ottenne l’anticipazione di duecento sessanta scudi per le spese di viaggio; si recò a Roma; e fingendosi colà amico del Cao, con raggiri [26] riuscì a trascinare i quattro esuli all’isoletta Rossa, presso Castelsardo. Tre di essi furono colà sgozzati a tradimento; ed il vecchio marchese di Cea fu condotto a piedi fino a Cagliari, e dato in mano al carnefice. Il nobile Alivesi — dopo aver compiuto il più nero tradimento che abbia macchiata la storia sarda — non solo fu graziato, ma venne dal Governo investito dei feudi dell’infelice marchese.
Era allora in vigore presso il Governo (e lo fu per lunghissimo tempo, fino ai giorni nostri) il sistema di promettere l’impunità ai più volgari malfattori, purchè uccidessero, o consegnassero alla giustizia un delinquente, meritevole di uguale, o di maggior pena. Anche i Governi si mostravano entusiasti dei valorosi briganti, e ne incoraggiavano le gesta!
Tutta la seconda metà di quel secolo, ed il primo ventennio del seguente non furono inferiori al secolo XVIII per audaci banditi, squadriglie numerose, furti, omicidi, impiccagioni, e impunità concesse dal Governo agli assassini traditori.
***
Uscita di Sardegna nel 1720 dal regime di Spagna, ed entrata sotto il dominio di Casa Savoia, continuarono le prodezze dei banditi e delle squadriglie agguerrite. Il Logudoro e la Nurra erano infestati di malviventi. I banditi, protetti [27] dai parenti e dagli uomini più autorevoli dei villaggi, ne facevano delle grosse, e gettavano lo sgomento per ogni dove. Si pubblicarono rigorosi Pregoni, ma inutilmente.
Il Vicerè Di Costanze si lagna della corruzione dei giudici di Sassari, ed accenna a denaro depositato presso un notaio, per compensare quei magistrati che avessero diminuito la pena a certi fratelli Virdis di Pattada. Egli ammonisce con minaccie i nobili e i magnati dei paesi, perchè desistessero dal proteggere i birboni — ma era un parlare al vento. I baroni, piccati, protessero i banditi che cercavano rifugio nelle loro terre feudali, e protestarono altamente contro l’arbitrio!
Fin dal maggio del 1722 il Vicerè aveva mandato distaccamenti di truppe in giro per i villaggi, con lo scopo di reprimervi il banditismo invadente, raccomandando al Governatore di Sassari, di prestare ai soldati il carnefice e due aguzzini!
Anche l’autorità ecclesiastica (lo rilevo dai Regi Dispacci) era chiamata prepotente in modo straordinario; essa ordinava arresti a suo talento, e sottraeva al braccio secolare i malfattori favoriti, designandoli quali chierici o tonsurati. Si deplorava la protezione scandalosa accordata sfacciatamente ai malviventi dal popolo, dai prelati, dai feudatari, ed anche dai giudici e dagli avvocati fiscali(!)
Impressionato dall’aumento dei delitti in Sassari [28] e nel Logudoro, il Vicerè, nel 1726, chiamò d’urgenza a Cagliari il Governatore Cav. Carlino; ma questi ricusò di andarvi, dicendo d’esser stato colto dalla gotta!
Come abbiamo veduto, non erano i soli popolani che facevano le prove di valore in campagna sotto il nome di banditi: non mancavano i titolati, poichè (lo ripeto) fare il masnadiero non era un disonore in Europa, anzi lo si riteneva un mestiere nobile e avventuroso, come quello del cavaliere errante; motivo per cui, se trattavasi di masnadieri nobili, le protezioni venivano dall’alto. Ho sott’occhio una lettera del re Carlo Emanuele III, scritta da Torino l’8 dicembre 1733 al Vicerè di Cagliari. In essa leggesi:
«... Riguardo al capo bandito Don Girolamo Delitala, raccomandato dal cardinale Alessandro Alboni(!), approviamo la grazia delle pene incorse, a condizione che il Delitala si porti a Cagliari per l’arresto, presti fidanza di mille scudi, conduca seco in ostaggio uno de’ suoi figliuoli o un aderente, e paghi le spese.»
È chiaro che lo si voleva portar via da Sassari per evitare lo scandalo, poichè ai nobili banditi un po’ di grazia la si accordava sempre. Dopo tutto, la nobiltà veniva venduta dal Governo, e qualche cosa doveva fruttare agli acquisitori!
Le bande dei malviventi si moltiplicarono in Sardegna, e specialmente nel Logudoro, ricco di [29] montagne e di sicuri nascondigli. Centro principale dei facinorosi era allora Nulvi, dove la famiglia Delitala, nemica al governo di Casa Savoia, aveva armato i popolani, eccitandoli a parteggiare. Una Donna Lucia Tedde Delitala, montata in arcione, e armata di fucile e stocco, con ardimento virile usciva in campagna per affrontare i nemici.
Il Vicerè Rivarolo, mandato in Sardegna nel 1735, si diede a sterminare con zelo i numerosi malfattori, e riuscì ad impiccarne molti, piantando le forche (per il buon esempio) sul luogo del commesso delitto. Ma i banditi continuavano a moltiplicarsi, facendo a gara per sorpassare in destrezza e in valore i soldati regi. Per cinque anni Rivarolo non si adoperò che a far allontanare dall’isola i vagabondi cattivi, esortando i buoni ad arruolarsi nel Reggimento sardo. Procedette egli con tanto rigore, che qualche innocente fu impiccato, e lo storico Manno gliene muove aspro rimprovero.
Sgomentato il re dal cieco furore del suo Rappresentante in Sardegna, gli ordinò di frenarsi e di usare maggior cautela; ma il Vicerè, soddisfatto dell’opera propria, nel 1736 fece un giro nell’isola, per riscuotere il plauso di tutti i villaggi.
Venuto a Sassari egli si preoccupò della Nurra, regione montuosa e marittima, che offriva sicuro rifugio ai numerosi banditi di Alghero e [30] di Sassari. Il Rivarolo ordinava a quei pastori di snidare dal centro della Nurra nel termine di quindici giorni, per trasferirsi alla parte piana, verso la strada che conduceva a Portotorres.
Il bandito più in voga era a quei tempi Leonardo Marceddu, di Pozzomaggiore, per il quale si era fatto un bando il 20 febbraio 1736. Sul conto di costui, però, correva una storia pietosa, che attenuava le sue ribalderie. Egli ebbe fama di laborioso e di onestissimo; ma la infedeltà della sposa lo precipitò nel delitto. Colta la moglie in colloquio intimo con un suo cugino, li uccise entrambi; e, datosi alla macchia, egli divenne singolare per coraggio, per ferocia, e per accortezza nel cimentarsi coi soldati regi. Fu siffattamente apprezzato, che finì per mantener pratiche segrete con alcuni agenti politici, poichè il Governo lo considerava come un forte cooperatore nel caso di un’invasione straniera: — sempre per quel certo sistema di servirsi dei banditi d’ogni genere, anche a scopo d’una difesa nazionale. Un esempio consimile lo si ebbe più tardi nel leggendario Fra Diavolo di Napoli, invitato a prender parte ad una guerra contro la Francia.
Continuarono intanto le caccie e gli scontri fra banditi e soldati. Il 16 gennaio 1758 il ministro scriveva al Vicerè: «— S. M. ha gradito l’incidente seguito a Bolotana fra le truppe e i malviventi; bisogna procurare l’arresto dei banditi rifugiati in Corsica, ed ora ritornati nell’isola, fra [31] cui Giovanni Fais, Don Antonio Delitala e i tre fratelli Filia Madau, capi dei medesimi. S. M. ha pure approvato la gratificazione di scudi venticinque accordati a Basilio Podeddu, che serviva di guida e spia e rimase ferito nell’azione. — (Il sistema perdurava!)
I nobili, nonpertanto, e molti rispettabili dei paesi, continuavano a favorire i malfattori erranti; e da Torino si scrive al Vicerè il 22 ottobre 1761: «— Prenda informazione sulla protezione accordata ai facinorosi dai cavalieri Quesada: metta una volta freno all’insolente ardore di tali protettori col punirli severamente, tagliando il filo delle corrispondenze coi malviventi.»
Ma le protezioni non venivano meno, come non vennero meno i delitti consumati anche in odio agli ecclesiastici. Il ministero, nel 1769, si preoccupava dell’assassinio di due preti strangolati a Mandas ed a Nulvi, nonchè del Diacono ucciso da un altro prete a Calangianus, in una partita di caccia, quasi per scherzo.
Da oltre un trentennio la fama delle audacie di Giovanni Fais correva da un capo all’altro dell’isola. Questo fiero bandito, per molto tempo, ebbe al fianco la propria moglie, donna di maschio coraggio, che lo aiutava ad assalire i nemici. Erano suoi alleati i Delitala di Nulvi, nonchè quella famosa Donna Lucia, da me altrove menzionata — per difendere la quale il Fais andò [32] incontro ad una forte fazione di Chiaramonti. Costui, saputo che Giammaria Tedde (pur congiunto di Lucia) aveva minacciato la sua protetta, gli tolse senz’altro la vita. Lo zio ed i parenti dell’ucciso, assetati di vendetta, giurarono allora lo sterminio dell’uccisore e de’ suoi compagni. Ma Giovanni Fais, guidatore esperto delle sue bande, taglieggiatore dei comuni, e assalitore di truppe, oppose la forza alla forza, e sfuggì al furore dei persecutori.
Non appena il Vicerè ebbe sentore dell’odio che il Tedde nutriva per il Fais, pensò di trarne partito. Egli incoraggiò il primo a persistere nella caccia contro il secondo, suggerendogli di servirsi dell’opera del bandito Leonardo Marceddu, a cui il Governo avrebbe concessa l’impunità ed un premio in danaro. Leonardo Marceddu, però, uomo di fiero carattere, mandò a dire al Vicerè che sdegnava la libertà a prezzo di un tradimento; e fatta lega col Fais continuò a seminare il terrore nel Logudoro.
Duemila miliziani, condotti da Girolamo Dettori di Pattada e da Don Giovanni Valentino di Tempio, oltre ai quattrocento soldati comandati dal Cav. Meyer, tentarono con energia la distruzione di queste bande. Il Valentino riuscì ad arrestarne oltre duecento, per cui il re lo creò cavaliere.
Accortisi i banditi della caccia ad oltranza che lor dava il Governo, fecero causa comune. [33] Il Marceddu recossi al Sasso di Chiaramonti per unirsi al Fais, che vi si era rifugiato coi compagni. Sbaragliati dall’attacco incessante che lor davano le numerose milizie, sulle prime si accamparono sul monte Cucaro, poi una buona parte (fra cui il Fais coi Delitala) si salvarono in Corsica.
L’infelice e generoso Marceddu, che aveva rifiutato dal Governo la libertà a prezzo d’infamia, finì per cadere nelle mani d’un bandito traditore: di Francesco Bazzone, che lo aveva venduto allo stesso Governo, in cambio dell’impunità e di una ricompensa in danaro.
Donna Lucia Delitala, raggiunta l’età di quarant’anni, pare che avesse messo giudizio. Tratta in arresto, fu in seguito graziata, dopo due anni di prigionia. In una lettera del Vicerè, marchese Rivarolo, al re Carlo Emanuele (1738) è detto: «... Donna Lucia è una donna qui n’à pas voulu se marier pour ne point dépendre de un homme (à ce qu’elle disait).» Chiude dicendo, che, dopo la grazia, «elle vit assez tranquille.»
Nel 1749 i banditi parvero dispersi e le spedizioni militari ebbero tregua.
Dopo una quindicina d’anni il Fais tornò dalla Corsica; e verso il 1760, formata una banda di buoni compagni, si diede a scorrazzare di nuovo nei dintorni di Sassari, quasi per insultarvi il Governatore. Un amico di quest’ultimo, tradendo il Governo, avvertiva segretamente l’ormai vecchio bandito, divenuto più audace di prima. Si assicura [34] che il Fais (mascherato da cappuccino, con la bisaccia in spalla) avesse osato più volte introdursi in Sassari, e presentarsi alla questua in casa dell’assessore Aragonese. Egli divenne talmente in odio al Governo, che lo si escluse dall’indulto promulgato il 23 agosto 1768.
Dopo non pochi tentativi riusciti vani, finalmente il Governatore Allì Maccarani riuscì a sedurre, con la solita promessa di libertà e danaro, due banditi sassaresi, i quali propinarono al Fais un vino oppiato. Quando videro il vecchio immerso nel sonno, lo uccisero a colpi di scure e lo consegnarono cadavere al carnefice. Ciò nel 1774.
Giovanni Fais era allora più che settantenne, e faceva il bandito da oltre mezzo secolo. Contava solo quindici anni, quando verso il 1720 si era dato alla macchia, dopo aver ucciso un uomo sulla pubblica piazza di Chiaramonti.
A complemento della notizia della sua morte, riporterò un brano della lettera che il ministro scriveva da Torino al Vicerè, in data del 23 novembre 1774:
«S. M. il re gradì che il Governatore di Sassari sia riuscito a disfarsi del vecchio Giovanni Fais e dei sette suoi compagni di quadriglia, annidati nel Sasso di Chiaramonti, sperando cogliere i due scampati colla fuga. Poichè intanto si poterono conoscere gli uccisi, è stato opportuno che a pubblico esempio si siano tosto fatti [35] appendere al patibolo i cadaveri dei già condannati, colla successiva dispersione delle membra, nei luoghi dei rispettivi delitti. — S. M., oltre alla grazia ai due banditi che concorsero nell’impresa, vuol rimunerare gli altri, e invita a proporre la somma a darsi; vuole anche che gli si suggerisca qual riguardo meritano i due cavalieri Corda, che ebbero parte principale nell’operazione.».
I lettori avranno notato, come per l’esempio pubblico si ordinava anche l’impiccagione dei cadaveri, i quali in seguito venivano squartati e dati alle fiamme, per sperderne le ceneri al vento. Nè ciò deve recar meraviglia, poichè vi ha di peggio. Leggo una corrispondenza del Ministro (5 settembre 1770) in cui si parla del cadavere imbalsamato di un bandito famoso, tenuto a disposizione del Governo per qualche esemplarità. Quando, dunque, si volevano atterrire i malviventi, si conduceva alla forca quel cadavere imbalsamato e lo s’impiccava. E Dio sa quante volte gli avranno messo la corda al collo!
È facile immaginare come per l’eccessivo rigore dei giudici venissero sagrificati molti innocenti, tratti in arresto per le false deposizioni dei nemici; e lo prova una lettera ministeriale del 23 ottobre 1765, in cui si dice al Vicerè: «— Prenda energiche misure sui testi falsi, massime in codesto Regno, dove havvi tanta facilità e frequenza di delinquere in tale materia.»
[36]
Alle false testimonianze bisogna aggiungere il sistema della tortura, allora in pieno vigore, e conservata fino al 1827, anno in cui Carlo Felice l’aboliva. Il dolore per lo slogamento delle ossa riusciva a far strappare dal labbro dei pazienti tutte le confessioni che si volevano.
Scene edificanti, in secoli che si dicevano dell’oro!
Se in quei tempi esistevano i favoreggiatori dei banditi, non mancavano pure i cittadini benemeriti, che si adoperavano con ardore per dare i rei in mano alla giustizia; ma non tutti riuscivano nell’intento come i due fratelli Corda.
Nel 1773 l’avvocato Giovanni Berlinguer veniva fatto segno (come i suoi antenati) a speciale benemerenza, per il zelo spiegato nella persecuzione dei banditi, dai quali era stato più volte ferito. Gliene colse però danno; poichè tre anni dopo, nel gennaio del 1776 (come rilevo da una lettera ufficiale) gli venne ucciso in campagna l’unico figlio Girolamo, con trentatre stoccate. L’assassino — certo Antonio Capponi — fu arrestato e impiccato.
Dopo il ritiro del ministro Bogino (il persecutore dei malviventi) i banditi tornarono a formar bande per darsi alle piacevoli scorrerie. Il Vicerè Thaon, nel 1788, bandì loro una guerra atroce, e tenne duro, quantunque venisse biasimato acerbamente per aver violato le forme legali.
Nel gennaio del 1782 veniva promessa la [37] impunità ai due banditi fratelli Mucciga (complicati nella famosa sommossa popolare del 1780) a condizione che avessero arrestato ed ucciso altri malandrini. Nella lettera ministeriale leggo queste precise parole: «— bisogna animare (!) i banditi a distruggersi fra loro.» — Era massima fondamentale dei governi di tutti i secoli, compreso il nostro. Chi non lo sa? chiodo scaccia chiodo.
Nè crediate che i banditi d’allora fossero tutti sardi; la Corsica ne dava un buon contingente, poichè ne vantava a centinaia sulle spiaggie della Gallura, come dalla Gallura molti ne emigravano sulle spiaggie corse. Le due isole si aiutavano a vicenda. Nel dicembre dello stesso anno (1782) l’ambasciatore di Francia pregava il Vicerè di Sardegna (per il bene comune delle due nazioni) di procurare l’estradizione di dodici banditi corsi, che scorrazzavano intorno a Castelsardo. E ne dava i nomi: Giovanni Saverio, Girolamo Ranfioni, Bonelli, Labicone, Leonati detto il nero, i tre fratelli Volpi, e i quattro fratelli Giovannoni. Pare che in Corsica si dessero alla macchia intere famiglie!
Veniamo intanto allo strascico della rivoluzione dell’Ottantanove, ed ai torbidi che seguirono in Sardegna negli ultimi del secolo: periodo turbolento, al quale non furono estranei i banditi.
Nel pregone emanato dal Vicerè Vivalda il 9 giugno 1796, ponendo a prezzo la testa di Angioi [38] e suoi complici, oltre ai premi in danaro, si prometteva la nomina a favore di qualunque delinquente si volesse graziare!! — E così pure, quando pochi giorni dopo si mossero da Cagliari i 2500 armati per combattere l’Angioi ad Oristano, ci dice lo storico, che in quella milizia furono reclutati delinquenti volgari, tolti alla macchia. In una memoria del 5 marzo 1797 (sottoscritta da Ghisu, Pintor e Delrio) si legge: «— Bisognava graziare gli inquisiti che servivano in tutte le spedizioni; poichè alla loro intrepidezza e coraggio si deve pure attribuire la buona riuscita dei più ardui e pericolosi incontri —» — Queste frasi rivelano i tempi e la moralità del Governo; il quale traeva partito dal coraggio e dall’intrepidezza di codesta brava gente, in seno alla quale sceglieva i suoi sicari! — Anche per l’arresto del parroco Murroni e di suo fratello (ardenti angioini datisi alla fuga) il giudice Valentino, nel novembre del 1797, suggeriva al Vicerè di servirsi dei due banditi Salvatore Rugu e Bantine Addis, a cui pertanto poteva concedersi un affidamento interinale, e in seguito l’impunità dopo la cattura.
E qui chiudo le gesta dei banditi e dei malviventi del secolo XVIII.
Qualche partigiano del regime spagnuolo si era lasciato forse scappare, che i misfatti risultassero assai più scandalosi sotto il dominio piemontese, che sotto quello di Spagna.
[39]
Il Governo del Piemonte si sentì punto da quest’asserzione; e lo desumo dalle seguenti linee, che leggo in una lettera del Ministro al Vicerè, in data 28 luglio 1790:
«Non siamo in Sardegna nelle circostanze rappresentate al Papa dai re di Spagna per la Catalogna, cioè, che frequentissimi fossero i più atroci misfatti, e pochi ne succedevano in cui preti e frati non fossero almeno complici — e quasi tutti andavano impuniti per la negligenza o connivenza dei Vescovi e dei Superiori regolari». — E scusate se è poco!
***
Diamo ora uno sguardo al secolo spirante — al nostro secolo — non inferiore forse al precedente per furti, delitti e scorrerie di malandrini.
Nei primi anni del secolo XIX si ebbe lo strascico dei moti angioini. Si perseguitavano a morte i liberali d’allora, e fra questi il povero notaio Cilocco, che inseguito dalle truppe batteva da più anni la campagna gallurese, sfuggendo ai persecutori da montagna in montagna. Il Marchese di Villamarina scriveva da Tempio al Vicerè (15 giugno 1802) ch’era sua intenzione di servirsi di spie pagate per far guerra ai repubblicani, sebbene difficilissimo sia trovarne fedeli in questo comune.
Il Cilocco potè sfuggire alle armi regie, ma [40] cadde in trappola col solito tradimento. Stanco, oppresso, affamato, il poveretto si presentò un giorno al bandito Giovanni Mazzoneddu, chiedendogli asilo ed un tozzo di pane in nome dell’ospitalità. Il bandito finse di soccorrerlo, ma informò segretamente il Governo, dicendo d’essere pronto a consegnare alla giustizia l’ardente notaio, in compenso dello sborso della somma stabilita nella taglia, e dell’impunità per sè e per altri quattordici malvagi, di cui pensava servirsi per arrestarlo. Il Governo fu ben lieto di poter graziare quindici assassini di strada, per aver la testa d’un infelice notaio, di non altro reo, che di aver caldeggiato le idee repubblicane di Don Giammaria Angioi. Venne concesso quanto il Mazzoneddu chiedeva, e Francesco Cilocco fu tenagliato col ferro rovente, e trascinato a braccio fin sopra il patibolo l’11 agosto del 1802.
I banditi e i malandrini si moltiplicarono, e crebbero d’audacia, perchè protetti dai signori e dai monaci. Il 21 gennaio 1806 il governatore si lagna col Vicerè della scandalosa protezione che i conventi tutti di Sassari, specialmente quello dei frati carmelitani, accordavano ai malviventi; e gli annunziava intanto l’arresto del famigerato bandito Fanis, detto la frina, che da lungo tempo era ricoverato nel convento di Santa Maria.
L’Italia tutta, e specialmente la meridionale, non era in quel tempo in migliori condizioni della Sardegna. In quell’anno stesso, 1806, veniva trascinato [41] al patibolo Michele Pozza di Napoli, il famigerato bandito, che, sotto il nome di Fra Diavolo aveva attirato l’attenzione dell’Europa, destando l’estro d’Auber, il celebre musicista francese.
Quando il re Vittorio Emanuele I si mosse da Cagliari per fare un’escursione per l’isola, fu vivamente impressionato dalle numerose bande di malviventi che scorazzavano per ogni dove, e più ancora della protezione che loro davano i magnati delle ville, i quali giunsero persino a scarcerare gli arrestati nei loro feudi. Il re emanò un decreto rigoroso, e comminò la pena di morte ai protettori di banditi, colla perdita della nobiltà; nè dimenticò allo stesso tempo di promettere l’impunità agli assassini che avessero ucciso i propri compagni. Ma nondimeno crebbero i banditi, e crebbero le protezioni.
Nel 1809 è impossibile registrare i misfatti, tanto sono numerosi. Lotte sanguinose fra comuni e comuni, tra famiglie e famiglie, fra pastori e pastori; pene economiche, impiccagioni continue, arresti di prepotenti magnati. Il Martini ne fa un quadro orroroso. A Tempio, nel 1811, gli odî di parte raggiungono il parossismo. Si volle dare dagli audaci una lezione alla giustizia; e vennero assassinati, quasi allo stesso tempo, il Censore Diocesano, il Procuratore fiscale della pretura, e il Giurisdicente. Un indulto e una spedizione di soldati, per opera del Governatore di [42] Sassari, calmarono alquanto gli animi. Per intromissione del clero e del popolo si fecero le paci, le quali vennero rogate con atto notarile il 9 di maggio del 1813. Il re, costretto dalle circostanze, chinò la testa e firmò la grazia.
I delitti, nondimeno, ripresero il loro corso fino al 1817; ma furono in gran parte frenati dal rigore memorabile del Villamarina, sebbene egli abbia voluto favorire i propri compatriotti. Fu notato dagli storici, che, durante il suo governo, non venne impiccato alcun gallurese.
Dal 1820 — e più ancora dopo il 1826, anno in cui fu abolita la tortura e tracciata in gran parte la strada nazionale da Cagliari a Sassari — le squadriglie dei malviventi parvero meno feroci nelle loro gesta.
Durante il lungo periodo in cui Lamarmora percorse l’isola da un capo all’altro per i suoi studi prediletti, egli non venne molestato da masnade di ladri e di assassini. L’unico suo incontro coi banditi (avvenuto nell’aprile del 1823, sulla strada fra Nuoro e Siniscola) lo resero convinto che le masnade non erano ingorde di rapina, poichè rispettarono l’oro che portava seco — come lui stesso racconta.
Tuttavia la guerra ai malviventi fu continuata con ardore dal Governo; nè mancarono valorosi cittadini che si distinsero nel perseguitarli. Nel Gennaio del 1836, per il valore spiegato nella caccia dei banditi, fu data una medaglia d’oro [43] (dono del Sovrano) a Don Girolamo Berlinguer, capitano dei Barracelli.
Salì in fama a quei tempi il bonorvese Peppe Bonu, uno dei più popolari banditi dell’isola, e sul quale correvano bizzarre leggende. La generosità, unita al coraggio e alla destrezza, aveva fatto di costui un semi-eroe. Temerario all’eccesso e di una forza erculea, egli dava molto da pensare alle regie milizie; e non potendo il Governo impadronirsene per mezzo delle armi, pensò ricorrere al solito premio in danaro ed alla impunità: il premio in danaro da sborsarsi per intero a chi dava vivo o morto il Bonu, e per metà a colui che avrebbe ucciso qualcuno della sua banda; l’impunità (meno male!) ragguagliata questa volta a un delitto punibile con venti anni di galera.
Peppe Bonu non era un malfattore volgare; fu accertato che molti delitti si mantellavano col suo nome; e il bandito ne fu così sdegnato, che si decise a scortare in persona la diligenza nel transito di Campeda, per tutelare la vita e gli averi dei viaggiatori, temendo che altri in suo nome li assalisse.
Da pochi mesi era emanato il decreto della taglia sulla testa del bandito bonorvese, quando verso il 1838 circolò la notizia della sua morte. Mentre Peppe Bonu, nel Pianu de murtas, dormiva placidamente sotto un albero, venne ucciso a tradimento da un tal Rosas, della fazione dei Piu, suoi nemici.
[44]
Altro bandito di quei tempi, coraggioso e temuto, era il bonorvese Giovanni Biosa; il quale ebbe l’audacia di strappare il proprio padre (pur bandito) dalle mani dei carabinieri che lo avevano arrestato.
Furti continui, seguiti da misteriose uccisioni (commesse dentro città e nei dintorni di Sassari) fecero sospettare di una squadriglia segreta di malfattori, negli ultimi anni del governo assoluto. E questa volta non trattavasi di banditi, ma di una lega di malandrini, regolata sulla base degli odierni grassatori della Barbagia: di giorno erano artisti ed operai in apparenza onesti e tranquilli — la notte si univano per commettere le ribalderie, servendo di strumento a cittadini creduti galantuomini. Fin dal 1836 questi delitti si sospettarono perpetrati per invidiosi dispetti, o per vessazioni del francese Uxel; il quale aveva fondato a Sassari uno stabilimento di sanse, a breve distanza dalla chiesa di S. Paolo. La mente direttiva non era sarda — sardo era il braccio che eseguiva il mandato di sangue.
Tra il 1841 e il 1842 non vi fu quasi giorno in cui non venisse consumato un delitto di sangue. I malfattori scorrazzavano per l’isola, e fra essi i terribili banditi corsi Stefano il Serpente, il Quartara, il Tengone, il Santa Lucia. Nel 1842 ne furono rimandati una ventina al Governo francese.
Nell’intento di purgare la società, verso questo tempo, i cittadini discoli venivano arruolati [45] nel Reggimento sardo; ed il governo piemontese, volendo ingrossare le fila dei malfattori isolani, mandava in Sardegna seicento cattivi soggetti, col titolo di operai di punizione!
Il bandito più celebre che chiuse il periodo del regime assoluto fu l’algherese Agostino Alvau. Di costui ci darà qualche ragguaglio Giovanni Tolu, nella sua narrazione.
***
Ed eccoci giunti sulla soglia del 1848, l’anno delle agognate riforme, che dovevano far crollare il vecchio governo assoluto per aprire l’era novella di tempi più civili.
Pur troppo è destino dei popoli, che nei grandi rivolgimenti politici, nel passaggio repentino dall’uno all’altro regime di governo, vi abbia sempre chi approfitti del fermento della situazione, o per avidità di guadagno, o per sfogo di qualche antica vendetta, o per libidine di mal fare, servendo questo o quel potente, nella speranza dell’impunità. Non parve vero ai tristi della campagna e della città di poter mantellare gli istinti feroci sotto la larva di una lotta politica.
Io sorvolerò sulla storia di questi avvenimenti, perchè uscirei di carreggiata.
Il Municipio di Sassari, vivamente impressionato dalle scene di sangue a cui assisteva, ricorse il 22 ottobre 1849 al presidente dei Ministri, esponendogli, [46] con foschi colori i continui, e in questi ultimi giorni spaventevolmente cresciuti delitti ed attentati alla vita e proprietà dei pacifici cittadini.
Il 1850 fu anno tristo per sanguinosi avvenimenti. Con l’allontanamento da Sassari del tribuno Antonico Satta (partito nel giugno del 1849) non furono spenti i rancori, come si sperava. Si ebbe nel giugno la strage così detta dei Saba e Careddu alle porte della città; si ebbe l’anno seguente, nel lunedì di carnevale, l’altra strage dei Saba e dei Macioccu all’uscita del teatro; e le scene sanguinose si ripeterono di tanto in tanto fino al 1855 — anno in cui il cholera mieteva a Sassari oltre 5000 vittime, spegnendo molti odî e molti tristi, e svelando le trame dei numerosi delitti, che da quasi un ventennio si erano macchinati, o compiuti, dentro ai laberinti misteriosi dello stabilimento di San Paolo.
Il primo decennio del governo costituzionale (dal 1849 al 1859) fu memorabile per stragi e per odî di parte, mantellati sempre dalle lotte politiche, le quali non servirono che di pretesto.
Ed è appunto in questo periodo che compariscono sulla scena i quattro banditi famosi: Pietro Cambilargiu, Antonio Spano, Antonio Maria Derudas, e quel Giovanni Tolu, che, inseguito per trent’anni dalla giustizia, fu da questa assolto nelle Assise di Frosinone.
[47]
***
L’antico bandito sardo, conosciuto per l’odio implacabile verso i soli nemici e le spie, per la ripugnanza al furto, la fierezza del carattere, la generosità cavalleresca, è da un pezzo scomparso dall’isola.
Di simili banditi (per vero non troppo numerosi!) si occuparono in ogni tempo, con pietosa simpatia, storici e letterati insigni, nell’intento di mettere in rilievo quella fierezza e quella generosità, che pure in mezzo alle ferocie li rendeva talvolta degni di compianto, se non di ammirazione.
Ne citerò alcuni, per non tediare più oltre il lettore.
Lo storico Pasquale Tola esaltò la magnanimità di Salvatore Anchita verso il suo nemico Francesco Brundano. Dopo aver riportato nel suo Dizionario biografico l’episodio da me altrove citato, scrive: «— Esempio di generosità d’animo, da cui traspare quanto negli uomini stessi rotti al mal fare sia potente il sentimento dell’onore: raggio di virtù che brilla talvolta in mezzo alla fosca luce dei più enormi delitti.»
Sulle pagine del Tola s’inspirò Gavino Cossu, che scrisse un romanzo storico in due volumi col titolo: gli Anchita e i Brundanu.
L’infaticabile frate Vittorio Angius ha voluto [48] scrivere più d’una pagina pietosa, tanto in favore di Leonardo Marzeddu, che si diede alla macchia dopo aver vendicato il suo onore oltraggiato — quanto di Giovanni Fais, che il Valery chiama un Leonida.
L’erudito marchese di San Filippo scrisse e stampò una storia romantica su Peppe Bonu di Bonorva, la quale parve una leggenda, e venne riprodotta in parecchi giornali di Torino.
Il padre Bresciani, che volle visitare più volte la Sardegna, nel suo libro Dei costumi sardi ha dedicato parecchie pagine entusiastiche ai banditi sardi, la maggior parte dei quali (egli afferma nel 1846) lo erano per vendetta d’onore.
Questo scrittore rileva un particolare. Egli dice: quando un bandito sardo è sorpreso nella foresta da qualche carabiniere che gli grida: ferma, il re! — egli risponde togliendosi con riverenza il berretto: — Rispetto il re, ma gli consacro la tua testa! — E postosi dietro un albero fa fuoco sul carabiniere. Il Bresciani a questo punto esclama: — Che laconismo! e che fiera alterezza di cuore! (A me, invece, pare fuori luogo il suo entusiasmo sopra un fatto che non credo vero!)
Parlando delle paci fatte nel 1840 per intervento dei missionari, il Bresciani cita un venerando pastore, il quale si ridusse ad abbracciare un nemico che gli aveva ucciso il figlio. (Caso non troppo comune in Sardegna!)
[49]
Lo stesso scrittore riporta un altro episodio storico, narratogli a Cagliari da un giudice della Reale Udienza. Un famoso bandito, inseguito da due carabinieri, cacciossi per caso dentro un ovile, dove, insieme a molti armati, si trovava l’uomo a cui aveva ucciso il fratello. In omaggio alla sacra ospitalità, il pastore lo accolse nella capanna, e intimò ai carabinieri di allontanarsi, se volevano salva la vita. Informata del caso la Giustizia, fu subito spedito un messo al pastore (padre di due figli di recente condannati a morte) proponendogli la libertà di essi, se si risolveva a cedere il bandito accolto nel suo ovile. Il pastore rifiutò sdegnosamente. Giustiziato uno dei figli, fu rinnovata la proposta per la liberazione dell’altro; ma il vecchio diede al messo questa fiera risposta: — Dirai al giudice, che il sardo ha più cara la fede che i propri figliuoli!» — Quando apprese la morte del secondo figlio il poveretto svenne.
A proposito di questo fatto il Bresciani cita un caso avvenuto in Corsica al tempo in cui Paoli combatteva per la indipendenza dell’isola sua. Un popolano corso, cieco d’ira, aveva ucciso colle proprie mani l’unico suo figlio sedicenne, solo perchè questi, dopo aver concessa l’ospitalità ad un bandito, lo cedette per denaro ad un carabiniere.
«I sardi, che tanto ritennero delle condizioni del mondo antico (conchiude il Bresciani) hanno [50] di queste esagerazioni, riputandole diritto, dovere, e stretta osservanza della ragione delle genti.»
***
E mi pare che le citazioni storiche da me riportate siano sufficienti per dare un’idea del colore dei tempi.
Ho esposto a larghi tratti il quadro dei principali avvenimenti di sangue che afflissero il Logudoro nel lungo periodo di quattro secoli. Mi accorgo però che la mia tela ha tinte troppo fosche, ed è incompleta; poichè non ho potuto riportare che i fatti crudi, quali li estrassi da documenti ufficiali. In riscontro alle nequizie dei banditi da me segnalate, le carte di Archivio non registrano virtù alcuna, nè le intime cause che determinarono il traviamento di tanti infelici, trascinati assai spesso al delitto dalla trista condizione dei tempi miseri e corrotti.
Negli scaffali della Giustizia si riscontrano unicamente le colpe, non le virtù dei disgraziati; e questo forse succede, perchè l’uomo è nato cattivo, e la virtù realmente non esiste. Come l’ombra non è che l’assenza della luce, così la virtù non è che l’assenza del vizio. La società, insomma, pare non pretenda che il solo freno delle passioni, convinta che l’uomo riescirà sempre a fare il bene, sempre quando potrà astenersi dal fare il male.
[51]
Ho esposto in altro libro il sistema usato dallo storico e dal poeta, quando vogliono fabbricare i grandi benemeriti e i grandi delinquenti: — dei primi essi registrano le sole virtù, dei secondi non rivelano che i soli vizi. In pochi, però, la coscienza di voler ritrarre l’uomo qual’è, col fardello del bene o del male, fornitogli dai tempi, dagli uomini, o da madre natura.
Perchè questo? forse perchè il popolo ha bisogno di commuoversi dinanzi a quanto esce dalla cerchia dei fatti comuni: esso sdegna le mediocrità, per esaltarsi alle azioni dei grandi buoni o dei grandi cattivi. L’evangelista Giovanni lo ha detto chiaro nell’Apocalisse: «— Deciditi: sii freddo, o sii caldo; ma se tu sarai tiepido, ovvero nè freddo nè caldo, ti rigetterò dal mio seno!»
Fra i molti banditi che nacquero belva — come Pietro Cambilargiu e Francesco Derosas — non mancarono i disgraziati, che pure in mezzo alle ferocie ebbero slanci di generosità magnanima, di virtù vera, di singolare rettitudine d’intelletto.
Nella storia di Salvatore Anchita, di Francesco Brundanu, di Leonardo Marceddu, di Giovanni Fais, di Peppe Bonu, e di Giovanni Tolu non fanno difetto gli sprazzi di luce che rischiarano azioni generose, delle quali tacciono i documenti Ufficiali. Questo silenzio è spiegabile; poichè la giustizia non sa leggere che nel Codice [52] penale, e non sa pesare nella sua bilancia che le sole colpe degli sventurati! — Ed è forse per reazione che i grandi poeti (come Byron e come Schiller) vollero idealizzare con splendore di colorito le gesta avventurose di corsari e di briganti.
Bisogna, dopo tutto, convenire, che l’uomo ha un fondo malvagio.
Non è questione di alti o bassi strati sociali: — l’ignoranza e il pregiudizio salgono tutti i gradini. Abbiamo veduto come nei traviamenti dei secoli passati incorsero nobili e plebei, e come talvolta si ebbero esempi di volgo nobile e di nobiltà plebea.
Nelle gesta delittuose vi hanno due cavallerie: quella rusticana e quella incivilita. La prima, per sua natura, è apertamente audace — la seconda, all’incontro, nobilmente accorta: forse perchè ha troppi guanti — e i guanti, assai spesso, non servono che a nascondere le mani sporche.
Io non voglio fermarmi sul numero infinito dei delinquenti volgari, che battono la città e la campagna: sono essi i delinquenti d’ogni tempo, d’ogni paese, e parlano ogni lingua. Ripeto solo, che Giovanni Tolu, nel suo complesso di bene e di male, è l’ultimo bandito sardo.
Il bandito sardo — giova ricordarlo, perchè il giornalismo italiano pare si ostini a non volerlo rilevare! — non è un masnadiero, non è un brigante, non è un grassatore, non è un fabbro [53] di ricatti. Ed è solamente per dimostrarlo, che ho voluto aderire a scrivere la storia di Giovanni Tolu.
I tempi or sono cambiati. Colla nuova Italia è sottentrato un altro brigantaggio, che al piombo, al pugnale, ai grimaldelli ha sostituito il libello, la truffa, e i brogli bancari.
Dobbiamo tuttavia ardentemente sperare, che questa nuova forma di delinquenza inguantata, la quale sfugge così spesso alle leggi, abbia fatto il suo tempo. Ad ogni modo, lusinghiamoci di non trovarci per anco nel tristo caso di ripetere la frase tagliente, ch’ebbe sulle labbra Giovanni Prati negli ultimi anni di sua vita: «— Dappoichè ho conosciuto i galantuomini d’oggi, ho preso a stimare i ladri antichi!»
Sassari, maggio 1896.
Enrico Costa.
[55]
STORIA DI GIOVANNI TOLU
NARRATA DA LUI MEDESIMO
[57]
La nostra famiglia è di Florinas.
I miei nonni — Felice Tolu e Francesca Cossu — vivevano agiatamente, perchè possessori di terreni, di case, e di molto bestiame. Dalla loro unione erano nati sei o sette figli, fra i quali Pietro Gavino — mio padre.
I tempi intanto si facevano tristi. Dopo la carestia dell’ottanta — ci diceva il babbo — le terre diminuirono di prezzo, e la piccola fortuna del nonno cominciò a venir meno[2].
Il vecchio Felice scese nel sepolcro lasciando i figliuoli in giovanissima età; e la povera vedova, sperando di poter tirare innanzi la famiglia [60] nell’agiatezza in cui era stata allevata, fu costretta a vendere i pochi beni che ancora le rimanevano. I suoi sforzi, però, riuscirono vani. I giorni calamitosi si succedettero senza tregua, nè si tardò a provare tutte le strettezze della miseria.
Pietro Gavino, per campare la vita, si era adattato a prestare l’opera sua presso alcuni parenti facoltosi; ed una sua sorella, non potendo più oltre mantenere l’antico sfarzo, fece dono della sua ricca veste alla Madonna del Rosario, presso la quale (com’è tradizione nella nostra famiglia) conservasi tuttora.
Sebbene alquanto innanzi negli anni, il mio babbo Pietro Gavino tolse in moglie la giovane figlia di un pastore — Vincenza Bazzoni — che gli regalò una dozzina di figli, diversi dei quali morirono bambini.
Mia madre era in fama per i parti doppi; e infatti per tre volte ebbe figliuoli gemelli, nel numero dei quali sono anch’io compreso.
Ecco i nomi dei figli sopravvissuti: — Felice, il primogenito; Chiara, la seconda; in seguito tre coppie di gemelli, cioè: Peppe ed io — Giammaria e Nicolò — Giustina ed altro che visse pochi giorni — e finalmente Maria Andriana[3].
È cosa ormai assodata: quando Dio non può [61] mandare ai poveri un po’ di fortuna, concede loro la grazia di molti figliuoli!
Pietro Gavino Tolu, mio padre, era un tipo di agricoltore fiero, energico, scrupoloso. Uomo di stampo antico, era rigido e severo nell’educazione della famiglia. Soleva dare poca confidenza ai figli, nè voleva che essi s’intromettessero in alcuna questione di famiglia. I figli, da parte loro, gli ubbidivano ciecamente, non permettendosi la minima osservazione, nè atti sconvenienti alla sua presenza.
Egli ci diceva spesso:
— Figli miei: o buoni, o morti! Voglio che rispettiate gli altri, perchè gli altri vi rispettino.
Guai se egli avesse saputo che i figli si permettevano d’introdursi nei poderi altrui! Sarebbe stato capace di picchiarci senza misericordia.
Ci eravamo tutti abituati al regime rigoroso del babbo, ed in famiglia si viveva tutti di buon accordo.
L’ho detto: al mondo non venni solo. Io sono una grossa metà. Nacqui ad un parto col fratello Peppe, il 14 marzo del 1822 — a Florinas[4].
[62]
Entrambi fratelli fummo mandati a studiare presso un maestro prete, nostro parente, il quale ci sgridava sempre, e qualche volta ci picchiava colla sferza. Peppe, più paziente, imparò a leggere, ed anche un po’ a scrivere; io, invece, inasprito delle brusche maniere del prete, mi ribellai, e non volli più sapere di scuola.
All’età di nove anni, tanto io quanto il mio gemello, fummo accettati nella chiesa parrocchiale, in qualità di sagrestani. Mio fratello, dopo un annetto, lasciò bruscamente la Sagrestia, dichiarando di volersi dare al lavoro dei campi; io rimasi al mio posto per altri due anni.
Tenevo alla carica di sagrestano, poichè lusingava il mio amor proprio. I sacerdoti mi volevano bene, ed io cercai di cattivarmi la loro stima, col mandare a memoria (giacchè non riuscivo a leggere) tutte le risposte latine relative alle funzioni ecclesiastiche — oltre la dottrina cristiana, che sapevo a menadito. Indossavo con un certo sussiego la sottana e la cappetta, ed ero diventato esperto nella professione. Assistevo con disinvoltura alla messa; cantavo con voce squillante nei funerali; accompagnavo il parroco in tutte le cerimonie — tanto nelle visite che faceva [63] alle partorienti dopo il battesimo, quanto alla casa dei moribondi per somministrar loro il viatico. Ond’è, che masticavo molti confetti, e mi ero abituato al tristo spettacolo degli agonizzanti, che nei primi tempi mi facevano una penosa impressione.
Mi pareva di essere diventato quasi il padrone della chiesa e della sacristia. Preparavo gli arredi sacri, regolavo e custodivo il vino, aiutavo i preti a vestirsi e a spogliarsi, ed avevo imparato a mettere in assetto gli altari con un certo gusto. Anche la clientela delle devote mi era affezionata. Tutte le penitenti si raccomandavano a me; ed io trovavo modo di far sbrigare al confessionale le peccatrici che mi andavano più a genio, e che volevo favorire. Le più noiose ed insistenti erano le vecchie, le quali d’ordinario sono quelle che si confessano con più frequenza, forse perchè non hanno più occasione di peccare.
Ero infarinato delle cose ecclesiastiche, e giunsi perfino a capire, che quando il prete nella messa recita più di tre orazioni, egli compie una brutta azione, cioè a dire, fa le legature a danno di qualche nemico[5].
Raggiunta l’età di 12 anni, mi avvidi che il [64] mestiere di sacrista non faceva più per me; sentivo di essere un ozioso, e temevo di esser fatto segno alle beffe de’ miei compagni. Un bel giorno buttai in un canto la sottana, e mi diedi, come gli altri fratelli, a lavorare i campi.
Mio padre era stato accettato come socio da un suo compare agiato, parimenti agricoltore; il quale gli forniva la semente, i buoi e la terra, lasciandogli a benefizio un terzo del guadagno, e tenendo per sè gli altri due terzi, secondo la usanza del paese. Questa società ebbe la durata di otto e più anni, con piena soddisfazione del compare; il che dimostra che mio padre era un abile lavoratore, ed onesto fino allo scrupolo.
Gettata all’ortiche la sottana di sacrista, volli andare a lavorare con mio padre, per servirgli di aiuto. Maneggiavo la zappa, o guidavo i buoi, secondo i casi; e quando per me non c’era lavoro, mi adattavo a trasportar pietre sullo stradone, tanto per non stare in ozio, e per non essere di peso alla famiglia.
Ho l’orgoglio di vantarmene. Fin da giovane avevo la fama di abile lavoratore, di sobrio, di onesto, di docile; nè pochi erano gli agricoltori che chiedevano l’opera mia. Ma io preferiva di aiutare il babbo ne’ suoi lavori di campagna. Pieno di amor proprio e di buon volere, mi sentivo spronato al lavoro dall’emulazione, e godevo di essere mostrato a dito dai compagni, con una compassione che mi sapeva d’invidia.
[65]
Ero appena diciasettenne quando perdetti mio padre, morto a 54 anni. Lo piansi amaramente, e da quel giorno mi dedicai con più lena al lavoro, poichè volevo recar sollievo alla mamma ed alla famiglia.
Felice, il nostro fratello maggiore, aveva intanto preso moglie. Si era unito a Giovanna Serra di Giave, ed erasi allontanato da noi per mettere su casa, a parte.
Io era ritenuto come il figliuolo più serio e più lavoratore; tanto è vero, che a diciotto anni mi si erano affidate le redini della casa. Peppe, più delicato e più debole di me, era rimasto addietro, e subiva la mia influenza.
Provvistomi d’un cavallo mi diedi a lavorare per i paesi circonvicini, facendo il viandante. Trasportavo viveri e merci da un punto all’altro; mi recavo con frequenza a Sassari per vendervi grano; e di là ripartivo con un carico di vino, che mia madre rivendeva in paese per trarne qualche lucro.
L’ho detto: mio padre ci aveva educati rigidamente, e si viveva tutti in buon accordo. Ciascuno di noi portava alla mamma i propri guadagni, e godevamo di una certa agiatezza, relativa alla modesta nostra condizione. Il lavoro non ci mancava mai, ed i viveri erano a buon mercato. Ricordo che verso il 1840 la carne si vendeva a due libre mezzo reale (circa 30 centesimi il chilogramma).
[66]
I principali proprietari di Florinas richiedevano continuamente l’opera mia e quella di Peppe; ma non volevamo legarci ad alcuno, poichè la mamma era gelosa di noi, e temeva che coll’abbandono venisse meno l’accordo in famiglia.
Quando Chiara — la nostra sorella maggiore — toccò i 23 anni, fu chiesta in moglie da un bravo giovane. La scelta fu di nostro gradimento, e raddoppiammo di attività nel lavoro, tanto per poter riuscire a preparare un po’ di fardello alla sposa.
La nostra casa era il nido della pace e della concordia. La vecchia mamma non faceva che ringraziare il Cielo, per averle dato figliuoli così buoni ed affettuosi.
Contavo appena venti anni, quando in paese si sparse la notizia che nell’agro sassarese si prevedeva un raccolto straordinario di olive. Volendo guadagnare qualche soldo in più, mi allontanai da Florinas, per collocarmi nella qualità di sorvegliante a Sassari, presso due proprietari di molini ad olio; nell’uno lavoravo di giorno, nell’altro di notte. Dopo parecchie settimane di assiduo lavoro, feci ritorno a Florinas. Mi sentivo stanco e abbattuto, ma avevo raggiunto lo scopo, mettendo a parte una diecina di scudi, che consegnai alla mamma.
E così continuai a cercar lavoro da un punto all’altro: nei dintorni di Florinas, nelle campagne di Sassari, e nei salti della Nurra. Nessuna fatica [67] mi spaventava quando mi sorrideva la probabilità di un guadagno.
Coi risparmi fatti, decisi più tardi di acquistare un buon cavallo. Me ne offrì uno bellissimo, di manto nero, il reverendo Pittui, per il prezzo di sedici scudi. Ricordo anzi, a questo proposito, che allor quando sborsai la somma al prete, in presenza della serva, mi scivolò di mano una pezza da cinque soldi, che andò a rotolare sul pavimento. Ci chinammo tutti e tre per raccoglierla, ma non ci fu possibile rintracciarla. L’inferno l’aveva inghiottita. Dovetti cacciar fuori dalla borsa altra simile moneta, che non mi venne più restituita. Ricordai più volte questo fatto, ripensando al prete Pittui, che più tardi doveva esser causa d’ogni mia sventura.
Diventato proprietario di un buon cavallo, che battezzai col nome di Moro, continuai la mia vita di lavoro con più coraggio. Passavo intiere settimane fuori di Florinas, e non vi rientravo che alla vigilia dei giorni festivi.
Le domeniche erano per me giorni di noia. Il mio unico divertimento consisteva nel tiro al bersaglio: passatempo di molti giovani del paese nella sera dei giorni di festa, ed al quale prendevano pur parte i signori, ed anche qualche prete. La bettola, i balli, e sovratutto il bel sesso, non ebbero mai per me alcun’attrattiva. Devo anzi confessare, che fin da giovinotto ero un orso e fuggivo quasi le donne. Non provavo la smania [68] di far loro la corte, poichè gli amori inutili mi ripugnavano, non volendo perdere il mio tempo. A che trattenere una ragazza e perdersi in sciocchezze, quando l’uomo non ha intenzione di torsela in moglie? Nei nostri villaggi bisogna andar cauti colle zitelle; il far lo spasimante diventa pericoloso, poichè i parenti della donna potrebbero immischiarsene; e il meno peggio che possa capitare, è il matrimonio forzato con donna che non ci piace. Non amavo le leziosaggini, nè le mollezze femminili, che sfibrano il carattere e ci espongono qualche volta al ridicolo. Sdegnavo di cacciarmi nei pubblici balli, o di piantarmi come un palo dinanzi alle case, per fare il cascamorto colle ragazze che sedevano sulle soglie. Preferivo andarmene fuori del paese con la combricola dei tiratori, per vincere una scommessa al bersaglio. Il fucile era la mia prima passione — il cavallo la seconda.
Non mi fecero pertanto difetto le avventure amorose; ma io nella donna temevo le malìe — cioè a dire le legature, come noi le chiamiamo. Citerò due soli episodi.
Recatomi una sera in casa di un amico, vi trovai la moglie insieme ad una giovane sorella di costei, di fama un po’ equivoca.
La donna maritata, fra il serio e il faceto, mi disse:
— Guarda mia sorella, com’è bellina! Perchè non te la baci?
[69]
Fui quasi spaventato dello strano invito; del che accortasi la scaltra donna, cambiò tono, e mi chiese il favore di accompagnare la sorella ai balli, che avevano luogo quella sera in piazza.
Benchè a malincuore, accondiscesi al suo desiderio. Quando fummo di ritorno, le due sorelle si affrettarono ad offrirmi alcuni amaretti e un bicchierino di rosolio; ma io mi guardai dall’accettare, temendo volessero farmi qualche legatura. Appresi più tardi, che la moglie del mio amico aveva contato sulla mia inesperienza, per mantellare col sacramento del matrimonio il primo fallo della sorella.

Due mesi dopo, a breve distanza da Florinas, mentre rientravo dalla campagna, fui fermato con mistero da una giovane donna, maritata ad un vecchio. Ella cominciò col parlarmi di una sua amica, la quale era alquanto innanzi negli anni, ma possedeva un piccolo vigneto ed una casa bassa, che le procuravano una vita abbastanza comoda. Avendo costei desiderio di marito, me la proponeva come moglie, cercando persuadermi che avrei fatto un buon affare; poichè, anche con una moglie attempatella, non mi sarebbe [70] mancato l’affetto di qualche amica più giovane. Rifiutai con ripugnanza; e allora la giovane si sfogò meco in tenerezze, e mi tenne un linguaggio così singolare, che mi costrinse a fuggire da lei, come un casto Giuseppe dalla moglie di Putifarre[6].
Tale io era con le donne a vent’anni. In seguito, naturalmente, ebbi qualche scrupolo di meno, sebbene non sia mai riuscito a cambiare la mia opinione[7].
[71]
Raggiunta l’età di 25 anni, non tardai a sentire tutto il peso della mia vita solitaria, monotona. L’amore al lavoro ed al guadagno, la ripugnanza all’ozio ed ai compagni crapuloni, mi rendevano più penoso l’isolamento. Non bastava più mia madre, non bastavano i miei fratelli, nè le sorelle, a darmi un conforto, quando stanco rientravo in seno alla famiglia, dopo una settimana d’incessante e faticoso lavoro. Desideravo qualche cosa di più attraente che mi eccitasse ogni sera a far ritorno alla mia casetta.
Felice, il primogenito de’ miei fratelli, aveva preso moglie; gli altri pensavano a prenderla; le mie sorelle già parlavano di marito — ed io non sentiva la virtù del sagrifizio, senza uno scopo determinato. Il pensiero di abbandonare la mamma era quello che mi tormentava; ma io avrei potuto ritirare la vecchierella presso di me; avrei potuto darle una compagna, quando le sorelle e i fratelli miei si fossero allontanati dalla casa materna, per crearsi una famiglia.
[72]
Pensai dunque ad una compagna.
Avevo fermato l’attenzione sopra una bella giovinetta quindicenne, che ogni domenica io aspettava sul piazzale della chiesa, all’entrata ed all’uscita della messa. Parecchie volte ero stato ai balli con essa, e mi pareva che non gli fossi del tutto antipatico. Il contegno modesto di quella ragazza mi aveva profondamente colpito. Maria Francesca, la prediletta del mio cuore, era al servizio del prete Gio. Maria Masala Pittui, insieme ad una sua zia.
Questa zia — Giovanna Maria Meloni Ru — si trovava da molti anni in casa del prete. Tanto lei, quanto una sua sorella maggiore, si erano allontanate dal paese natio (Scano Montiferro) ferme nel proposito di collocarsi come serve in casa di qualche prete, a Florinas, o altrove. L’una di esse, infatti, riuscì ad essere accettata dal reverendo Pittui — l’altra si collocò presso un altro sacerdote, in Codrongianus.
Le due donne avevano un fratello a Florinas — Salvatore Meloni Ru — già servo del prete Pittui, che gli aveva dato in moglie certa Catterina Merella.
Da queste nozze era nata, fra gli altri figli, Maria Francesca, la ragazza che mi aveva colpito. Costei, fin da bambina, frequentava la casa del prete, dove si recava per visitarvi la zia; e quando crebbe negli anni vi fu accettata come servetta, con piena soddisfazione dei genitori; i [73] quali ascrissero a grazia divina l’aver potuto collocare la loro bella figliuola in casa di un sacerdote benestante, influente, e temuto più che amato nel paese.
Il prete Pittui aveva fatto di tutto per dar marito all’antica sua serva Giovanna Maria, ma non vi era riuscito. In paese correvano molte dicerie sul conto di quella donna, e nessuno voleva caricarsela. Fra gli altri designati, il prete si era rivolto a due suoi nipoti, promettendo loro la protezione, e non so che altro, se avessero appagato il suo desiderio; ma i due nipoti non vollero sapere di dar la mano ad una donna attempatella, a cui si cercava un marito con tanta insistenza.
Il rifiuto dei due giovani inasprì alquanto lo zio, che tenne loro il broncio per lungo tempo, sebbene non mancasse di prenderne le difese, quando credeva compromessa la dignità del sangue di famiglia.
Il prete Pittui trovò finalmente il desiderato Cireneo della sua Giovanna Maria: un suo servo agricoltore — certo Giovanni Antonio Piana; il quale, sebbene molto giovane (eravamo coetanei) si decise a sposare quella donna, che poteva essergli madre.
Giovanni Masala Pittui era un prete, che aveva oltrepassata la cinquantina. Burbero, prepotente, di modi piuttosto aspri, si sentiva capace di affrontare venti nemici petto a petto. Possedeva [74] una Cappellania, che dicevasi gli fruttasse da quattro a cinquemila scudi; ed aveva l’obbligo di dir la messa tutti i giorni festivi nell’Oratorio di Santa Croce — chiesetta un po’ fuori di mano, perchè posta all’estremità del villaggio.
Erano in quel tempo in Florinas altri tre preti: i due viceparroci e il rettore Gio. Angelo Dettori; ma nessuno poteva vantare l’influenza del prete Pittui, che tutti temevano. In relazione con cavalieri, avvocati, giudici, ed altre autorità di Sassari, egli dispensava promesse o minaccie a diritta ed a manca, e nessuno osava contraddirlo, poichè si sapeva che le minaccie avrebbero avuto il loro effetto.
Il prete Pittui andava sempre armato, ed era ben provvisto di fucili, di pistole, di pugnali. Possedeva una quindicina di cani, fra i quali due feroci mastini, capaci di sbranare quattro nemici a un semplice cenno del padrone. Si vantava di essere un valente cacciatore (e lo era di fatto), e si dilettava parimenti della pesca nei fiumi; però, non mangiava mai pernici, nè lepri, nè anguille, che per solito regalava agli amici.
Io era in buoni rapporti coi preti di Florinas, poichè tutti mi avevano conosciuto sagrestano. Anche prete Pittui mi trattava con una certa confidenza. Non poche volte gli avevo assistito la messa, e assai spesso mi ebbe a compagno nelle solite gare al bersaglio della domenica. Guai però a contraddirlo, o a prendersi troppo confidenza [75] con lui! Corrugava la fronte, rispondeva brusco, e voltava le spalle con aria spavalda e prepotente.
Per dare un’idea del suo carattere focoso e della fiducia che riponeva nelle autorità di Sassari, di cui si vantava amico, narrerò un episodio.
Un giorno io lavoravo in un suo tenimento, insieme ad altri compagni, fra i quali uno dei due nipoti che si era rifiutato a sposargli la serva Giovanna Maria. Avvenne che uno dei contadini che lavoravano insieme a noi, non so per qual contesa insorta, mettesse le mani addosso al nipote del prete, che per caso era presente. Io corsi in difesa dell’aggredito, e afferrato un bastone percossi senza misericordia l’aggressore.
Il prete, cieco di bile per l’insulto fatto al parente, mi si accostò inferocito, gridandomi alle spalle:
— Uccidilo! uccidilo, Giovanni! chè penserò io a strapparti alla Giustizia!
Queste parole mi fecero tornare in me, e sospesi la correzione — tanto più che l’avversario non mi aveva opposto resistenza. Il prete si limitò a licenziare il contadino audace; ma mi accorsi che non era soddisfatto della mia disubbidienza.
Riprendo la narrazione.
Colpito, dunque, dall’avvenenza e dalla modestia di Maria Francesca, e fermo nel proposito di prender moglie, mi decisi a confidare in famiglia i miei progetti, chiedendo un consiglio. [76] Ottenni la generale approvazione per la buona scelta fatta. Lieto che tutti fossero contenti, incaricai la mamma di recarsi in casa del prete Pittui per chiedergli la mano della ragazza. Si sa che in simili casi i genitori passano in seconda linea, poichè spetta ai padroni disporre dell’avvenire delle serve.
Mia madre, dopo essersi vestita degli abiti migliori, si recò dal prete per far la domanda. Io rimasi ad aspettarla in casa, ansioso di conoscere la risposta.
Trascorsa una mezz’ora, mia madre fu di ritorno. Per quanto affettasse disinvoltura, mi accorsi subito che la sua missione non era pienamente riuscita.
— Ebbene....? — le chiesi, andandole incontro.
— Bisogna ancora aver pazienza, figlio mio!
— Un rifiuto?!
— Non rifiuto, veramente! Mi disse solo, che avessi prima pensato a maritare le tue sorelle Giustina e Maria Andriana, poichè per Maria Francesca ci sarebbe stato tempo, avendo essa di poco oltrepassato i quindici anni.
Questa risposta, che mia madre si studiava di raddolcirmi, mi tenne alquanto di malumore. Tuttavia, non disperai, deciso di tornare all’assalto in un momento più opportuno.
Lasciai trascorrere alquante settimane. Nel frattempo in paese si era fatta correre una voce, [77] la quale in sulle prime mi fece sorridere, ma in seguito mi destò qualche inquietudine. Dicevasi dalle comari, che io mi era pazzamente invaghito di Maddalena Pintus Marongiu, figlia di Pietro Paolo, la cui fama non correva troppo buona in paese. Si era pur detto, precedentemente, che tanto la ragazza, quanto i suoi genitori, studiassero tutti i mezzi per accalappiarmi con un matrimonio.
L’origine e lo scopo della diceria erano palesi. La zia di Maria Francesca aveva confidato alle comari la mia domanda di matrimonio; e la famiglia Pintus, al cui orecchio era pervenuta la notizia, aveva messo in giro la storiella del mio amore, per dar pretesto al prete di rifiutarmi la mano della ragazza.
Un caso innocente, avvenuto poche settimane dopo, diede corpo all’ombra ed alimento ad una diceria, che servì di appiglio ai disgustosi incidenti che amareggiarono in seguito la mia esistenza.
[78]
Si era verso la metà di Settembre del 1848, e si avvicinava il giorno della famosa festa di Nostra Signora di Bonuighinu, che suol farsi presso una chiesa campestre, nelle vicinanze del villaggio di Mara. Questa festa, con annessa fiera, è una delle principali dell’isola, e chiama tuttora dal Logudoro e dalla Planargia una folla considerevole di curiosi e di devoti[8].
Essendo Mara molto distante, i florinesi hanno bisogno di quattro o cinque giorni per effettuare la gita e godere del divertimento; e forse [79] per questo motivo l’attrattiva è maggiore, e cresce nei festaioli la smania di prender parte alla baldoria.
Già da tre anni mi ero prefisso di recarmi a N. S. di Bonuighinu per sciogliere un voto fatto, e nello stesso tempo per divertirmi un poco. Lavoravo tutto l’anno con assiduità, e mi pareva di aver diritto a un po’ di svago. Circostanze impreviste avevano impedito che si effettuasse il mio disegno; ond’è che quella volta fui irremovibile nel mio proposito.
Mia madre non vide di buon occhio la mia gita, e me lo disse con una certa amarezza:
— Bada, Giovanni! A me pare, che in questa circostanza non ti convenga recarti alla festa. Non vorrei che la tua gita avesse a procurarti qualche dispiacere!
Io mi strinsi nelle spalle. Mia madre, certamente, voleva alludere alle trattative in corso per la domanda di matrimonio; ma io sentiva di aver la coscienza netta, nè dovevo temere serie conseguenze da un passatempo innocente.
Anche il nostro vicino di casa — Gavino Pintus — aveva deciso di andare alla festa insieme alla figliuola, e si era dichiarato contento di avermi a compagno di viaggio.
Questo Pintus, agricoltore benestante, era fratello dell’altro Pintus, della cui figlia mi dicevano invaghito. Le due cugine avevano lo stesso nome: Maddalena.
[80]
All’alba del giorno designato insellai il mio Moro; Gavino Pintus prese la figliuola in groppa, e partimmo insieme.
Svoltate appena due stradicciuole, il Pintus fermò il cavallo e mi disse:
— Aspettami qui un momento. Mi spingo fino alla casa di Pietro Paolo, per sapere se insiste nell’idea di venire alla festa.
Fu tanta la mia sorpresa, che non risposi neppure. Mi lusingavo già che si trattasse di un semplice atto di convenienza, quando vidi sboccare da una viottola i due fratelli a cavallo, colle rispettive figliuole in groppa.
Quell’incidente impreveduto mi gelò il sangue. Mi venne persino in mente di piantare la comitiva e di andarmene tutto solo alla festa; ma ebbi vergogna di una debolezza, che poteva venir interpretata paura o vigliaccheria. Ripensai allora alle parole di mia madre, la quale non s’ingannava mai ne’ suoi pronostici.
Che dovevo fare? Feci l’uomo di spirito, e mi rassegnai ad essere il compagno di viaggio dei due fratelli e delle due cugine, deciso però a mostrare il broncio alla coppia malaugurata, che aveva messo in giro la diceria de’ miei amori. Volevo che si notasse quanto poco gradita mi fosse la compagnia dei due intrusi.
La figliuola di Gavino, appena quindicenne, era di un’ingenuità infantile; la cugina, invece, a diciott’anni, rivelava una furberia singolare, ed era molto addentro negli intrighi amorosi.
[81]
Il padre di costei, povero quanto Giobbe, tirava a stento la vita, ma studiavasi di comparire agli occhi del mondo meno miserabile di quello che era.
I nostri tre cavalli trottavano di conserva sulla strada. Mi ero messo alla sinistra di Gavino per togliermi alla vista di Pietro Paolo e della figliuola. Mi divertivo invece a scherzare e a conversare colla più giovane delle Maddalene, lasciando l’altra ad annoiarsi fra il babbo e lo zio.
Arrivati dopo un’ora di strada al sito denominato Sas funtanas, smontammo tutti per abbeverare i cavalli.
Stando insieme sul ponte, Gavino si lamentò meco della lentezza del suo cavallo, incapace di poter portare due persone sul dorso. Io gli dissi:
— Se per quindici giornate tu mi aiuterai ad arare la terra, porterò la tua figliuola in groppa.
Il babbo mi rispose, scherzando:
— Anche per venti giorni avrai l’aiuto mio, se vorrai alleggerirmi di Maddalena!
Dopo avermi aiutato ad assicurare il sellone sul mio cavallo, Gavino sollevò da terra la figliuola e me la sedette in groppa.
Ci rimettemmo in viaggio.
Mi sentivo proprio contento del servizio reso a Gavino Pintus. Il mio cavallo trottava, ed era facile lasciarmi addietro gli altri compagni, la cui conversazione mi riusciva oltremodo impacciante.
[82]
Così trottando, colla donna in groppa, volli mangiare un boccone. Tolsi dalla mia bisaccia un po’ di pane e di noci, e ne offersi a Maddalena, la quale si divertiva un mondo alle mie facezie.
Arrivati dopo cinque ore di viaggio alla cantoniera di Giave, Pietro Paolo invitò tutti a smontare da cavallo, offrendoci le sue provviste per far collazione.
— Ho giù mangiato e non ne ho voglia! — risposi.
— Mangiato! e quando? — mi chiese sorpreso Pietro Paolo.
— Or ora in viaggio — risposi — ed ho anche bevuto. Anzi, se volete approfittare, ci ho ancora vino nel mio fiasco!
Mi ero proposto di nulla accettare da quella gente. Sebbene avessi giustificato il mio rifiuto, mi accorsi ch’esso spiaque ai due fratelli, i quali pertanto si guardarono dall’insistere.
Terminata la collazione continuammo il viaggio, e dopo altre due ore di strada sostammo a Padria, ospiti del comune amico Salvatore Masia, il quale volle offrirci una lauta cena.
Come più ci avvicinavamo a Mara, più numerose diventavano le comitive dei festaiuoli, accorrenti da ogni punto dell’isola a N. S. di Bonuighinu.
All’alba del giorno susseguente rimontammo a cavallo, e un’ora dopo entravamo nel villaggio [83] di Mara, accolti generosamente da Antonio Francesco Peralta, che ci volle ospiti, insieme ad altri festaiuoli che ci avevano preceduto.
I miei compagni lasciarono in paese i cavalli, e si recarono a piedi alla chiesetta campestre, distante appena una mezz’ora. Io feci quel tragitto a cavallo, sempre con Maddalena in groppa.
Pietro Paolo si era rassegnato a far la strada a piedi, poichè la figliuola, sprovvista di sellone, era stata adagiata alla meglio su due cuscini. Il vero scopo della sua gita era il solito commercio d’uova; e si sentiva giustamente umiliato della propria miseria, tanto più sapendo che a me non mancavano soldi da spendere[9].
Durante la breve gita da Mara alla chiesa campestre, io continuai le facezie colla mia compagna di viaggio, quasi per far dispetto alla cugina, della quale volevo vendicarmi. Ero ancora inasprito delle dicerie messe fuori dai genitori di una ragazza, la quale pretendeva di essere corteggiata per forza. La mia natura superba rifuggiva da simili donne!
[84]
Un’immensa folla occupava i dintorni della chiesetta; e vi erano rappresentati la maggior parte dei comuni dell’isola.
Attiguo alla chiesa è un vasto cortile con un lungo loggiato per comodità dei visitatori e dei mercanti. Vi si vendeva di tutto, e si macellava all’aria aperta carne di bestiame, proprio... o rubato.
Siccome mi ero recato alla festa per sciogliere un voto, non mancai di far le mie preghiere in chiesa; dopo di che, pensai a darmi un po’ di spasso. Ho sempre mantenuto la mia parola, anche con Dio e coi santi!
Da Mara erano venuti, insieme a noi, molti curiosi e devoti; e non poche forosette, in allegra brigata, avevano voluto accompagnare le due cugine Pintus.
Eravamo arrivati alla chiesa verso il Vespro, dopo aver fatto a Mara le provviste per la cena.
Io non stavo indietro ad alcuno nello spendere; anzi mi ero proposto di fare il generoso. Avevo comprato molte libbre di pesce d’Oristano cotto, nonchè una ragguardevole quantità d’aranci, che dispensai largamente a quanti componevano la numerosa comitiva.
Cenammo in una delle loggie del vasto cortile della chiesa.
Terminata la funzione del Vespro, s’iniziarono i balli. Era un gridìo incessante di mercanti e di compratori, di giovanotti allegri e di donnette [85] di buonumore. Al chiarore dei lampioncini, dei falò, dei razzi, si correva da un punto all’altro scherzando, ridendo, altercando. La festa era stata allietata dalla presenza dei principali cavalieri e signori di Bonnanaro, di Torralba, di Bessude, di Borutta e di Tiesi, che gironzavano di qua e di là, in compagnia delle loro donne.
Dopo aver preso parte ai balli, come attori o come spettatori, fu proposta la visita a tutti i liquoristi e torronai; e da una baracca all’altra non si faceva che bere ed acquistare dolciumi per i bambini. Com’è usanza in simili feste, ci alternavamo nello spendere; e ciascuno cercava di distinguersi nella prodigalità.
A Pietro Paolo non erano rimasti in tasca che sette soldi e mezzo, ed io non avevo cessato di superarlo negli acquisti.
Verso la mezzanotte si die’ principio alla solita gara dei poeti estemporanei, con botta e risposta. I due fratelli Pintus vollero assistere alle sfide in versi, poichè uno di essi — Gavino — si piccava d’essere poeta. Io, invece, con le due cugine Pintus, preferimmo di prender parte al ballo.
Terminate le danze la Maddalena Bua mi disse:
— Andiamo a bere alla fonte!
La fonte è lontana un quattrocento passi dalla chiesa, e la folla vi affluiva di continuo.
Volli appagare il desiderio delle donne, e le accompagnai.
[86]
La moltitudine che andava e ritornava dalla fonte rendeva penosa la nostra gita. Frotte di allegri giovinotti, un po’ brilli, davano la baja a questa o a quella forosetta, e bisognava lottare, or colle buone ed ora colle brusche, per aprirci un passaggio. Io stava attento perchè le mie donne non si sbandassero, trascinate dalla folla che ci seguiva, o da quella che ci veniva incontro.
A un certo punto Maddalena Bua (la più giovane) si fermò e mi disse ingenuamente:
— In questo modo non potremo andare avanti! Perchè non ci dai il braccio?
E senza aspettare che io l’offrissi loro, le due donne mi presero a braccetto: l’una a destra, l’altra a sinistra. Sudavo freddo, immaginando le chiacchiere dei maldicenti florinesi che assistevano alla festa.
Dopo essere stato alla fonte, ricondussi le Maddalene verso la chiesa, e le accompagnai fino alle loggie. Erano le due dopo mezzanotte, e volevano riposare.
Offersi il mio cappotto alla più giovane, perchè se ne servisse come guanciale, e tornai indietro per raggiungere i miei compagni, che erano intenti al giuoco, ai canti, ed alle gare poetiche.
Mancavano due ore all’alba quando mi diressi tutto solo alle loggie, in cerca di un cantuccio per poter dormire. Passando lungo lo [87] scompartimento assegnato alle donne, fui colpito dalla vista di una nera sottana, che provocava le grasse risa e gli scherzi degli astanti. Era quella di un prete di Mara, venuto per le funzioni religiose. Volendo star comodo, egli si era cacciato alla chetichella nel loggiato delle donne, sordo alle chiacchiere e alle facezie di quanti lo avevano veduto. Io gli dissi, scherzando:
— Ella ha scelto un buon posto, reverendo! Fra sottane e gonnelle ci corre poco!
— Lasciatemi dormire, chè ne ho bisogno, canaglia! — brontolava il prete con stizza. — Tu per il primo, Giovanni Tolu, non vorrai rinunziare alla mia messa! Non è così?
— Sicuro, che è così! — risposi — poichè mi vanto di essere un buon cristiano. Non solamente ascolterò la vostra messa, ma vi prometto di assistervela come antico sagristano. A condizione però, che diciate una messa da cacciatore: brevissima.
— Siamo intesi, e buona notte!
— Dite meglio: buon giorno! — conchiusi.
La giornata susseguente non fu meno chiassosa del Vespro, quantunque quest’ultimo abbia sempre maggior attrattiva.
Fedele alla parola data, volli assistere il prete nella messa, e mi ci misi d’impegno. La maggior parte dei devoti l’ascoltarono all’aria aperta, poichè la chiesa non poteva capire che un duecento persone.
[88]
Terminata la funzione religiosa si ricominciarono le danze, i canti e le visite alle baracche.
Si pensò intanto alla collazione. Pietro Paolo si era incaricato di provvedere il pesce; ma siccome aveva pochi soldi da spendere, ne portò una quantità insufficiente. Allora andai io a far l’acquisto, e tornai con un grosso involto di muggini e di aranci, bastevoli per saziare dodici persone. Devo confessarlo: quel giorno volevo fare il signore.
Fu sempre mia opinione, che l’uomo non deve badare ad economie in certe circostanze; e quando non si hanno i mezzi per poter spendere, si rimane a casa per evitare una brutta figura.
Dopo la collazione si andò tutti alla messa solenne; in seguito ebbe luogo la processione, la corsa dei cavalli, e di nuovo i canti e le danze.
Verso la una dopo mezzogiorno i festaiuoli si unirono in diversi gruppi, per i preparativi della partenza.
Fin dal giorno innanzi avevo ordinato che da Mara mi si portasse il cavallo. Montai in sella, ripresi in groppa la figlia di Gavino Pintus, e feci al passo il breve tragitto, per andar di conserva co’ miei compagni di viaggio, ch’erano tutti a piedi.
L’ho detto: quel giorno volevo fare il signore.
[89]
Arrivati al villaggio di Mara si fece sosta, e si pranzò in casa Peralta. Al pomeriggio si giunse a Padria, dove passammo la notte. All’alba del giorno seguente ci recammo a Tiesi, per accompagnarvi i desini, che ci furono compagni alla festa. Ivi passammo il resto della giornata e la notte, sempre in baldoria.
In quest’ultimo paese Pietro Paolo fece un carico d’uova, ed affidò la figliuola allo zio Gavino, che se la prese in groppa.
Di là si andò tutti a Banari per accompagnarvi la comitiva dei banaresi, e vi si passò allegramente la giornata. Verso sera ci movemmo dal paese per far ritorno a Florinas.
Prima di allontanarmi dalla chiesetta di N. S. di Bonuighinu, ebbi cura di far la provvista di confetti e torroni per portarli alla mia famiglia ed a quella di Gavino Pintus. Non si deve far ritorno da una festa senza pensare a quei di casa.
[90]
Pietro Paolo Pintus, fin dal mattino, si era messo in viaggio per Florinas col carico delle uova, avvertendoci che alla sera ci sarebbe venuto incontro per riprendere la figliuola. Giunto a Florinas (come seppi più tardi) si era presentato a mia madre, chiedendole se avesse un sellone da donna per adagiarvi la sua Maddalena.
La mia vecchia, già inasprita per la diceria messa in giro sul mio conto, gli rispose bruscamente:
— Invece di sella, perchè non vai alla ricerca di due fascine, per collocarvi la tua figliuola?!
Pietro Paolo si allontanò, fingendo prendere l’insulto come uno scherzo innocente. Ognuno sa che sulle fascine si trasportano i feriti od i morti per malefizio.
Eravamo a metà strada da Banari a Florinas, quando Pietro Paolo venne a incontrarci. Egli si affrettò a dirmi:
— Pare che la tua mamma sia in collera!
— Se mia madre è in collera — risposi asciutto — avrà le sue buone ragioni. Ella non si adira mai, senza un motivo.
La ragazza ch’io aveva in groppa, impressionata dalle parole dello zio, voleva ad ogni costo smontare da cavallo.
— Tua madre l’ha con me — diceva impaurita — ed io non voglio essere da lei sgridata!
— Sta tranquilla! — le risposi — con te la mamma non può aver rancori.
[91]
E siccome la ragazza persisteva a non voler più stare con me, il padre le gridò con voce autorevole:
— Rimani dove sei! Nessuno oserà farti rimprovero. Ci sono io, qui!
Mi rivolsi allora a Maddalena, e soggiunsi risoluto:
— Se tu smonterai da cavallo, vi pianterò qui tutti, e rientrerò solo in paese!
Lo zio e la cugina di Maddalena Bua non fiatarono.
L’incidente non ebbe altro seguito. Facemmo insieme la strada, e si parlò d’altro.
Intanto a Florinas era pervenuta la notizia delle mie avventure a Nostra Signora de Bonuighinu. Alcuni festaiuoli florinesi, arrivati il giorno precedente, avevano parlato della mia gita alla fontana, a braccetto di Maddalena Marongiu. Si diceva di amori, di accordi presi, di nozze conchiuse.
La stessa madre della ragazza si era lasciata sfuggire qualche frase allusiva; la quale era stata colta a volo e commentata in tutti i modi. Più tardi quella furba, abboccatasi colla signora Vittoria Oppia (comare di battesimo del prete Pittui) le spiatellò addirittura, che il marito e la figliuola, lo zio e la nipote, si erano tutti recati a N. S. di Bonuighinu per combinare il matrimonio fra Giovanni Tolu e Maddalena Pintus Marongiu.
La signora Oppia si affrettò a riferire il fatto al compare prete, il quale montò su tutte le furie.
[92]
— Come?! si osano fare simili pazzie, dopo le trattative in corso per una ragazza che è in casa mia? Vedremo come l’andrà a finire!
Mia madre, al cui orecchio erano pervenute le chiacchiere del paese, era molto dispiaciuta; e stava appunto adoperandosi a persuadere le comari del vicinato, quando udì lo scalpitare dei cavalli che annunziava il nostro ritorno dalla festa.
Siccome avevo Maddalena in groppa, era mio dovere smontare dinanzi alla casa di Gavino Pintus, posta al di là della nostra. Passando dinanzi a mia madre ed alle mie sorelle, ch’erano sulla porta, dissi loro scherzando:
— Stava qui Giovanni Tolu, quando era vivo?
Mia madre non sorrise, ma mi disse con tono d’ironia:
— Festa lunga, eh?
— Lunga e bella! — risposi, e spinsi oltre il cavallo.
I miei parenti si avvicinarono alla casa di Pintus, col quale erano in buoni rapporti. Feci là distribuzione dei confetti e dei dolci alle due famiglie, e Gavino volle che quella sera si cenasse insieme.
Rientrati in casa nostra, la mamma mi disse con tono grave:
— Dio non voglia, o Giovanni, che questa festa ti costi cara, e che qualche giorno non abbia a pentirtene!
[93]
— Quando si ha la coscienza di non aver recato danno ad alcuno, non si devono temere tardi pentimenti!
Allora la mamma e le sorelle mi posero a parte delle dicerie che correvano in paese, e delle scene avvenute fra la madre di Maddalena Pintus, la signora Oppia ed il prete Pittui.
— Tutte falsità e calunnie! — gridai stringendomi nelle spalle — Io non ho avuto mai intenzione di far l’amore con alcuna donna, nè ho incoraggiato ragazze a nutrire sciocche speranze.
Trascorsi alcuni giorni, volendo mettere le cose a posto, pregai la mamma di recarsi un’altra volta dal prete Pittui per smentire le dicerie, e per rinnovare la domanda di matrimonio.
Mia madre rientrò in casa dopo un’ora.
— Eccoti bell’e maritato! — mi disse con amarezza — Maria Francesca non ti vuol più perchè ti sei legato ad altra donna!
— Che ti disse il prete?
— Lo trovai sulle furie. Egli non pronunciò che queste parole: «— Dirai al tuo figliuolo, che si mariti con chi gli pare e piace, ma che stia lontano dalla mia casa.» — Sei contento, adesso?
— Via, non t’inquietare. Dissiperò io l’equivoco. Mi presenterò dal prete, e saprò convincerlo.
Due giorni dopo mi feci annunziare al prete Pittui. Mi ricevette nello studio, ma di mala grazia.
[94]
— Che vuoi tu qui?
— Ve lo ha già detto mia madre: — voglio in moglie Maria Francesca, la vostra servetta.
— Maritati con chi ti piace, ma non in casa mia. Maria Francesca non sa filare, non sa fare il pane, non sa far niente!
— E che importa ciò? — risposi piccato — Io so filare, so fare il pane, so far tutto. Col mio lavoro e colla mia attività saprò provvedere a quanto abbisogna in una casa.
— Maritati con chi ti piace, ma non in casa mia!
— Ed è appunto in casa vostra che voglio maritarmi, perchè vi si trova colei che mi piace.
Il prete Pittui si mostrò meco inflessibile. Non volle darmi alcuna soddisfazione, nè volle ascoltare alcuna discolpa. Riflettei che non era il caso d’insistere, e me ne andai, col proposito di scegliere un momento più propizio per far valere le mie ragioni.
Ritornato da lui una seconda volta, lo trovai anche più duro. Mi parlò di mala grazia, e mi fece intendere, che non mi avrebbe mai dato il consenso di sposare la sua servetta.
Il suo contegno insolente e le sue parole tronche mi fecero perdere la pazienza.
— In fin dei conti — risposi — Maria Francesca non è vostra figlia; e se tale pur fosse, mi basterebbe il consenso di lei. Ottenendolo, io resterei con mia moglie, e voi senza figlia!
[95]
— Ed io non le darò nulla! — esclamò vivamente il prete, piantandomi addosso due occhi da spiritato.
— Se voi non le darete nulla, tanto meglio per me. Vivrò più tranquillo; poichè coi vostri doni non potrei sfuggire alla critica del paese... Voi m’intendete!
Queste mie parole ferirono a sangue il prete. Egli non volle più ascoltarmi, e mi licenziò bruscamente.
[96]
Ottenuto, per mezzo di impegni, un terzo abboccamento col prete Pittui, questi si mostrò addirittura implacabile, nè volle udire ragione alcuna. Non valsero preghiere, nè umiliazioni per smuoverlo dal suo proposito. Allora gli dissi con significato:
— Chi lo sa? i tempi cambieranno!
E il prete con aria minacciosa:
— Possono cambiarsi in bene, ed anche in male!
— Badate, reverendo! quando i tempi si cambiano in male, i signori rischiano di perdere la vita e il patrimonio; — i poveri invece non potranno rischiare che la sola vita, poichè non hanno altro da perdere!
E così dicendo presi commiato dal prete, in preda ad un’agitazione febbrile, che non riuscivo a dominare.
Da quel giorno vissi irrequieto e cominciai a disperare di me, della mia fortezza d’animo, della mia fibra d’acciaio.
[97]
I miei timori non furono infondati. Il prete cominciò la sua vendetta, valendosi vigliaccamente dei mezzi che gli dava il suo ministero. Egli mi fece le fattucchierie, nè tardai ad accorgermi che mi trovavo sotto l’influenza d’una legatura. Caddi ben presto ammalato; di quel malore singolare, che i medici sono impotenti a guarire[10].
Non si rida delle mie credenze. La mia convinzione è profonda, perchè fondata sulla esperienza di tutta la mia vita.
Io ero fatturato. Il prete Pittui mi aveva fatto le legature, e dovevo pensare a scioglierle. Mi sentivo seriamente ammalato, e bisognava guarire.
La mia malattia era curiosa. Mi sentivo tutto pesto — come se fossi stato bastonato senza misericordia. Provavo una svogliatezza singolare, dolori atroci alle ossa, punture insopportabili a tutte le articolazioni. E questi dolori si facevano più acuti nell’ora del Vespro, alla vigilia delle [98] feste solenni — quasi a ricordo della festa di Nostra Signora di Bonuighinu. Era in quel vespro che Maddalena Pintus Marongiu si era appoggiata al mio braccio per recarsi alla fontana!
Dovevo dunque pensare alla guarigione. Io ben sapeva che in questi casi è opera vana ricorrere ai medici; bisognava raccomandarsi ai soli preti, o a persone esperte nella scienza delle fattucchierie.
Mi rivolsi, primo fra tutti, al nostro vice parroco Giovanni Stara, un buon prete esemplare, molto povero. Egli si munì di stola, di aspersorio e di breviario, e cominciò gli esorcismi.
Per tre volte ricorsi a lui, e devo dichiarare che fra i consultati fu il più efficace nella cura. I miei dolori non cessarono, ma diminuirono sensibilmente e mi diedero tregua per qualche settimana.
Seppi un giorno, che nel villaggio d’Ossi era un prete assai potente negli scongiuri. Si chiamava Valerio Pes. Montai a cavallo e andai a visitarlo.
Come il vice parroco Stara, egli mi fece mettere ginocchioni, mi lesse il breviario, mi asperse d’acqua santa, e mi raccomandò di ripetere la prova altre due volte. Dopo i tre esperimenti, gli dissi che i miei dolori erano più intensi e che non avevo risentito alcun miglioramento. Allora il reverendo Pes mi confessò addirittura, [99] che egli si trovava in una condizione eccezionale. Anche lui era un fatturato, per legatura fattagli da un prete nemico, il cui potere era maggiore del suo. A ciò dovevo attribuire la vera causa dell’inefficacia degli esorcismi[11].
Non volendo lasciare intentato alcun mezzo per riacquistare le perdute forze, mi decisi a consultare un bravo agricoltore florinese, potentissimo nell’arte degli esorcismi.
Il metodo seguito da questi profani era d’ordinario il seguente. Anzitutto l’esorcista doveva operare dopo un intimo colloquio colla propria moglie. In seguito si muniva di un archibugio sardo, che avesse già servito ad uccidere un uomo, e si recava col paziente ad una vigna, i cui viali fossero disposti in croce. Fatto collocare il malato in un crocicchio, gli appoggiava alla schiena il calcio del fucile, e gli ordinava di far fuoco in quella posizione, portando all’indietro la mano per far scattare il grilletto. Partito il colpo, la legatura era sciolta.
Per due volte l’esorcista ripetè l’esperimento, ma senza alcun vantaggio per me. Finalmente mi disse con dolore:
— È questa la prima volta che fallisce la mia prova. Dunque una mano potente pesa [100] sul tuo capo, e non ti resta che raccomandarti a Dio.
Queste parole mi colpirono vivamente, e quasi ne piansi. Per fortuna, in quei giorni, i dolori mi diedero un po’ di tregua, e non perdetti del tutto la speranza della guarigione.
[101]
Gironzando una sera per le vie del villaggio, in preda ai miei cupi pensieri, mi fermai dinanzi alla casa d’un amico, a breve distanza da quella dei genitori di Maria Francesca.
— Com’è che non vi maritate ancora? — mi chiese l’amico.
— Il prete non vuole! — risposi sbadatamente.
— E che c’entra il prete? Se tu ce lo consenti, noi parleremo il padre e la madre della ragazza. Sono nostri vicini, e siamo in ottimi rapporti.
— Fate come volete! — dissi, e continuai la mia strada.
All’indomani l’amico venne a dirmi, che i genitori di Maria Francesca nulla sapevano del matrimonio, ma che avrebbero scrutato l’animo della figliuola per darmi una risposta.
Ringraziai l’amico ed attesi. La risposta mi fu data tre giorni dopo, ed era consolante. Maria Francesca acconsentiva a diventare mia moglie.
[102]
Fattomi coraggio, mi presentai ai genitori della ragazza. Dopo avermi confessato che il prete contrariava questo matrimonio, essi conchiusero:
— Non devi per ciò disperare; se il prete non lo vuole, lo vogliamo noi. Siamo contenti che la nostra figliuola diventi tua moglie, e che tu diventi figlio nostro!
— Il vostro consenso mi consola; ma non mi basta. Vorrei scambiare alcune parole con Maria Francesca, qui, alla vostra presenza. Datemi un appuntamento.
Pochi giorni dopo mi ripresentai a Salvatore, il quale mandò un suo figliuoletto in casa del prete Pittui, per dire a Maria Francesca che la mamma aveva bisogno di lei.
Il cuore mi batteva forte, e i minuti mi parevano secoli.
A un tratto Maria Francesca comparve sulla soglia, e vi rimase indecisa alcuni secondi; indi si fece avanti lentamente, col capo chino e le braccia conserte. Era impacciata, commossa.
Ruppi per il primo il silenzio:
— Che dici tu, Maria Francesca, di quanto accade?
— Io non so che cosa dire. Han cominciato col farmi sapere che avevi chiesto la mia mano, e si finì coll’avvertirmi che non sarei stata più tua moglie. Le ragioni non vollero dirmele.
— Anzitutto devi manifestarmi il tuo sentimento. Se tu mi vuoi bene quanto io te ne voglio, [103] i contrasti cesseranno subito, poichè nessuno potrà impedire la nostra unione!
A questo punto la ragazza levò la testa, ed esclamò ingenuamente:
— Quando il prete e la zia mi fecero sperare che questo matrimonio si sarebbe effettuato, io ne fui contentissima, poichè fra i giovani del paese tu eri il prescelto dal mio cuore. Aggiungo adesso, che, se tu mancherai alla parola, io uscirò dalla casa del prete per servire altro padrone... e non prenderò più marito!
— Io non ho mai mentito, e la mia parola è sacra. Mi chiamo Giovanni Tolu, sento di essere un giovane onesto e laborioso, e prometto di renderti felice. Non ti darò mai motivo a pentirti di avermi scelto per compagno!
Così dicendo mi avvicinai alla ragazza e soggiunsi:
— Qui, alla presenza del babbo e della mamma, voglio darti il primo bacio: sarà caparra solenne del sacrosanto matrimonio.
E dopo averla baciata sulla guancia, le dissi:
— Questo bacio era tuo da lungo tempo, ma non potevo mandartelo con altri. Serbalo come saldo pegno dell’amore che ti porto, e affidati a me![12]
[104]
Maria Francesca, per la prima volta, levò la testa per guardarmi negli occhi; poi arrossì, mi sorrise, e andò via quasi bruscamente, senza salutare nessuno.
Da quel giorno mi parve di star meglio e di aver lo spirito più tranquillo. Visitavo assai spesso la casa del mio futuro suocero, ed aspettavo con ansia il giorno festivo, designato per gli appuntamenti, all’insaputa del prete. Non dimenticherò mai quel tempo felice e i dolci colloqui colla cara ragazza!
Sventuratamente la mia felicità fu di breve durata, poichè alla gioia succedette l’affanno. Le punture ai ginocchi ricominciarono, e i dolori acuti mi fecero accorto, che la maledizione del prete non voleva darmi tregua.
Fuori di me per lo spasimo, mi diedi alla ricerca di nuovi esorcisti per sottrarmi alle malìe. Dove mi s’indicava un esperto in quell’arte diabolica, io correvo come pazzo senza frapporre indugio, fosse anche in capo al mondo. Montavo a cavallo, e col pretesto degli affari visitavo tutte le cascine, tutti gli ovili, tutti i paesi dei dintorni — ma sempre inutilmente. Ero disperato.
Volevo farla finita colle fattucchierie del prete, ma prima volevo sposare Maria Francesca. L’influenza di quel sacerdote mi spaventava. Il mio malumore crebbe, quando un giorno mi rivolsi ai genitori della ragazza, dicendo loro che desideravo affrettare le nozze.
[105]
La madre tacque abbassando gli occhi; ma il padre mi disse con un certo tono fra l’agro e il dolce:
— Ti par proprio giusto, che noi dobbiamo affidare la figliuola ad un malato?
Quel tono amaro m’indispose, ed esclamai vivamente:
— Voi mi avete conosciuto sano... e ciò vuol dire che io potrò guarire. D’altronde vi comunico la mia risoluzione: — o fatemi sposare subito con Maria Francesca, o portateci entrambi dinanzi ad un parroco per scioglierci dalla promessa. Ciascuno penserà ai casi propri. Scegliete!
I genitori della ragazza si acquietarono; ed io mi diedi di nuovo attorno, in cerca di esorcisti.
Mi rivolsi nuovamente a diversi preti, i quali si dichiararono impotenti a lottare col mio jettatore.
Una sera mi recai a Tissi per consultarvi un famoso scongiuratore di legature. Prima di andare da lui, mi si volle far visitare un infermo fatturato, la cui moglie dicevasi fosse l’amica di un prete. Quel povero disgraziato, colpito da paralisi alle gambe, giaceva sulla paglia di un tugurio, in preda a spasimi atroci.
Mi tolsi raccapriciando a quella spettacolo orribile.
— Se io diventassi come costui — dissi — sarei rovinato per tutta la vita!
Non volli ritornare a Florinas. Passai la notte [106] a Tissi, e l’indomani mi spinsi fino ad Uri per sottopormi alle cure di un maestro di esorcismi, indicatomi come valentissimo.
Ma i dolori continuavano.
Sempre alla ricerca dell’uomo che doveva guarirmi, io trottai all’impazzata da un paese all’altro, finchè mi decisi a far ritorno a Florinas, dopo un’assenza di tre giorni.
Un caso singolare, avvenutomi in quella circostanza, contribuì ad agitare nuovamente il mio spirito. Voglio narrarlo, per persuadere gli increduli, che le legature non sono un parto di mente inferma.
Giammai, come in quei tre giorni, io aveva provato la smania tormentosa di rivedere Maria Francesca. Mi pareva di esserne lontano un secolo. Diedi di sprone al cavallo e trottai come un forsennato fino alla casa di mia madre. Ivi appresi che il prete, durante la mia assenza, aveva licenziato la servetta, inasprito per le nozze stabilite senza il suo consenso.
Smontato di sella, affidai il cavallo a mio fratello Peppe, e mi avviai sollecito alla casa dei genitori della ragazza.
Come posi piede sulla soglia, mi sentii avvinto da un misterioso fascino, che non seppi spiegare. La viva smania di rivedere la sposa diletta si era cambiata in un’avversione invincibile. Una forza occulta mi respingeva da lei; la sua vista mi metteva quasi ribrezzo; ond’io le volsi [107] bruscamente le spalle, e continuai a parlare coi genitori, senza rivolgerle la parola, senza stringerle la mano, e senza baciarla sulle guancie, come al solito. Temevo persino il contatto delle sue vesti, poichè avevo la convinzione che esse mi avrebbero scottato. Rimasi là come intontito, paralizzato, subendo l’influsso malefico del prete, che si vendicava di me. Ad un tratto, non potendo più oltre resistere, mi precipitai fuori della porta, e mi diedi a correre. Mi pareva di essere inseguito da una furia infernale.
Quando rientrai in casa, mio fratello Peppe mi venne incontro agitato:
— Il tuo cavallo è tutto gonfio! — gridò pieno di spavento.
— So di che si tratta! — risposi cupo; ma non dissi che il prete n’era la causa, poichè le sue malìe si erano estese anche alla bestia che mi aveva venduto.
— Il tuo cavallo sta male... e forse muore! — ripetè mio fratello.
— Lascia ch’esso muoia, nè dartene pensiero! — esclamai con profondo dolore — Tutti moriamo, e morrò anch’io fra non molto!
La mamma e le sorelle si scambiarono un’occhiata, non riuscendo a spiegarsi lo strano senso delle mie parole.
[108]
Il mio cavallo non morì, e i miei dolori si calmarono. Approfittai della tregua per sollecitare presso la famiglia di Maria Francesca i preparativi degli sponsali. I parenti accondiscesero al mio desiderio.
Si andò anzitutto dal parroco per sottoporci all’esame della Dottrina, come l’uso voleva. Il parroco rinunziò ad interrogarmi, perchè molte volte gli avevo assistito la messa e mi sapeva addentro nelle pratiche religiose. Si limitò ad esaminare Maria Francesca, e si accorse, che, sebbene educata in casa di un prete, ella ben poco ne sapeva.
Il parroco disse, a me rivolto:
— Se si fosse trattato d’altri, e se io non vi sapessi in condizioni speciali, mi sarei ben guardato dal permettere le vostre nozze. Ma questa volta voglio passarvi sopra. A te specialmente raccomando d’istruire la sposa nella dottrina cristiana.
[109]
— Ne prendo impegno! — risposi con un certo orgoglio — sapete pure che sono stato sagrestano!
Ottenuto l’assenso del parroco, vennero fatte in chiesa le pubblicate d’uso per due sole domeniche, avendoci la Chiesa dispensato dalla terza, com’è d’obbligo.

La mattina del 17 aprile 1850 fu designata per lo sposalizio.
Ci eravamo confessati entrambi dal parroco, ed assistemmo alla messa, celebrata dal prete Pittui, il quale non aveva avvertito la nostra presenza. Quando ci scorse, non potè contenere un movimento di dispetto. Pareva un diavolo sull’altare!
La cerimonia venne compiuta senza pompa, senza codazzo di parenti e di amici, poichè non volli la compagnia di nessuno, togliendo pretesto dalla malattia che mi tormentava e dai contrasti che avevano preceduto il mio matrimonio.
Assistettero alla funzione mio fratello Peppe [110] e mia madre. I genitori della sposa non vollero inasprire colla loro presenza il prete Pittui.
Sulle prime si pretendeva che, per un po’ di tempo, noi si vivesse separati, cioè a dire, la sposa presso i genitori ed io in casa di mia madre. Mi opposi vivamente, dicendo a Maria Francesca:
— Noi siamo marito e moglie, e dobbiamo mangiare, dormire, e vivere insieme. Se saremo lontani l’uno dall’altra, non mangerai tu, nè mangerò io. In casa mia ci ho grano, ci ho lardo, ci ho fave e fagiuoli — dunque possiamo vivere del nostro, indipendenti.
Secondando il mio desiderio, i genitori di Maria Francesca combinarono di offrirci parecchie stanze nella casa attigua alla loro. Accettai, quantunque a malavoglia.
Dopo la benedizione del prete fu apprestato il pranzo di nozze in casa di mia suocera. Ricevetti dai parenti molto bestiame in dono; alcuni mi regalarono un vitellino od una pecora, altri un montone od un maialetto.
Volli far parte di un grosso castrato alla zia di Maria Francesca, la serva del reverendo Pittui; la quale, in ricambio, mi regalò un barilotto di vino, che mandai subito in casa di mia madre. Non volli berne, perchè proveniva dalla casa del prete, e temevo fosse fatturato a mio danno.
All’indomani ci ritirammo nella nostra casetta provvisoria, e facemmo il pranzetto da soli, [111] come due colombi innamorati, felici d’essere finalmente uniti per tutta la vita.
Appena ritirati nel nostro nido, dissi alla sposa:
— Bada bene: la prima pietanza che uscirà dalla nostra cucina, voglio che sia mandata a tuo padre ed a tua madre. È questa la mia opinione, e il nostro dovere!
Durante i mesi di aprile e di maggio la nostra vita trascorse serena. Si viveva in perfetta armonia, fra il riso più schietto e le carezze più affettuose, sempre fantasticando progetti d’ogni genere per migliorare il nostro avvenire. Eravamo ancora giovani: — io contavo ventott’anni, e mia moglie diciasette. Sentivo d’essere contento di me e di lei. Maria Francesca era una pura e ingenua ragazza, piena di attrattive, tutta premure per me, e docile come un agnello ad ogni mio comando.
Si avvicinava intanto la stagione della messe, ed io doveva pensare a dedicarmi con lena al lavoro, per tirare innanzi dignitosamente, senza bisogno di ricorrere all’altrui soccorso.
Il mestiere dell’agricoltore è faticoso, ed è col sudore della fronte che si guadagna il pane quotidiano. Io dissi a Maria Francesca:
— Siamo alla messe, ed è mestieri che io cerchi lavoro. Tu sei troppo giovane ancora, delicata, e non hai l’abitudine di lavorare in campagna, sotto la sferza del sole, affrontando disagi [112] e patimenti. Cercami dunque una spigolatrice di tuo gradimento, e tu cura con agio le faccende domestiche, conservandoti sana e fresca.
Maria Francesca mi fissò lungamente, e mi disse con affettuoso risentimento:
— Come! ed hai potuto così prestò dimenticarmi? Hai tu bisogno di altre, quando io mi sento capace di far la spigolatrice?
— Codesti sono capricci da bambina! — risposi — Non sai tu che il non aver spigolatrice sarebbe una vergogna per me ed un danno per la casa? Mentre colei che spigola avrà un lucro, tu potrai sorvegliare la nostra casa, ed io penserò a tutto. Il lavoro dei campi è molto grave, bambina mia! ed io non voglio aver questioni co’ tuoi parenti!
E siccome Maria Francesca persisteva nel suo proposito, credetti mio dovere avvisarne i genitori, perchè la persuadessero.
Mia suocera disse alla figliuola:
— Lascia le pazzie, e scegli una spigolatrice di tua fiducia. Non è conveniente che tu ti esponga a simile fatica. Bada! chè non abbia ad essere tardo il tuo pentimento! poichè una volta sul posto, dovresti starvi a costo di crepare!
Non ci fu verso di persuaderla, nè colle buone nè colle minaccie. Mia moglie dichiarò recisamente, che la spigolatrice voleva essere lei.
Ero stato invitato a far la messe nella Nurra — regione lontana cinque o sei ore dal nostro paese, e da me con frequenza visitata.
[113]
Venuto il giorno della partenza, Maria Francesca si mostrò esitante; tirò fuori non so quali dubbi, e finì per dire che non voleva più seguirmi.
Questo repentino cambiamento all’ultim’ora mi creò degli impicci. Era avvenuto quanto avevo pronosticato. Il babbo, sulle furie, impose alla figliuola di recarsi alla Nurra, giacchè ella stessa ne aveva fatto la proposta.
Dai proprietari nurresi ero stato preposto alla direzione della messe, ed avevo l’incarico di far la scelta degli uomini componenti la brigata. Come capo dei mietitori dovevo pensare alla sorveglianza, all’ordine del lavoro, nonchè a preparare la cena.
Avevo portato meco alla Nurra tutti i miei fratelli, le mie sorelle, i cognati, e non pochi amici compaesani, per poter così contare sull’abilità, sull’attività e sulla disciplina de’ miei dipendenti.
I salti nei quali dovevo eseguire la messe erano due, di diversi proprietari: — quello in Giumpaggiu, di Vincenzo Pasquino, e quello in Abba-meiga di Gianuario Agnesa.
Eseguita la messe, venne la volta della trebbiatura. Destinai al primo salto Peppe (mio gemello), Giammaria e Maria Andriana, ritenendo per me il secondo salto, dove mi recai con mia moglie e con Giustina, volendo così equilibrare coll’opera mia solerte l’insufficienza delle mie deboli [114] compagne. Sbrigai la bisogna in sole quattr’ore, trebbiando diciasette corbule di grano.
La nostra permanenza alla Nurra fu di dieci giorni. Maria Francesca resistette fino alla fine della campagna, ma non tardò a dichiararsi stanca e ammalata, come avevo preveduto. Non abituata, al par di noi, ai penosi lavori dell’aia, ella non potè sopportare i caldi afosi del giorno, nè l’umido delle notti; dippiù la poveretta era incinta da un mese, e soffriva molto.
Terminati i lavori della messe tornammo insieme a Florinas, dopo esserci fermati a Sassari un giorno ed una notte per ritirare le paghe dai proprietari dei salti. In quest’ultima città volli fare diversi acquisti per contentare Maria Francesca; la quale, trovandosi in istato interessante, esternava certe voglie che bisognava ad ogni costo soddisfare, per non recar pregiudizio al nascituro. Le comprai, fra gli altri oggetti, un elegante grembiale a vivi colori, ed un fazzoletto da testa, che gradì moltissimo.
Arrivati a Florinas, affidai a Maria Francesca il governo della casa; ed io mi diedi nuovamente attorno per cercar lavoro in campagna, per mio conto, e per conto della famiglia di mia madre; perocchè avevamo preso in affitto (per lo più a mezzadria) alcune terre appartenenti alle chiese di Florinas.
Coll’aiuto del mio cavallo, l’inseparabile Moro, io cercava ogni mezzo per guadagnare qualche [115] soldo; poichè il lavoro era per me un bisogno, un conforto, una vera passione — e non lo dico per volermi vantare!
Tornavo ogni volta a casa così soddisfatto, così contento, che mi pareva di aver dimenticato le soperchierie del prete, i malumori di mio suocero, e i dispetti dei parenti di Maria Francesca.
[116]
Durante le mie assenze da Florinas — o per darsi svago, o per non voler rinunziare alle antiche abitudini — Maria Francesca soleva frequentare la casa del prete, col pretesto di andar a trovare la zia. Così pure si piaceva di visitare or l’uno or l’altro de’ suoi parenti, i quali si divertivano a renderla ribelle a’ miei consigli. Mia moglie era una buona ragazza, ma piuttosto credenzona, facile ad impressionarsi, e sovratutto ciarliera in modo singolare. Lo star sola in casa le dava noia, e la rendeva curiosa dei fatti altrui.
Quando rincasavo ella tirava fuori questioni nuove, nuovi quesiti, e mi metteva a parte di qualche nuovo pettegolezzo; ond’io, che conoscevo l’indole sua e il suo carattere, non tardai ad avvedermi che le chiacchiere dei parenti e delle comari le riscaldavano la testa. Pareva, insomma, avesse preso il partito di ricondurmi sulla buona via, con ammaestramenti che facevano a pugni col buon senso.
[117]
A me, giovane piuttosto serio, di poche parole, poco espansivo, questo stato di cose dava ai nervi; e un po’ colle buone, un po’ colle brusche, cercai di correggere mia moglie:
— Bada! — le dicevo — se darai retta a me, potrai trovarti bene; ma se ascolterai i consigli degli altri te ne avverrà male!
Un’altra volta la ripresi:
— Non voglio che tu vada così spesso in casa del prete, poichè egli mi vede di mal occhio, io non sono cane da star sotto tavola, nè vado a leccare i piatti di nessuno. Se il prete ha bisogno di me, sa dove trovarmi; ma intendo di essere il padrone in casa mia. Eppoi..... non voglio prestarmi ad alimentare certe dicerie... Hai capito? Mi accorgo pur troppo, che quando vai fuori di casa ne ritorni colla testa piena di corbellerie. Pensa alle faccende domestiche, e non immischiarti nei fatti degli altri. Se farai altrimenti, le cose cambieranno... te lo prevengo!
E dopo questa avvertenza montavo a cavallo, e correvo da paese in paese a trasportar grano per conto mio, o per conto altrui, superando i miei compagni nel numero dei viaggi.
Quando poi si faceva la raccolta in casa di mia madre, lavoravo alacremente: — lasciavo due porzioni alla famiglia, e ritenevo per me la terza parte, come d’uso, per la dote dell’uomo. Le donne, d’ordinario, impiegano la loro porzione nell’acquisto di lingeria e di masserizie per preparare il corredo nuziale.
[118]
Io dunque, oltre ai guadagni propri, contavo sul modesto patrimonio di famiglia, e lavoravo con lena per accrescerlo a vantaggio mio, e a vantaggio della mamma, dei fratelli e delle sorelle.
Continuarono pertanto i piccoli dissidî nel mio nido coniugale.
Un giorno avevo fatto aggiustare il basto del mio cavallo, e, per mie vedute speciali, ero rimasto debitore del saldo di tre reali al falegname. Rientrato in Florinas dopo alcune sere, appresi che mia moglie, senza ordine alcuno, aveva soddisfatto il mio debito. Mi spiacque la sua intromissione, e la rimproverai:
— Tu non hai debiti da saldare per conto mio! — le dissi — Li salderò io, quando lo crederò conveniente. Lascia il mal vezzo di andare attorno per far chiacchiere inutili, che mi compromettono. Rimani a casa! — io non m’immischio nel tuo lino e ne’ tuoi lavori di cucito. Fa tu altrettanto!
Le comari del vicinato, a cui mia moglie faceva le confidenze, si divertivano ad aizzarla contro di me; ed io non tardai a scorgere in lei un certo freddo riserbo ed un’asprezza di modi, che non erano nel suo carattere abituale. Ne fui piccato, ma tacqui.
Una sera Maria Francesca osò rinfacciarmi, che una mia zia conviveva con un compagno, che non le era marito.
[119]
— Che sai tu di queste cose? Se tu rimanessi a casa, nulla sapresti di mariti falsi e di mogli illegittime!
Invece di accettare i miei consigli, Maria Francesca persisteva a vivere nel pettegolezzo; e giunse a tanto, che un giorno si ridusse a confidarmi, che una nostra vicina mi aveva chiamato faccia di cane!
— Le dirai che è in errore! — le risposi con pazienza affettata. — Quella donna un giorno voleva lusingarmi a prendere in moglie una sua sorella, ch’era stata in corrispondenza illecita con altri. La mia faccia, così simpatica allora, è diventata cagnesca dietro il mio rifiuto. Ti ripeto che non voglio più sentire simili spropositi; e se tu persisterai a raccogliere per strada i pettegolezzi dei parenti e delle comari, finirò per farti conoscere chi sono io!
Essendosi accentuato il nostro diverbio, e costretti entrambi a gridar forte, non tardarono le vicine di casa, comprese le zie, a farsi all’uscio di casa mia, minacciandomi della loro collera se avessi osato toccare un capello a Maria Francesca.
Era il colmo della sfacciataggine. Mi feci sul limitare della porta e gridai infuriato:
— Chi siete voi?! Toglietevi subito alla mia presenza e sgombrate la strada; chè altrimenti con un ceffone vi mando tutte a gambe in aria!
Ci volle tutto l’aiuto di Dio per far intendere [120] un po’ di ragione a quelle pettegole; le quali si allontanarono brontolando, poichè sapevano ch’ero uomo da mettere in pratica le mie minaccie. Tuttavia mi contenni, e mi limitai per quel giorno ad ammonire severamente mia moglie, avvertendola che avevo bisogno di quiete e di tranquillità per poter lavorare.
— Bada, Maria Francesca! il mio individuo è diviso in due parti: io sono per metà dolce e per metà amaro. Datti alla parte del miele se vuoi vivere felice; chè se mi stuzzichi dalla parte opposta, finirò per amareggiarti la vita!
Intanto pensai ch’era tempo di sloggiare da quelle due stanze provvisorie; le quali, essendo attigue all’abitazione dei parenti, diventavano causa permanente de’ miei litigi in famiglia...
Da più settimane andavo in cerca di una casa che fosse di pieno gradimento di mia moglie; ma costei, forse suggerita dai parenti, indugiava nella scelta.
Finalmente ne trovai una che piacque a Maria Francesca. Pattuito il prezzo col padrone, ringraziai la Madonna di tutto cuore, credendo di potermi alfine sottrarre al sindacato noioso di mia suocera.
Si era vicini al Mezzagosto. È costume in Florinas di cambiar di casa alla vigilia dell’Assunta: giorno in cui ciascuna famiglia dev’essere a posto.
Quando tutto fu combinato, disposi per il [121] trasporto delle legna e del grano, che avevo in deposito in casa di mia madre.
La mattina della vigilia dell’Assunta, mentre mi disponevo a trasportare le masserizie, Maria Francesca mi fece intendere che sarebbe stato meglio sospendere ogni cosa.
— Perchè? — le chiesi sorpreso.
— Perchè io non ci verrò!
— Non ci verrai?!
— No.
— Ed io come devo fare?
Mia moglie tacque.
Il sangue allora mi montò alla testa, divenni cieco, e diedi a quella matta uno schiaffo così forte, che le fece saltare un’orecchino in mezzo alla strada.
Maria Francesca si diede a piangere ed a strillare. Accorse la madre, la quale riuscì a calmarci, dicendo che ci voleva a pranzo in casa sua, e che al trasporto si sarebbe pensato il giorno susseguente a quello dell’Assunta.
Cedetti al suo desiderio e mi contenni.
Non uno, ma due giorni dopo — il 17 agosto — dissi pacatamente a mia moglie:
— La festa è ormai finita. Ora possiamo andare. Ho pronto il cavallo per il trasporto delle masserizie.
— È inutile, poichè io non ci vengo più! — mi rispose bruscamente quella caparbia, forse incoraggiata dalla presenza della madre.
[122]
— Ma non sai tu — soggiunsi — che io sono capace di chiamar qui tuo padre, per darti una lezione e per costringerti a seguirmi?
A queste parole mia suocera uscì fuori, certo per prevenire il marito in favore della figlia.
Vedendo tornar vano ogni mezzo di persuasione, piantai quella matta, e mi accostai alla soglia della casetta di mio suocero:
— Salvatore, vieni fuori, chè tua figlia desidera parlarti!
Mio suocero entrò in mia casa, ed io gli tenni dietro. Egli chiese alla figlia con tono imperioso:
— Che vuoi da me?
— Non ho chiesto di lei — rispose Maria Francesca, cogli occhi bassi.
E allora io:
— Ebbene, giacchè tua figlia non ha nulla a dirti, ti parlerò per conto mio. Sappi che mia moglie mi ha fatto impegnare nel fitto di due case, e che ora si rifiuta ad abitarle. Che cosa dici tu?
Salvatore, già istigato da mia suocera, mi si piantò dinanzi cogli occhi spalancati, e gridò con voce alterata dall’ira:
— Dico, che tu sei un poco di buono, un cattivo soggetto, un birbante matricolato!
A questo punto Maria Francesca, prevedendo la tempesta, scappò fuori in istrada per cercar rifugio nella casa paterna.
[123]
Mio suocero, inferocito, si die’ a correre come pazzo intorno alla stanza, dando di piglio ad effetti ed a mobili per gettarli sulla strada — come per farmi capire che non voleva in sua casa nè me, nè le robe mie.
Il sangue mi montò alla testa; pure mi contenni, e dissi con calma:
— Se non avessi per te il rispetto che si deve ad un padre, ti prenderei per i piedi e ti sbatterei al muro!
Salvatore afferrò un tavolo e lo smosse, come per volerlo buttar fuori; allora perdetti la pazienza, e dato di piglio al mio fucile gli gridai risoluto:
— Se tu tocchi un altro oggetto per buttarlo in strada, giuro che con esso usciranno le tue cervella!
Spaventato dal mio volto acceso e dall’arma che impugnavo, Salvatore si fermò di botto; indi saltò in strada, gridando a squarciagola:
— Accorrete! accorrete! Giovanni Tolu mi uccide!
Il grido di Salvatore ebbe il suo effetto. Tutte le comari si fecero in sull’uscio di casa; molte finestre si spalancarono con fracasso; dallo sbocco delle vie vennero fuori a frotte uomini, donne, ragazzi; così che in poco d’ora un’onda di popolo faceva ressa dinanzi alla mia soglia. Vidi, fra gli altri, arrivare il sindaco (il medico dottor Serra, di Giave), e poco dopo il prete [124] Pittui, il quale più degli altri pareva in preda ad un’agitazione nervosa.
La folla tumultuava, e il sindaco gridò con voce autorevole:
— Andate per i fatti vostri! Ogni cittadino ha il diritto di non venir disturbato nel proprio domicilio!
E pronunziate queste parole si allontanò, esortando la folla a ritirarsi.
Dopo aver rimesso a suo posto il fucile, io guardai freddamente quella frotta di curiosi, che si divertivano a cacciarmi gli occhi addosso. Nessuno però volle azzardarsi a varcare la soglia della mia casa.
Uno solo l’osò: il prete Pittui. Con passo fermo, ma con un tremito per tutta la persona, egli si aprì un passaggio tra la folla e si avanzò verso di me colle mani in tasca: carezzando certamente l’impugnatura delle pistole, che soleva portare sotto la sottana.
Entrato arditamente nella stanza, il prete Pittui mi lanciò un’occhiata fulminante:
— Tu hai girato la scatola! — mi gridò con aria di minaccia. — Sei un miserabile, un birbante, un bastardo!
Frenai a stento la bile, e risposi con calma, accentuando le parole:
— Ella s’inganna, reverendo! Io sono il figlio di Pier Gavino Tolu e di Vincenza Bazzone. Tutti conoscono in paese mia madre, come conoscevano [125] mio padre. Non sono quindi un bastardo, come dice! E se anche mia madre fosse una disgraziata, a lei non spetta insultarla, poichè per tre volte le fu compare di battesimo!
Il prete ripetè l’insulto; e allora io diedi un’occhiata sotto al letto, dove per solito riponevo la scure. Fu per lui fortuna, che quel giorno l’arma fosse in fondo, in modo che il manico non si trovasse alla portata della mia mano. Ero deciso di spaccargli la testa e di farla finita.
Dopo aver detto al mio indirizzo un mondo d’insolenze, il prete uscì in piazza sbuffando, e accostandosi alla casa di mio suocero, gridò forte, in modo che tutti lo sentissero:
— Ritirate la vostra figliuola in casa, e non dategliela mai più!
E dopo avermi fissato un’ultima volta con piglio minaccioso, si allontanò lentamente come era venuto, sempre colle mani nelle tasche della sottana.
Rimasi solo nella stanza terrena, risoluto di commettere qualche eccesso.
Due ore dopo venni avvertito che il prete aveva incaricato Giovanni Antonio Piana (il marito della sua serva) di cacciarmi fuori di casa. Avevo preveduto il tiro, e stavo aspettandolo, pronto a fargli fuoco addosso se avesse osato varcare la mia soglia.
Verso l’imbrunire, infatti, vedendolo avvicinare, presi in mano il fucile.
[126]
Le donne del vicinato gli corsero tutte incontro e lo fermarono; e Pietro Rassu, il mio vicino di casa, gli gridò con mal piglio:
— Che fai disgraziato? Ha torto chi ti manda, e tu hai più torto ad ubbidire. Non vedi che Giovanni Tolu ti spaccierà con una fucilata?
Due giovani robusti presero a braccetto Giovanni Antonio Piana, e lo trascinarono a viva forza in altra via.
Quella notte non andai a letto. Temendo una sorpresa, e volendo farla pagar cara, lasciai l’uscio socchiuso, e sedetti in un canto, senza deporre un istante il mio fucile.
[127]
Il mio stato era angoscioso. Solo, sconfortato, in odio a tutti, non sapevo a qual partito appigliarmi per uscir d’impiccio. Io dissi a me stesso:
— È mai possibile che al mondo non vi sia giustizia per un povero diavolo? Come dovrò contenermi in un paese, dove i preti ed i nobili comandano? A chi dovrò ricorrere quando nobili e preti sono intesi coi giudici, e la peggio tocca ai zoticoni pari miei?
Come spuntò l’alba del giorno seguente presi una risoluzione. Montai a cavallo, venni a Sassari, e mi presentai all’Intendente, ch’era un continentale[13]. Gli esposi schiettamente i miei casi, ed invocai un provvedimento per evitare un maggior disastro.
[128]
— Scriverò io al sindaco — mi disse l’Intendente — Tornate pure a Florinas, e state di buon animo!
Rientrato in paese, seppi che la lettera non era pervenuta al dottor Serra, poichè il caso l’aveva fatta capitare nelle mani del prete.
Tre giorni dopo mi presentai di nuovo all’Intendente per informarlo dell’accaduto. Sorpreso del caso, egli scrisse un’altra lettera, che mi porse, dicendo:
— Consegnatela voi stesso in proprie mani del sindaco, e fate in modo di dargliela alla presenza di testimoni.
Il sindaco, già da me informato, esclamò dopo aver letto il foglio:
— Io farò il mio dovere, e s’impicchi chi vuole!
Seppi in seguito, che l’Intendente aveva ordinato al Sindaco d’invitare Maria Francesca ed il babbo a recarsi in Sassari per conferire con lui. Il prete, richiesto di consiglio, aveva suggerito a mia moglie ed a mio suocero di dichiarare all’autorità, ch’io li avevo entrambi minacciati di morte, e che ogni riconciliazione sarebbe stata impossibile.
E così riferirono. L’Intendente fece loro comprendere che il matrimonio era sacro, e che bisognava fare la pace; ma tanto il padre, quanto la figlia, persistettero nella determinazione di tenermi lontano dalla casa coniugale.
[129]
Il capo del Governo di Sassari non si diede per vinto, ma mandò a Florinas un suo segretario, coll’incarico di adoperarsi per il nostro buon accordo.
Nè preghiere, nè minaccie valsero a far smuovere mio suocero e Maria Francesca dal loro proposito. Entrambi si rassegnarono a pagare una multa (non so per quale articolo di legge) ma si mostrarono inflessibili.
Tornato la terza volta dall’Intendente (per informarlo della pertinacia del prete e di mio suocero, che si ostinavano a volermi separato da Maria Francesca) quel cortese funzionario mi disse:
— Senti: se tu mi dichiari d’esserne contento, io mi varrò della facoltà che mi accorda la carica, per far tradurre a Sassari tua moglie, scortata dai carabinieri o dai luogotenenti[14].
Presi riserva a rispondere più tardi, volendo prima consultare mia madre. Questa mi disse:
— Non mi piace simile provvedimento. Maria Francesca è tua moglie: oggi siete separati, e domani potreste riconciliarvi. Io non voglio, nè tu devi permettere la vergogna e lo scandalo di farla arrestare!
— Non sono del tuo avviso — risposi — Sarei contento di vederla in carcere, se non altro [130] per far dispetto al prete; il quale, co’ suoi consigli, è stato causa unica di quanto è avvenuto.
— Ti ripeto ch’io non voglio scandali e vergogne, che farebbero mormorare il paese! — ripetè mia madre, con tono di comando.
— Ebbene, farò quanto desideri; ma che non si parli più di conciliazione. Noi saremo separati, e per sempre!
Quel giorno stesso dissi a mia suocera, perchè lo riferisse al marito ed alla figlia:
— Siete miserabili! Voi avete voluto che Maria Francesca fosse separata da me, ma non tarderete a pentirvene. Farete di lei la sgualdrina del villaggio!
***
Eravamo nel mese di settembre, e tre frati erano venuti a Florinas per le solite Missioni. Ero andato a confessarmi dal rettore, ed avevo adempiuto a tutte le pratiche religiose prescritte per la circostanza.
Fra gli obblighi delle Missioni era quello di metter pace tra le famiglie nemiche ed i coniugi separati.
Fui chiamato in casa del vice parroco Antonio Fiori, presso il quale i tre missionari erano alloggiati.
Il più anziano dei frati, ch’era il più autorevole, prese a parlarmi presso a poco così:
[131]
— Giovanni Tolu, perchè non ti ricongiungi a tua moglie? La vita che menate è scandalosa, e siete entrambi in peccato mortale. Tornate insieme e fatela finita, poichè il matrimonio è uno dei sette sacramenti. Noi siamo qui venuti per istruire il popolo, riconducendolo sulla via della salvezza per opera dello Spirito santo. La pace domestica è il supremo dei beni mondani; e quanto più grande sarà il tuo sagrifizio, tanto più accetto tornerà al Signore il tuo ravvedimento. Non dubitare: noi ci adopreremo perchè il prete Pittui più non s’ingerisca ne’ tuoi affari; tu così non avrai più alcun motivo a dolerti di lui. Che rispondi?
— Io rispondo: che Maria Francesca mi ha fatto prendere in affitto due case, e non ha voluto in seguito abitarle con me. Io rispondo, che la prima volta che l’ho chiesta in moglie dichiarai che rinunziavo alla dote, perchè mi bastava il suo amore; ma che adesso (se dovrò abbassarmi a ritirarmela in casa) pretendo che ella si provveda del necessario, secondo il costume del paese; e ciò perchè non abbia più a dipendere dai parenti. Rispondo infine: che essa deve risolversi, per ora, a ritirarsi in una delle due case da me scelte, dove anch’io mi recherò, quando lo crederò conveniente. A condizione, però, che i suoi parenti non vadano a farle visita.
Il frate osservò, scrollando le spalle:
— A simili umiliazioni una donna non deve sottomettersi!
[132]
— Ma questa è l’usanza nostra. Chi fa il peccato deve fare la penitenza — ed io non son tenuto a far la penitenza dei peccati degli altri.
Il missionario continuò con tono grave e solenne:
— Ravvediti, Giovanni Tolu, e fa la pace con Maria Francesca. Insieme al clero di Florinas noi verremo in processione fino a casa tua. Ivi impartiremo la benedizione ad entrambi, e vivrete felici per tutta la vita.
A questa predica sorrisi.
— Scusino, reverendi, ma queste mi sembrano mascherate. In siffatta guisa noi usiamo andare in carnevale da una bettola all’altra per bere un bicchiere di vino. Non potrei mai prestarmi a simili pagliacciate!
I tre frati fecero una smorfia disgustosa, ma tacquero.
Io tenni loro un simile linguaggio perchè trattavo i preti con molta confidenza. Ero stato sagrestano e sapevo il fatto mio.
I missionari si scambiarono un’occhiata — come per dire: con costui non faremo niente! — e mi congedarono.
Terminate le missioni, i tre frati lasciarono Florinas per recarsi ad altro villaggio. Appresi in seguito, che avevano parlato col prete Pittui, il quale certamente non era uomo da lasciarsi impressionare da tre zoccolanti.
[133]
***
Cominciai col rassegnarmi al mio destino. Avevo una spina nel cuore, ma affettavo di non sentirne dolore. I nostri conti erano saldati: l’autorità politica non era riuscita a persuadere mia moglie, come l’autorità ecclesiastica non era riuscita a persuadere me. Nondimeno debbo confessare, che non nutrivo rancore per Maria Francesca: lo nutrivo per il prete, che aveva istigato i parenti a rendermela ostile. Chi avrebbe osato in Florinas trascurare un consiglio di prete Pittui? Egli, famoso cacciatore, esperto tiratore al bersaglio, sindaco supremo del paese, mediatore di matrimoni, dispensatore di grazie e di castighi, fabbricatore di libelli, carabiniere, giudice, boia?!
Maria Francesca era incinta di quattro mesi. Il pensiero forse della sua gravidanza, e del bambino che sarebbe venuto al mondo, spinse i parenti a mutar consiglio. Partiti i missionari, sulla cui opera avevano contato, i parenti si erano raccomandati a tutti i cavalieri e ai più notevoli signori di Florinas per influire sul mio animo. Non pochi mi avevano avvicinato per esortarmi a farla finita e a ricongiungermi a Maria Francesca. Ma questa volta tenni duro. Le altalene non mi andavano a sangue.
— Come volete ch’io m’induca a pregar mia moglie, se essa mi ha scacciato? Dietro quanto [134] è accaduto, è lei che deve venire da me, non io che devo andare da lei. Se è vero che Maria Francesca mi vuole, perchè non viene a trovarmi?
Non dissi altro.
Mia moglie, dal canto suo, fu ostinata nel suo proposito. I consigli del prete Pittui, l’antico suo padrone, avevano più forza della parola d’un affettuoso marito!
Non poteva più oltre durare così — io perdeva il mio tempo. Pensai di ritornare al lavoro, unico sollievo e conforto nella sventura che mi era toccata. Ero stato marito per quattro mesi precisi — dal 17 aprile al 17 agosto — e dovevo ormai considerarmi come scapolo, o come vedovo.
La vista continua de’ miei nemici mi disgustava; ond’è che decisi di allontanarmi dal paese. Mi recai a Sassari, dove mi occupai nel trasporto del mosto e nel commercio delle granaglie. Misi in serbo una trentina di scudi.
Partiti i missionari da Florinas, ero stato di nuovo tormentato dai dolori alle giunture; ma il clima di Sassari mi giovo non poco.
Dopo un altro breve soggiorno a Florinas volli recarmi alla Nurra, dove il lavoro non mi mancava. Trascorso però un po’ di tempo, divenni di cattivo umore ed intrattabile, perchè i soliti dolori m’impedivano di lavorare coll’attività, che in me era natura.
Io sentiva la potenza malefica di quel prete [135] fatale, che continuava a perseguitarmi colle diaboliche legature. Crebbe il mio odio contro costui, autore d’ogni mia disgrazia.
— Se io non toglierò la causa del male, il male mi farà soccombere! — dicevo ferocemente a me stesso; e questo pensiero, come chiodo rovente, mi stava infisso nel cervello e nel cuore.
***
Venne intanto il dicembre colle giornate rigide, tempestose. Avevo l’umor nero. La solitudine mi pesava, perchè fantasticavo troppo.
Gli acuti dolori, che tratto tratto strappavano una contrazione nervosa al mio labbro, mi facevano imprecare come un dannato.
Si avvicinavano le feste di Natale, e mi sentivo più solo e più accasciato. Io, che avevo sognato una famiglia; che a furia di lavoro ero riuscito a formarmi un nido; ch’ero sul punto di diventar padre, mi vedevo relegato nelle solitudini della Nurra, senza casa, senza amici, senza gioie domestiche, e senza il conforto d’una parola affettuosa — neppure quella della mamma!
E tutto perchè? Per un prete sordido, prepotente, che voleva frapporsi fra me e Maria Francesca, spinto da uno scopo misterioso, ch’io non riusciva a spiegarmi
Temendo che i miei dolori aumentassero, deliberai di far ritorno a Florinas. Volevo almeno [136] passare le feste in famiglia — in casa di mia madre, dei fratelli, delle sorelle: nell’unica casa dove potevo fidarmi, dove ancora ero amato, carezzato, compianto.
— Avrei perdonato anche al prete, se io mi fossi sentito bene — dicevo con rammarico — ma con questi dolori la mia vita non potrà essere che un martirio. Bisogna finirla, e finirla presto! L’idea di diventare impotente, costretto a mendicare il pane altrui, mi spaventa. Parmi ancora di vederlo il povero mendicante di Tissi, paralizzato dalle legature! — Bisogna finirla, finirla, finirla presto!
Arrivai a Florinas due giorni prima di Natale. I parenti mi ricevettero con acclamazioni di gioia... ma non mi parevano contenti. Io leggeva negli occhi di mia madre il mio stato deplorevole; ella mi guardava ogni tanto alla sfuggita, con un sospiro, con un senso di pietà dolorosa, che si studiava nascondere per non affliggermi.
Un mese addietro i miei fratelli Peppe e Giomaria (per la prima ed ultima volta) mi avevano fatto intendere ch’erano disposti a far le mie vendette.
Ne fui spaventato e mi opposi energicamente.
— Guai a voi! Non voglio che v’immischiate ne’ fatti miei, nè adesso, nè mai! Basto da solo. Pur troppo io so fin dove arrivano nei nostri villaggi le gare, i puntigli, e gli odî di parte! Le famiglie si distruggerebbero. Pensate ai casi vostri — Dio penserà ai miei.
[137]
Il giorno di Natale la famiglia preparò un pranzetto d’occasione. Sedemmo in cinque a tavola: io, la mamma, Peppe, Giomaria e Maria Andriana.
I miei fratelli e la sorella si sforzavano di essere gioviali... ma nessuno lo era. Il mio tristo caso impressionava tutti.
Così passò il primo ed il secondo giorno di Natale. Io, che moriva dalla voglia di rivedere il mio paese, non vedevo l’ora di tornarmene alla Nurra. Troppe triste memorie racchiudeva per me Florinas, nè bastava l’affetto de’ miei cari per cancellarmele dalla mente.
[138]
Il terzo giorno di Natale — il 27 dicembre 1850 — mi alzai prima dell’alba. Avevo poco dormito e molto pensato. Ero d’umor nero, poichè avevo fantasticato sulla serie delle peripezie, che da un anno mi tenevano in angoscia. Tuttavia debbo dichiarare, che nessun pensiero sinistro aveva attraversato la mia mente durante quella notte insonne.
Dopo aver passeggiato da un capo all’altro della stanza terrena, tolsi la spranga alla porta e mi feci sulla soglia per esplorare il cielo.
L’alba spuntava. Era una giornata fosca, molto fredda. Il vento impetuoso soffiava da tramontana, e urlava fra i comignoli, facendo volare qualche tegola dai tetti.
Indossai il mio lungo cappottone di orbace, e tornai sull’uscio a respirare a pieni polmoni quell’aria frizzante, che pareva spegnesse la mia febbre. Sentivo lo stormire delle foglie degli alberi vicini, agitate dal vento.
[139]
Guardando distratto la campagna, verso Codrongianus, i miei occhi si fissarono sul tratto di strada che mi stava di fronte, la quale conduceva all’Oratorio di Santa Croce. Ricordai allora, ch’era la festa di San Giovanni evangelista, e che all’alba di ogni giorno festivo il prete Pittui soleva recarsi a dir messa in quella chiesetta fuori mano.
Per di là, dunque, sarebbe fra non molto passato quel prete: il prepotente, il fattucchiere, il nemico della mia pace.
Non so dire i pensieri che in quell’ora passarono a tumulto nella mia mente. So che rientrai nella mia stanza per spiccare dal capezzale del letto (dove per solito lo tenevo) il mio vecchio pistolone ad una canna. Nascosi l’arma sotto al cappotto, e tornai ad appoggiarmi allo stipite della porta, tenendo l’occhio sempre fisso sulla strada dell’Oratorio.
Il vento soffiava con più violenza, e i rami degli alberi si piegavano verso terra, quasi minacciando di spezzarsi.
Il temporale pareva imminente. Avevo preso un’istantanea risoluzione, e dovevo ad ogni costo compierla.
— Ma, chi lo sa? — pensai — forse il prete Pittui non uscirà di casa con questo tempaccio; la messa la dirà più tardi.
Non so dire se in quel momento io desiderassi, o temessi un contrattempo. Ero fuori di me.
[140]
Certo è però, che quell’uomo doveva essere in cammino, poichè sentivo due acute punture ai ginocchi. Avevo bisogno di romperle, da una buona volta, quelle legature insopportabili!
Finalmente, verso le sei, vidi il prete che scantonava.

Il cielo si faceva sempre più fosco, e il sole non era ancora levato.
Per le vie non si vedeva anima viva. Le porte delle case erano tutte chiuse, poichè il freddo tratteneva in casa più dell’usato gli abitanti, i quali non avevano l’obbligo di lavorare in quel giorno festivo.
Avvolto nel suo lungo pastrano dalle ampie saccoccie, col bavaro alzato, il prete attraversò il breve tratto di strada, curvo, col capo chino contro al vento furioso, che gli soffiava di fronte. Passò come una visione, e scomparve.
Allora io mi mossi ed affrettai il passo per tenergli dietro.
Scantonata la via, studiai di camminare rasente [141] le case per raggiungerlo inosservato. Il vento che ci soffiava di fronte gli impediva di avvertire il rumore delle mie pedate.
Gli tenni dietro per una cinquantina di passi, e lo raggiunsi all’imbocco del largo detto Funtana manna, in cui a destra la strada fa scarpa in campagna aperta, fronteggiando il villaggio di Codrongianus[15].
Il sito era opportuno, perchè spazioso e poco frequentato.
Giunto a tre passi da lui, tolsi la pistola di sotto al cappottone, glie la puntai quasi a bruciapelo alla nuca, e premetti il grilletto.
L’arma non prese fuoco, perchè il cane non aveva schiacciato il fulminante.
Continuai a camminare insieme a lui, sempre alla stessa distanza; e per altre tre volte ritentai il tiro. Il colpo non partì mai, e il vento contrario impedì che lo scatto del grilletto giungesse all’orecchio del prete.
Io era atterrito. Mi venne allora in mente che quell’uomo usava della sua malìa, e che la mia pistola era fatturata. Pensai di ricorrere al coltello, ma non l’avevo meco.
Il prete, sempre collo stesso passo, ignorando ch’era pedinato, camminava verso l’Oratorio.
Si era giunti insieme al centro di Funtana [142] manna; e, non volendo lasciarmi sfuggire l’occasione che l’inferno mi offriva, decisi di farla finita in qualunque modo. Feci ancora altri due passi avanti, levai in alto il braccio, e, con tutta la mia forzar lo lasciai ricadere con un manrovescio sulla guancia sinistra del prete, che stramazzò supino.
Gli fui sopra come un tigre, gli posi un ginocchio sul petto, lo afferrai colla sinistra alla gola, e puntandogli la pistola nell’occhio, feci scattare tre o quattro volte il grilletto, sempre invano.
Il prete si dimenava in tutti i sensi e mandava sordi rantoli, che si confondevano col gemito del vento. Aveva la lingua tutta fuori, gli occhi spalancati. Le sue unghie penetravano nelle mie carni, ma le mie braccia erano di acciaio.
Riuscì finalmente ad afferrarmi per il ventre; fui pronto a tirarmi indietro; ma, rallentando la mano con cui gli stringevo la gola, egli potè emettere due acutissimi gridi.
Furono i soli. Volendo sbrigarmi per non venir sorpreso, gli strinsi con più forza la gola, e colla canna del mio pistolone, a mo’ di pugnale, lo percossi a più riprese sul viso, strappandogli dalle guancie brandelli di carne.
Ero cieco, feroce. Gli premevo i ginocchi sulle costole, gli davo calci, pugni da per tutto; ma egli, colla faccia insanguinata, continuava a fissarmi cogli occhi sbarrati, quasi volendomi far [143] subire il fascino della sua malìa. L’anima di quel mostro non voleva uscir fuori dal corpo!
Nel frattempo, dietro di me, diverse porte si spalancarono con fracasso. I gridi del prete avevano dato l’allarme. Una dozzina d’uomini robusti, da diverse parti, si slanciarono verso di noi, non sapendo ancora che cosa fosse avvenuto. Senza voltarmi, continuai a percuotere il prete con più forza; egli era livido, grondante sangue dalle narici e dalla fronte, ma non c’era verso che volesse morire!
Quando gli accorsi ravvisarono me e il prete Pittui, si fermarono un istante, come inorriditi dinanzi a tanta audacia e a tanto sacrilegio. Finalmente mi furono tutti addosso per strapparmi la vittima, che io cercava invano di strozzare. Sentendomi afferrato da tutte le parti, divenni idrofobo. Abbandonai il prete, mi levai in piedi, e mi slanciai come belva contro i miei assalitori. Con morsi, pugni e calci ne mandai parecchi a ruzzolare sul terreno; un altro ne allontanai con un colpo di pistolone sotto all’occhio, in modo che ne portò la cicatrice finchè visse. Giunsi infine a svincolarmi da tutti, e mi diedi a correre verso casa.
— Fermatelo! fermatelo! — gridava il prete con sordo rantolo, senza potersi alzare.
Parecchi giovinastri m’inseguirono; ed uno, più ardito, mi tenne dietro prendendomi a sassate.
Giunto a pochi passi da casa, mi volsi indietro; e rivolto a quel giovane gridai:
[144]
— Fermati lì, un momento, chè voglio insegnarti come si lanciano i sassi!
E siccome ero entrato in casa per prendere il fucile, quel giovane se la diede a gambe, e andò a raggiungere i compagni, occupati a sollevare il prete malconcio, per portarlo sopra una sedia alla propria abitazione.
Molte porte nel frattempo si erano spalancate, e la gente accorreva da ogni parte per dirigersi a Funtana manna.
Io corsi ad armarmi di fucile; slegai il mio cavallo, lo portai sulla strada, e vi montai a dorso nudo.
Nel saltare per inforcarlo, mi cadde il berretto, che lasciai sulla strada.
Cacciai in testa il cappuccio, diedi una strappata alle redini, e, senza dar soddisfazione a’ miei (che ignoravano ancora l’accaduto) spinsi il cavallo al trotto per prendere la campagna.
[145]
Percorso un buon tratto di strada, sempre al trotto, prima di arrivare allo stradone m’imbattei in Sebastiano Zara (un cugino del prete Pittui) il quale mi fe’ cenno colla mano di fermarmi.
— Perchè corri così a precipizio? C’è forse niente di nuovo a Florinas?
— Vanne, e lo saprai! — gli risposi di mala grazia, e continuai la mia strada.
Seppi più tardi dagli amici, che quando costui apprese l’accaduto, minacciò l’aria col pugno, gridando:
— Eh, se lo avessi saputo! Avrei arrestato Giovanni Tolu sulla strada!
Stupida millanteria, poichè lui era inerme ed io armato, e sapevo di vincerlo in forza ed in destrezza!
[148]
Per oltre una mezz’ora mantenni alla corsa il mio cavallo, non scostandomi mai dalla strada reale. Dal Prato a Badu ludrosu, e da Pedru Majolu alla Punta Dunossi non mi fermai un minuto. Qui mi diedi a saltare un muro, ma urtando col piede in un grosso sasso mi feci male.
Smontai da cavallo, e impiegai un’altra ora a piedi nel far la salita di Giunchi, fino alla Rocca bianca, territorio di Florinas, tra Banari ed Ittiri.
Colassù rimasi tutta la giornata senza prender cibo. La lunga corsa a cavallo, a dorso nudo, mi aveva pesto orribilmente; dippiù il mio piede si andava gonfiando per l’urto ricevuto a Punta Dunossi. Ero impensierito, perchè non mi trovavo in condizione di battere i boschi in campagna aperta, senza pericolo d’una sgradita sorpresa.
Venuta la sera deliberai di far ritorno segretamente a Florinas. Avevo bisogno di mettermi sotto cura in luogo sicuro.
Abbandonai il mio cavallo (a cui avrebbero pensato i barracelli o i miei parenti) e, favorito dalle tenebre, rientrai sul tardi nel mio paese. Corsi non visto a casa di Chiara, la mia sorella maritata, la quale mi custodì gelosamente.
Colà rimasi una diecina di giorni, medicando la mia storta e le mie piaghe con incenso sbattuto nel bianco d’uovo, bagni d’acquavite, e polvere di carbone impastata con sevo: tutti medicinali, [149] di cui noi, agricoltori, facciamo uso con ottimo risultato.
Ogni notte mi s’improvvisava un letto; ma di giorno io stavo dentro ad una luscia[16], prestando orecchio alle chiacchiere che sul mio conto facevano le comari, quando venivano a condolersi con mia sorella.
La notte stessa del mio arrivo, appresi da Chiara, che il prete Pittui era stato trasportato a casa sopra una sedia, malconcio in modo che dava a temere per i suoi giorni. Era sempre a letto, in preda a dolori atrocissimi, e parlava a stento. Al terzo giorno il medico lo dichiarò fuori di pericolo, ma gli raccomandò di non fare alcun movimento, poichè la cura sarebbe stata piuttosto lunga. La notizia non mi fece certo piacere!
Durante il tempo della mia convalescenza, i carabinieri, guidati da spie, erano venuti più volte a Florinas per perlustrare le case sospette, dove si sperava di potermi sorprendere. Nessuno immaginò di certo, che la prima settimana della mia latitanza io la passassi dentro Florinas, in casa di mia sorella. Non si pensò neppure a visitare l’abitazione di Chiara, nè quella di mia madre, poichè non era possibile ch’io fossi stato così gonzo da cacciarmi in bocca al lupo.
[150]
***
Guarito completamente della storta e delle piaghe, mercè le affettuose cure di mia sorella, abbandonai sul tardi il villaggio e mi recai a piedi fino alla cantoniera di Scala di Ciogga, dove giunsi verso mezzanotte. Riposavo in un macchione, dietro la casa, quando dodici carabinieri si fermarono dinanzi la porta, e obbligarono il cantoniere ad alzarsi per dar loro da bere. Ripresero quindi la strada di Florinas, forse alla mia ricerca, poichè l’attentato sacrilego contro un prete aveva suscitato molto rumore, e la Giustizia si dava attorno per impadronirsi del reo.
Andati via i carabinieri, continuai la mia strada verso Sassari. Giunsi all’alba all’oliveto della signora Murro, in Serra secca, dove ogni giorno si recavano a zappare alcuni miei parenti. Ivi rimasi il resto della giornata. Sull’imbrunire presi una zappa sulle spalle, ed entrai in Sassari arditamente, confuso coi zappatori che a quell’ora ritornano dai lavori di campagna. Nel 1850 la città di Sassari era un luogo sicuro per i banditi, poichè scarso vi era il numero dei carabinieri, a cui piaceva viver comodi e tranquilli.
Mi recai difilato in casa di Don Antonico Berlinguer, allora Maggiore di piazza, il quale mi trattava con benevolenza, poichè mi sapeva [151] onesto e buon lavoratore[17]. Chiesi a lui consiglio; e siccome mi sentivo minacciato dai soliti dolori per le fattucchierie del prete Pittui, lo pregai che mi raccomandasse a un certo Frate Agostino dei minori osservanti, designatomi come valentissimo negli esorcismi. Era costui un sassarese, in fama di mantener relazione colla moglie di un falegname, dal quale era stato sorpreso e bastonato[18].
Don Antonico mi tenne nascosto in casa sei giorni, dandomi da mangiare e da bere; e volle accompagnarmi in persona fino al convento di San Pietro, per presentarmi al frate.
Prima di lasciare la città volli provvedermi di polvere e di palle. Avevo lasciato il fucile nella capanna di mio cognato Bazzone, marito di mia sorella Giustina.
Uscimmo di casa dopo il meriggio. Don Antonico mi precedette facendo l’indifferente: io gli tenni dietro a una certa distanza, per non compromettere l’amico nella carica delicata di Maggiore di Piazza. Dopo un quarto d’ora eravamo dinanzi al Convento.
Frate Agostino ci accolse con molto garbo e ci offrì una tazza di buon caffè. Poco dopo Don Antonico se ne andò per i fatti suoi.
[152]
Rimasto solo col frate, questi mi ordinò d’inginocchiarmi, mi lesse la solita orazione, mi gettò addosso la solita acqua benedetta, e mi licenziò dicendomi, che sperava di avermi sciolto dalle legature.
Sbrigato il mio affare feci ritorno all’oliveto di Serra secca, e di là m’incamminai verso il Curraltu mal’a servire, in fondo alla valle di Sette Chercos, territorio di Cargeghe, dov’era l’ovile di mio cognato.
Rimasi nella capanna alcuni giorni, sempre in angustie, per timore che una grave malattia mi rovinasse.
Dissi ad un mio cugino:
— Il prete Pittui è ancora in vita, e continua a perseguitarmi colle sue maledizioni. Temo troppo che gli esorcismi di frate Agostino rimangano senza effetto!
Un mio amico, che si trovava presente — certo Pietro Rassu, già mio vicino di casa — disse a me rivolto:
— Ma perchè non ti rechi dal rettore di Dualchi, uno dei più famosi per scongiurare le legature?
Non volendo lasciare intentato alcun mezzo per togliermi alle malìe del prete Pittui, indussi mio fratello Peppe ad accompagnarmi a Dualchi, villaggio al di là di Macomer.
Ci recammo insieme a cavallo fino a Padria, dove fummo ospitati dall’amico Salvatore Masia, tenente dei barracelli. Di là l’indomani continuammo [153] il viaggio, attingendo qua e là informazioni sulle scorciatoie, non essendo noi pratici dei luoghi. Dopo due ore e più di strada, c’imbattemmo in un vecchio, il quale ci avvertì ch’eravamo sulla strada che conduceva a Sindia e a Scano Montiferro. Saputo ch’eravamo diretti a Bortigali, suo paese, il vecchio si esibì a servirci di guida. Arrivati al villaggio, egli ci condusse in sua casa, dove ci rifornì di vino e di formaggio. Andammo quindi in casa di certo Pietro Maria Murgia, al quale l’amico di Padria ci aveva raccomandato. Era assente dal paese; ma la moglie e la suocera, appreso il motivo della nostra gita, ci dissero con un certo orgoglio:
— Presentatevi pure in nome nostro al rettore di Dualchi, e ditegli, che vi riceva colla stessa cortesia con cui suol ricevere Pietro Maria Murgia, che gli fu servo per ventott’anni.
Ringraziammo le due buone donne, che ci avevano offerto asilo e cena, e all’alba rimontammo a cavallo. Dopo tre ore di strada, sostammo dinanzi alla casa del rettore.
Il prete e la sua Perpetua[19] ci accolsero cortesemente e ci vollero ospiti.
Il rettore di Dualchi, Pietro Maria, era sopranominato su caddu de Ottava, perchè possessore di un famoso cavallo di corsa, ritenuto a quei tempi uno dei migliori dell’isola.
[154]
Quando gli esposi il motivo della mia venuta — il desiderio, cioè, di venir liberato dalle legature fattemi da un prete — egli mi domandò con una certa curiosità:
— Come si chiama questo sacerdote?
— Giovanni Maria Pittui.
— Lo conosco. So che ha un eccellente cavallo di corsa.
— V’ingannate. Il possessore del buon cavallo è un altro Pittui: suo nipote.
— Ho capito, e poco importa. Posso solamente assicurarti, che il mio cavallo di corsa è migliore del suo; e questo potrebbe significare, che sarò parimenti più fortunato nella cura del tuo male. Ti applicherò una pezza, che nessuno riuscirà a strapparti.
Fui lieto dell’esordio. Il prete soggiunse:
— Anzitutto hai bisogno d’una bottiglia d’olio, ch’io dovrò benedire.
Mio fratello Peppe corse subito a comprarla; ma, mentre la porgeva al prete, gli sfuggì di mano e andò in frantumi.
Fui vivamente impressionato del mal augurio; ma il rettore esclamò sorridendo:
— E così? Manca forse dell’olio in casa mia?
Fatta riempire un’altra bottiglia dalla serva, il prete si adattò la stola, mi fece inginocchiare, lesse l’ufficio, mi versò sul capo l’acqua santa, e per ultimo benedisse la bottiglia dell’olio.
[155]
Nel frattempo la serva, ferma sull’uscio, assisteva all’operazione con curiosità maliziosa, come se da lungo tempo fosse abituata a simili cure, a cui non credeva.

Terminata la funzione, il rettore mi fece alzare, e mi consegnò gravemente la bottiglia dell’olio ed un involto contenente quaranta pezzi d’ostia.
— Ogni giorno, a digiuno — egli mi disse — tu [156] metterai in bocca uno di questi pezzetti, che trangugierai con una boccata d’olio. Bada di non spaventarti se i tuoi dolori aumenteranno: saranno i chiodi vecchi che ti verranno fuori dalle carni. Ti esorto parimenti a non impressionarti se ti verrà il sangue alla bocca. Prima di consumare i pezzetti d’ostia (cioè a dire, prima di quaranta giorni) ho bisogno di rivederti![20]
Albeggiava appena quando all’indomani io e Peppe ci rimettemmo in viaggio, prendendo questa volta la direzione di Borore, per misura d’abituale prudenza.
Pernottammo in quest’ultimo paese.
Riposai con animo tranquillo, ma verso l’alba, dopo ingoiata l’ostia, ebbi lo sbocco di sangue preannunziatomi dal prete. Allo stesso tempo fui colto da dolori acutissimi alle ginocchia.
Mi feci coraggio. Presi un nuovo sorso d’olio ed un pezzetto d’ostia, e sollecitai la partenza.
Rimontati a cavallo, percorremmo un lunghissimo tratto di strada. Era ancora giorno quando ci trovammo in vista del Crastu mal’a servire; ma aspettammo le ombre della sera prima di avvicinarci all’ovile di mio cognato: — altra precauzione di tutti i banditi.
Arrivati all’ovile, consultai Peppe e mio cognato [157] sulla ricompensa da offrire al prete esorcista. Fu determinato d’inviare nostra madre a Sassari per fare acquisto di tre fazzoletti da due lire, di un chilogramma di caffè e di otto libbre di zucchero: regalo destinato al rettore ed alla sua Perpetua. Fu pure combinato di ripartire per Dualchi al più presto possibile, prima cioè che la voce della mia latitanza pervenisse all’orecchio di quel rettore.
Il rettore di Dualchi accettò con piacere il dono fattogli; e dopo aver rinnovato l’esorcismo e ribenedetta la mia bottiglia, mi disse con una certa confidenza:
— Mano mano che l’olio diminuirà, tu non avrai che aggiungerne dell’altro: la benedizione avrà la stessa efficacia.
Ho sofferto per parecchie settimane dolori atroci, ma debbo dichiarare, che le mie punture cessarono. Il rettore di Dualchi mi aveva radicalmente sciolto dalle legature di prete Pittui.
Ricorderò quanto mi disse la prima volta:
— Tu guarirai, poichè il rimedio che ti ho dato è infallibile. Devo però prevenirti, che le potenti fattucchierie, di cui fosti vittima, ti hanno fatto perdere la metà delle forze, la metà del valore e la metà dell’astuzia!
[158]
Dopo il terzo giorno — come già dissi — il medico del villaggio aveva dichiarato che prete Pittui era fuori di pericolo; però gli ordinava di stare a letto e di non muoversi.
Durante quel tempo la casa del sacerdote era assediata dalle visite. I fedeli parrocchiani ed i famigliari più intimi correvano al letto del proprio pastore per prendere informazioni sullo stato di sua salute; e, imprecando all’assassino sacrilego, facevano voti all’Eterno per una pronta guarigione.
Se il prete fosse morto in seguito alle mie percosse, nessuno certamente lo avrebbe compianto; anzi si sarebbe ringraziato Iddio per aver liberato il paese da un cattivo soggetto di quella fatta. Sapendolo però vivo, ognuno si studiava di entrare nelle sue grazie con una pietà falsa, che avrebbe potuto più tardi fruttare qualche favore, o almeno una maggior dolcezza di trattamento.
[159]
Sebbene ancora indolenzito per le percosse ricevute, e accasciato per le lunghe sofferenze, appena il prete si accorse di essere scampato alla morte, non pensò che allo sfregio ricevuto, e si die’ a escogitare tutti i mezzi possibili per vendicarsi di me: cosa che gli sarebbe riuscita assai facile, avendo al suo comando molti cagnotti, e potendo esercitare la sua influenza presso le autorità di Sassari, colle quali si manteneva in stretta relazione.
Se il corpo del prete era inchiodato al letto, la sua mente era libera e ruminava a mio danno. La casa Pittui era diventata il luogo dei convegni misteriosi, dove si tramava la mia perdizione.
Io stava in guardia, poichè avevo molti parenti ed amici che mi tenevano informato di quanto accadeva in paese.
Fra i più assidui visitatori di casa Pittui (durante il periodo della malattia) erano il Piana, lo Zara, il Serra, Peppe il sorsinco, i fratelli Dore d’Osilo, ed i fratelli Rassu di Tiesi, domiciliati a Florinas.
Darò di essi alcuni brevi cenni[21].
Giovanni Antonio Piana, mio coetaneo, era [160] da poco tempo marito della matura serva di prete Pittui, la quale poteva essergli madre. Cugino del prete e zio di mia moglie, quel gradasso si dichiarava capace di darmi la caccia.
Sebastiano Zara, pur parente di mia moglie e del prete, era il millantatore che per il primo avevo incontrato uscendo dal villaggio, il giorno dell’attentato. Egli aveva pronosticato la mia futura morte per opera sua.
Il terzo visitatore assiduo, Francesco Serra, aveva la debolezza di credersi un potente, solo perchè si era dato a fare il commissario dei carabinieri. Io però sapevo, che costui, insieme a Paolo ed a Francesco Rassu, nonchè ad altri due ittiresi, aveva preso parte come mandante all’assassinio di don Peppe Serafino di Tiesi. Uno però della combricola (che poi finì sulla forca) era stato in seguito arrestato alla festa di S. Paolo in Monti, per un orologio d’oro colle iniziali dell’ucciso, da lui venduto al parroco del detto paese.
Riservandomi a parlare a lungo della famiglia Rassu (ch’ebbe larga parte nei casi della mia vita) mi fermerò per ora sui due fratelli osilesi.
I fratelli Giuseppe e Giomaria Dore, osilesi, quantunque notissimi ladri e sicari, erano sempre riusciti a sfuggire alla giustizia, mercè l’astuzia e l’intrigo.
Giuseppe era compare di battesimo di prete Pittui; dal quale, aveva preso un salto in affitto, [161] in società col fratello Giomaria e con un tal Peppe di Sorso.
I due fratelli erano veduti di mal occhio a Florinas, e già da tempo si pensava al modo di sbarazzarne il paese.
Ho già detto che a Florinas, nel pomeriggio dei giorni festivi, si soleva andare fuori dal paese, per la gara del tiro a segno. Come premio al vincitore, si metteva per bersaglio una gallina viva, un coltello, una berretta, od altro oggetto.
Una domenica eravamo in numerosa comitiva, e ricordo fra gli altri i due fratelli Dore, Pietro Rassu, i preti Massidda e Pittui, il pretore, il cancelliere, e diversi cavalieri e giovani di distinta famiglia.
In quel tempo (verso il 1847) era stata ordita fra i signori florinesi una specie di congiura per liberare il paese dai due fratelli sicari, dei quali si aveva paura, poichè gettavano ovunque il terrore. La giustizia in quei tempi dormiva, od era cieca, ed erano le popolazioni che pensavano a liberarsi dai malfattori. Fu deciso di uccidere Giuseppe a smarro (cioè a dire come per caso accidentale). Pietro Rassu si era incaricato del colpo, e per essere più sicuro nell’eseguirlo, aveva dato di piglio al fucile ad una canna del cancelliere: fucile a fulminante e non a piastra — cosa rara a quel tempo. Dopo diversi tiri al bersaglio (eseguiti fra il buonumore e gli scherzi della brigata) il Rassu, fingendo mettere la capsula [162] nel luminello, lasciò partire il colpo in direzione di Giuseppe Dore, che gli stava vicino. La palla passò tra le gambe di quest’ultimo, ma non l’offese. Vi fu scambio di parole vivaci per l’imprudenza del tiratore, ma tutto finì lì, ascrivendo il falso tiro alla imperizia del Rassu nel maneggio dell’arma nuova.
Volle il caso, che quella sera, forse per la soverchia carica di polvere, si spezzasse a Giuseppe il calcio del fucile. Nel rientrare in paese vi fu chi pensò trar partito da quell’accidente, che toglieva all’odiato sicario i mezzi di difesa. Verso la mezzanotte Giuseppe Dore venne assalito nella propria abitazione da una mezza dozzina di individui, i quali riuscirono a smantellargli il tetto della casa per fargli fuoco addosso. La moglie scappò sulla strada, in camicia; ed il marito seppe difendersi così abilmente, che rese vano l’attacco dei nemici.
Persuaso, infine, che il vivere a Florinas era per lui pericoloso, Giuseppe Dore si decise a battere la campagna insieme al fratello Giomaria, per campare dal furto e per fare il sicario: mestiere molto lucroso a quei tempi, stante le inimicizie che dividevano le famiglie.
I due fratelli osilesi avevano uno zio mugnaio (pur chiamato Dore) il quale era in urto col proprio genero Bertolo Bazzoni, agricoltore. Lo zio chiese aiuto ai nipoti per sbarazzarsene, e questi accettarono il mandato.
[163]
Ucciso Bertolo, il vecchio Dore voleva costringere la propria figlia a passare in seconde nozze con un di lui cugino mugnaio, che gli avrebbe prestato aiuto nella professione; ma la vedovella, inorridendo, si rifiutò di ubbidire ad un padre, che gli aveva ucciso il primo marito. In preda a spasimi atroci, la povera figliuola ne morì di crepacuore pochi mesi dopo.
Appena compiuto il mandato di sangue, i due fratelli sicari si erano ritirati a Giunchi, presso una loro sorella zitellona.
Andando a far legna sulla montagna, capitai un giorno in quella regione, ed assistetti per caso ad un vivo diverbio tra i fratelli Dore e certo Carboni; motivo per cui mi vidi citato come testimonio.
Nel frattempo era stato arrestato lo zio Dore, uccisore del genero Bazzoni. I due nipoti, designati dalla voce pubblica come sicari, si erano dati alla latitanza durante l’istruttoria del processo.
Fattosi a Sassari il dibattimento, alcuni testimoni di vista deposero essere il solo suocero l’uccisore di Bertolo; altri invece (comprati dalla ricca moglie dell’arrestato) riuscirono a provare, che nè lo zio, nè i nipoti avevano preso parte all’assassinio. La conclusione fu, che vennero tutti assolti. La voce pubblica imprecò alla corruzione di testi... ed anche di qualche giudice; ed io posso asserire in coscienza, che giammai sentenza più iniqua e più scandalosa fu pronunciata [164] da un tribunale. Ed ora fidate nei dotti giudizi di una magistratura stipendiata, e deplorate l’istituzione dei Giurati![22]
Poichè la Giustizia era stata così cieca o così venale in quel processo, non mancò chi volle surrogarsi ad essa. Tre mesi dopo, nell’agosto, un fratello dell’ucciso sborsò una somma ai due banditi Cambilargiu e Antonio Spano, i quali freddarono con una fucilata il suocero di Bertolo Bazzoni.
Non voglio parlare d’altri brutti fatti, avvenuti per opera dei due fratelli Dore e del loro compagno Peppe il sorsinco. Accennerò solamente a quello dei quattro agricoltori partiti da Sorso, e venuti a Florinas, col pretesto di andare in cerca di uomini per la messe. Essi avevano dato ad intendere, che scopo della gita era quello di voler assalire nelle proprie case diversi nemici, che avrebbe loro indicati la sorella dei Dore. Il sindaco di Florinas, prendendo sul serio la minaccia, eccitò la popolazione alla propria difesa, suscitando un baccano che rasentò il ridicolo; ma la commedia si chiuse con una scenata in piazza, dove si addivenne ad una parvenza di pace generale, giurata fra molti bicchieri di vino e le baldorie carnevalesche.
[165]
***
Ed erano queste le persone, a cui il prete Pittui aveva affidato le vendette, e che attorniavano il suo letto nel gennaio del 1851. Tutti si erano compromessi di mettermi le mani addosso; e i fratelli Dore e il sorsinco avevano già ricevuto dal prete ottanta scudi, obbligandosi a darmi vivo o morto nelle mani della giustizia.
Ma non erano i soli. Ad uno dei soliti convegni assistevano (insieme al Piana, allo Zara ed ai Rassu) due notabili signori di Florinas, i quali si erano vantati che non avrei tardato a cader vittima dei loro agguati.
Ricordo un fatto. Poc’ora prima che mi si riferisse quest’ultima congiura, mentre me ne stavo sotto una roccia, a poca distanza dal paese, vidi passare a tiro del mio fucile i menzionati signori. Il destino ha voluto salvarli! Se di qualche ora avessero ritardato il viaggio, li avrei uccisi entrambi come due pernici. In seguito sbollì l’ira mia, e volli risparmiarli.
I miei nemici convenivano in casa di prete Pittui per deplorare l’accaduto; e imprecando al sacrilego maledetto e al vile assassino, offrivano coraggiosamente il loro braccio vendicatore per ottenere la mia morte o la mia cattura. Essi potevano millantarsi a mio riguardo, perchè ero povero, e lontano dal paese; il prete invece era [166] ricco e potente, e dovevano ingraziarselo per procurarsene la protezione. Quasi tutti avevano la camicia sporca, e temevano i ricorsi, palesi o anonimi, alle autorità di Sassari. Il ministro di Dio era in intimi rapporti coi ministri della giustizia — e fra ministri se la intendevano!
I congiurati credevano di operare nel segreto, ma tutto io sapeva, poichè tutto mi si riferiva da persone intime della casa. Molti visitatori facevano una doppia parte, volendo allontanare da me il sospetto per sfuggire alla mia collera. Ben sapevano i furbi, che il prete poteva aggiustarli coi magistrati di Sassari, e proteggerli dentro paese; ma non così fuori di casa. Ero io il re della campagna — e alla campagna dovevano tutti venire, contadini e signori, per lavorare o sorvegliare le terre. E perciò si voleva, nel tempo stesso, lusingare il bandito ed il prete, col proposito di tradirci entrambi. Che importava loro delle persone? o cadessi io nelle mani del prete, o cadesse il prete nelle mie mani, era sempre una battaglia vinta per essi, perchè si liberavano da un nemico!
Ed io ascoltava il consiglio di tutti, ma stavo in guardia, perchè di tutti dubitavo. Quantunque giovane ed inesperto, capivo che la paura legava a me quei consiglieri, ai quali tornava ugualmente vantaggioso il perdermi, od il salvarmi.
[167]
L’essermi dato alla macchia impressionava non poco i miei nemici di Florinas. Ero per loro un bandito, un disperato che non avrebbe potuto frenarsi per alcun sentimento di riguardo personale, o di pietà. Si aveva paura di me, si temeva che una falsa informazione, un falso rapporto, un malinteso avessero apportato conseguenze fatali. Non pochi si erano messi al sicuro, per allontanare le cause che potessero destare un mio sospetto.
Gavino Pintus, per esempio, (il padre della Maddalena Bua) aveva licenziato dalla sua casa il cognato Serra, perchè bazzicava troppo coi Dore e coi Rassu ed era commissario dei carabinieri.
I fratelli Rassu erano di famiglia tiesina, domiciliati a Florinas. Con costoro ero in buoni rapporti, poichè uno di essi (Giuseppe) aveva sposato una mia zia. Tuttavia li guardavo di mal occhio, sapendoli gente abituata al malfare, e capace di prestarsi a qualunque delitto, senza scrupoli di sorta.
[168]
La famiglia Rassu si componeva di quattro fratelli — Pietro, Francesco, Paolo e Giuseppe — e di uno zio attempato, Giovanni Andrea, dal quale andavo a consigliarmi spesso, perchè lo ritenevo uomo di senno.
Il giovane Paolo era stato di recente ucciso a Siligo, a causa d’una ragazza, di cui si era innamorato. L’uccisore era stato punito con una fucilata, datagli da uno dei fratelli di Paolo.
La casa di Pietro Rassu era attigua a quella di mio suocero — come attigua a questa era la casa mia, quando l’abitavo insieme a mia moglie. Vedendoci e visitandoci con frequenza, si viveva di accordo come due buoni vicini, e il paese ci considerava quali amici.
Dopo la mia latitanza si accrebbe l’odio mio verso i fratelli Rassu, poichè li sapevo d’accordo col prete per congiurare la mia rovina.
Ero appena da quindici giorni bandito, quando uno strano accidente mi liberò da uno di essi: da Pietro Rassu.
Fra i molti delitti da costui commessi impunemente, se ne annoverava uno, la cui istruttoria era in corso, e si aspettava da un giorno all’altro l’ordine di spiccare il mandato d’arresto.
Un giorno Pietro, nel suo ovile di Corona majore, aveva diviso il pranzo con Monsiù Maronero, il brigadiere dei carabinieri, che andava in perlustrazione. Prima di separarsene, volle dare a lui due capretti, dicendogli scherzando:
[169]
— Te ne faccio un regalo, perchè tu mi usi un po’ di riguardo quando verrai per arrestarmi.
Il brigadiere aveva risposto:
— Siamo troppo amici, e farò di tutto per sottrarmi a questo doloroso incarico. Altri carabinieri ti arresteranno, non io di certo!
Pietro Rassu soggiunse, serio:
— Ed io ti prometto, dal mio canto, che in carcere non ci andrò, a costo di farmi ammazzare. Ci sono già stato quattro volte, e ormai ne sono stanco!
Fu lo stesso Pietro, che mi confidò questo incidente.
Trascorso un po’ di tempo, venne spiccato l’ordine d’arresto, e si aspettava l’occasione propizia per mettere in gabbia l’uccello.
I buoni rapporti apparenti che io manteneva con Pietro, per essere egli stato mio vicino di casa, diedero a sospettare che anche bandito io andassi qualche volta a trovarlo. Una sera sul tardi, mio suocero, origliando alla parete che lo divideva dalla stanza di Pietro Rassu, credette di riconoscere la mia voce, e si affrettò ad avvisarne il prete Pittui. Questi mandò subito un espresso a Codrongianus per far venire i carabinieri.
Il brigadiere Monsiù Maronero, con altri suoi compagni, accorsero nella stessa notte a Florinas, e si portarono segretamente in casa del notaio Giovanni Antonio Fiori, che aveva la moglie agonizzante. Ivi caricarono i fucili a mitraglia.
[170]
Era il 17 gennaio 1851 — giorno di Sant’Antonio.
Da poco era trascorsa la mezzanotte, quando il brigadiere dispose l’appiattamento. Collocò un carabiniere dinanzi alla porta che dava alla strada; ed egli, a cavallo, si collocò in faccia alla finestra della camera posteriore, che dava ad un piccolo cortile, verso la campagna.
Il brigadiere bussò al finestrino, dicendo:
— Pietro, apri!
— Aspetta un momento! — rispose Pietro, che immaginò si trattasse della sua cattura; e corse ad armarsi.
Trascorsi alcuni minuti aprì la finestra, e si trovò di fronte al brigadiere a cavallo, che gli impediva l’uscita.
— Datti a una parte! — fece Pietro, come avvertendo che voleva uscir fuori; ma quegli non si mosse.
Allora Rassu, fattosi alla bassa finestra, die’ uno spintone al cavallo colla canna del fucile, e lo costrinse a indietreggiare.
Monsiù Maronero, intanto, aveva puntato il fucile alla finestra, in attesa che l’uomo saltasse per fargli fuoco addosso.
Pietro Rassu, coll’audacia dei coraggiosi e dei disperati, montò il grilletto, e scavalcò d’un salto il davanzale della finestra, scaricando l’arma su Monsiù Maronero.
In pari tempo scattò il grilletto del fucile [171] del brigadiere. Si udirono due detonazioni, ed entrambi caddero a terra come fulminati.
Quando accorsero gli altri carabinieri non trovarono che due cadaveri boccheggianti.
Sono queste le stupide bravate di molti carabinieri; i quali, fidando unicamente nel proprio valore, non si mantengono mai sani di testa. Prima della spedizione essi hanno già in corpo Dio sa quanti bicchieri di vino e di acquavite, ed espongono ciecamente la vita, senza raggiungere l’intento.
Il brigadiere Maronero non aveva mantenuto la parola data a Pietro Rassu... ed ebbe il fatto suo!
Il caso della doppia uccisione (che aveva avuto a solo testimonio mio suocero, nella casa vicina) era stato così singolare, che per lungo tempo si tardò a prestarvi fede. La versione data fu questa: che io realmente mi trovassi in casa di Pietro Rassu; che questi, saltando dalla finestra, fosse stato ucciso dal brigadiere; che il brigadiere, alla sua volta cadesse morto per una mia fucilata; e che io, finalmente, fossi riuscito a raggiungere la campagna, prima che accorressero gli altri carabinieri.
Ed era una versione stupida. Mi si voleva dare un’audacia valorosa, che non mi spettava. Avrebbe dovuto bastare il fatto della doppia detonazione e delle due canne scariche per convincersi della verità; ma non si voleva incolpare mio suocero di una falsa denunzia!
[172]
Il prete Pittui si morse le dita per dispetto; e mio suocero fu talmente impressionato dal pensiero della mia vendetta, che da quel giorno si chiuse in casa, si ammalò, e non volle più vedere nessuno.
Quando appresi l’accaduto, esclamai con amaro sorriso:
— E uno! Dio ha voluto farmi risparmiare una carica di polvere.
***
Continuerò la storia dei Rassu.
Pietro e Francesco, sovratutti, erano in fama di ladri e di sicari; e dicevasi che il primo fosse il depositario delle ruberie che si commettevano.
Cinque mesi dopo la morte di Pietro, avvenne l’assassinio della sua vedova, Giovanna Angela Manconi, rinvenuta scannata col rosario in mano.
La voce pubblica non tardò ad affermare, che la poveretta fosse stata tolta dal mondo per mandato del proprio cognato Francesco, designato come tutore ad amministrare i beni dei nipoti minorenni.
Il giorno precedente al barbaro assassinio mi trovavo per caso a Scala ruja, territorio di Florinas, quando m’imbattei in Francesco Rassu, il quale, a cavallo, si diriggeva verso il paese, portando in groppa un bandito.
[173]
Come mi viddero e mi riconobbero, il bandito smontò da cavallo e mi chiamò a nome.
Io feci il sordo e continuai la mia strada, seguito da un grosso mastino.
Persistendo il bandito a darmi la voce, mi fermai.
— Che volete? — chiesi.
— Vieni con noi; abbiamo bisogno di sbrigare un affare urgente.
Mi accorsi subito che non aveano rette intenzioni a mio riguardo. Sapevo già della congiura fatta in casa del prete, e diffidavo di Francesco.
— Fate buon viaggio e andate per la vostra strada! — gridai rimettendomi in cammino, e risoluto di far fuoco su entrambi, se avessero persistito a tormentarmi col loro invito.
Capitai poco dopo nella capanna di un mio zio — Gio. Maria Giavesu — a cui narrai l’accaduto:
— Vedi? — gli dissi con amarezza — oggi ho corso il pericolo di romperla con Francesco Rassu. Mi sono contenuto per seguire il tuo consiglio!
— Ed hai fatto bene. Non voglio che tu l’uccida. Egli è nostro parente, poichè ha in moglie una tua cugina, e sarebbe un’onta se si dicesse che noi beviamo il sangue nostro!
La stessa sera sul tardi, invitato da un amico, passai la notte a Florinas. Verso l’alba del giorno seguente ci venne data la notizia dello [174] sgozzamento della vedova di Pietro Rassu. Il cognato Francesco, forse per allontanare i sospetti, nel momento in cui veniva consumato l’assassinio, discorreva in piazza col proprietario del bestiame datogli in custodia.
Trascorso qualche giorno, si sparse ad arte la voce, che il vero uccisore dei coniugi Rassu ero io. Compresi lo scopo della diceria: si voleva aggravare il mio attentato contro la vita di prete Pittui, designandomi come sanguinario.
***
Il terzo fratello dei Rassu — Giuseppe — era mio parente, perchè ammogliato con Maria Rosa Bazzone, sorella di mia madre. Era costui d’animo malvagio come gli altri fratelli, ma dominato da mia zia, donna energica e di carattere forte, finì per contenersi.
— Bada Giuseppe! — gli diceva la moglie — se hai caro di non morire in galera, devi allontanarti da’ tuoi congiunti, due dei quali morirono di palla. Rimani in casa con me, e non avrai malanni!
Francesco Rassu, nominato tutore dei figli di Pietro, fu deluso nelle sue speranze. Egli non aveva trovato nessun deposito di danaro in casa della cognata; e divenne così irascibile e intrattabile, che i nipoti non vollero convivere con lui.
Si diceva in paese, che i danari della vedova [175] assassinata fossero stati nascosti in campagna dal figliuolo sedicenne Salvatore, che li aveva rinvenuti. E la diceria veniva avvalorata dal fatto, che Salvatore era uscito dalla casa paterna, non appena lo zio vi era entrato come tutore. Il fiero giovane era andato a convivere con lo zio Giuseppe, marito di mia zia.
In quel tempo Ignazio Piana (marito di mia sorella Andriana) abbisognando nella Nurra d’uomini di lavoro, aveva preso seco il giovane Salvatore, come servo di fiducia.
Mio cognato mi diceva spesso:
— La donna che sposerà mio nipote farà la sua fortuna, poichè possiede molto danaro.
Ed io gli rispondevo:
— Se avessi cento figlie non ne darei una a tuo nipote, poichè il danaro ch’ei possiede non è che il frutto di furti e grassazioni.
Stando al servizio di Ignazio Piana, Salvatore si era più volte recato a Florinas per ritirare il suo denaro, che aveva dato in custodia ad una zia convivente con un prete.
Un giorno mi pregò di comprargli un pistola, ma andato in paese per chiedere quindici scudi, gli vennero rifiutati dal prete e dalla zia.
***
Lascio per ora indietro il giovane Salvatore, per parlarvi di Francesco, il più forte, il più coraggioso [176] e il più temuto dei fratelli Rassu, e sul quale il prete Pittui faceva assegnamento per potersi sbarazzare di me.
Non pochi erano i misfatti commessi da costui, sebbene la giustizia non fosse ancora riuscita a coglierlo in fallo. Ci odiavamo entrambi cordialmente; ma l’odio nostro era sotto cenere. Il ramo di parentela, che ci univa, ci obbligava a vivere sul tirato; ma si aspettava da entrambi un appiglio per poter cacciar fuori tutto il fiele che avevamo in corpo.
Fra i delitti di Francesco Rassu citerò il più vigliacco: l’assassinio dell’Eremitano di Santa Maria di Ese (o Sea) — un bonaccione, un mezzo scemo, chiamato Peppe.
Insieme alla mamma e a diversi piccoli fratelli, quel disgraziato viveva in parecchie casette basse, a guardia della chiesa campestre. Come tutti gli eremitani sardi, egli aveva l’obbligo di aprire la porta della chiesa a tutti i devoti che vi si recavano per farvi orazione. La povera famigliuola non viveva che delle magre limosine che i visitatori le davano, dello scarso frutto di un lembo di terra coltivabile, e dell’allevamento di qualche bestia, a mezzadria.
Un giorno certo Andrea Alichinu, già orefice ed allora bandito, capitando tutto solo nel casale di Santa Maria (fra Banari e Florinas) adocchiò una troia coi porcellini che stavano sull’uscio di casa.
[177]
— Me ne regali uno? — egli chiese a Peppe.
— Non posso regalartelo, poichè siamo molto poveri. La troia non è tutta nostra: l’abbiamo a metà col proprietario che ce l’ha data in custodia.
Il bandito tacque e tirò oltre; ma recatosi sul tardi in casa di Francesco Rassu, gli parlò del porcellino, della troia, e del rifiuto.
— Perdio! — fece Rassu — Peppe t’ha negato un porcetto, e noi glieli prenderemo tutti!
La stessa notte Alichinu, Rassu, e parecchi altri si recarono alla chiesetta campestre per rubarvi i porcellini.
L’eremitano dormiva. Al grugnito della troia si svegliò, tese l’orecchio, die’ di piglio al fucile e uscì fuori.
Francesco Rassu, ch’era appiattato in vicinanza per favorire il rapimento, fece fuoco addosso allo scemo e lo rese cadavere. I ladri si affrettarono a piombare sui porcellini, e li portarono via, ridendo del bel tiro riuscito.
Impossibile descrivere la disperazione della famigliuola per il caso luttuoso. Più volte ebbi occasione di passare dinanzi alla casetta di Santa Maria, e vidi la povera madre e i figliuoletti, laceri, scalzi, in uno stato miserando. Lasciavo loro qualche lira, qualche pane, e qualche pezzo di carne. Una sera la povera vecchia si presentò a me seminuda, ed io mi tolsi una flanella di cotone (ne avevo due indosso) e glie ne feci dono. Un altro giorno portai a quella famiglia un maialetto [178] regalatomi da mia sorella, promettendo di dargliene la metà quando lo avrebbero ingrassato. Venuto grande glie lo lasciai per intiero.
Non vi sembri ridicolo. Il barbaro assassinio dell’eremitano, consumato vigliaccamente da Francesco Rassu, non fu l’ultima causa dell’odio implacabile ch’io nutriva verso di lui. Ho sempre detestato i vili ed i vigliacchi, tormentatori delle donne o dei deboli.
Mi sono alquanto dilungato, per presentarvi alcuni membri della famiglia Rassu, che rivedremo più tardi. Ora ho bisogno di tornare indietro, per riprendere il filo della mia storia.
[179]
Ero finalmente guarito dalle legature di prete Pittui.
Cominciai dunque il mio pellegrinaggio per monti e per pianure, per boschi e per valli, recandomi da un ovile all’altro, sempre sospettoso, coll’occhio aperto, l’orecchio teso, la mano al fucile od al pugnale.
Il primo mese di banditismo mi riuscì penoso, insopportabile. Abituato com’ero ad una vita attiva, all’assiduo lavoro, quell’errare incerto da un punto all’altro, ignaro del dove avrei passato la notte, colla mente sempre intenta a sfuggire un pericolo, coll’animo deliberato a lottare disperatamente contro i nemici della mia libertà, mi rendeva irrequieto, irascibile, di cattivo umore. Le giornate mi parevano eterne, le notti interminabili.
Scorrendo le campagne da mattina a sera, io vedeva dovunque donne e uomini intenti ad arare, a seminare, a raccogliere le olive; m’imbattevo assai spesso in frotte allegre che andavano [180] o tornavano dal lavoro chiacchierando e cantando; ed io continuava il mio eterno giro per i campi aperti e per le terre altrui: io, il grande ozioso in mezzo a tanti lavoratori!
La mamma, la mia povera mamma, a quando a quando, dietro l’ambasciata ch’io le mandava per mezzo di qualche fido parente, veniva a recarmi un po’ di provvista nei punti da me indicati; e faceva persino due ore di strada, a piedi, per portarmi un pane fresco, o la biancheria da cambiarmi. Le lagrime di quella buona vecchia, che pregava la Vergine e i Santi per la mia conservazione, erano per me stille di piombo che alimentavano l’odio verso i miei nemici.
Mi ero spinto più volte fino alle lontane terre della Nurra ed alle campagne d’Osilo, di Sorso e di Alghero; ma finivo sempre per tornare ai dintorni di Florinas, dove avevo parenti da consultare, vendette da compiere.
Per rendere meno penoso il mio ozio involontario mi procurai un sillabario. Colla paziente perseveranza del bandito, passavo due o tre ore al giorno a compitare stentatamente le sillabe, senza aiuto di alcun maestro. Rammentavo qualche lezione appresa alla scuola del villaggio, e leggevo a voce alta, con meraviglia del mio cane, che mi guardava con tanto d’occhi. Il messale della parrocchia, che avevo maneggiato per tre anni, lungo la mia carriera di sagrestano, mi era servito per apprendere le lettere maiuscole; ma [181] le benedette minuscole mi riuscivano di difficile lettura, e mi facevano sudar freddo. Avevo pazienza. Non erano i lavori di campagna che mi toglievano il tempo!
Poco per volta, dopo il primo mese, mi ero abituato alla vita errante: l’ozio non mi tormentava più. Io pensava a’ miei nemici, al modo di assalirli, o di difendermi da essi — ed anche questa è un’occupazione come un’altra. Lavoravo colla mente, invece di lavorare col braccio — ecco tutto!
Per più di un anno non ebbi per compagno che un cane terribile, cui posi nome Pensa pro te! Aveva l’intelligenza di un cristiano. Bastava ch’io gli dicessi: — Togli il berretto a quell’uomo! — Avventati! — Sta fermo! — Oppure: Va con quell’amico e non fargli male! — perchè esso mi capisse. In sua compagnia io poteva affrontare quattro nemici; ed era capace ad un mio cenno di sbranarli tutti. Appena mi vedeva addormentato, esso si coricava vicino a me e mi poneva il muso sulla coscia. Se udiva il minimo rumore, mi svegliava con lunghi gemiti, ma senza abbaiare per non compromettermi.
Quantunque vivente nell’isolamento, ero minutamente informato delle mosse de’ miei nemici: nemici di due specie — i palesi, da cui sapevo guardarmi: e quelli che congiuravano nell’ombra, fingendo proteggermi di pieno giorno.
La mia carriera di bandito era aperta. L’uomo [182] che si dà alla macchia non ha che tre sole preoccupazioni: vendicarsi anzitutto dei nemici a cui deve la propria disgrazia; sfuggire alle insidie della giustizia che gli manda dietro i carabinieri; e punire severamente le spie, che per danaro od altra ragione, tramano la morte o la cattura dei latitanti.
Quasi ogni giorno mi si comunicava qualche notizia, attinta ai convegni segreti di casa Pittui. Era dunque cominciata la caccia feroce al sacrilego schiaffeggiatore di un prete! Le poste erano state assegnate dal capo cacciatore, e i cani venivano sguinzagliati contro il cinghiale della foresta. Ma io stava all’erta; ero tutt’occhi, tutt’orecchi, perchè disposto a vender cara la mia pelle.
I fratelli Dore avevano già ricevuto un acconto sul prezzo del tradimento a mio danno, nè più si recavano a visitare la casa del prete infermo[23].
Pochi giorni dopo l’uccisione di Pietro Rassu e del brigadiere Maronero, venni avvertito, che la notte di San Sebastiano (in gennaio) il commissario Francesco Serra, in compagnia di Francesco [183] Rassu, avevano fatto una visita a tutti gli ovili ed ai molini di Florinas e d’Ossi, con lo scopo di darmi la caccia, o di attingere indizî sui luoghi del mio rifugio. Essi operavano sotto la direzione e dietro i suggerimenti di prete Pittui, il cui odio contro di me, come il mio verso di lui, dovevano spegnersi colla morte di entrambi.
Mi trovavo un giorno insieme al bandito Antonio Rassu d’Ittiri (lontano parente dei famosi sicari). I compagni dei banditi non possono essere fior di galantuomini, ed il mio era già stato sette anni in galera, per aver ucciso un giovane a pugnalate.
Ci recammo insieme all’ovile di Antonio Luigi Carboni (in sas coas de medallu) dove sapevo di trovare l’osilese Giuseppe Dore, uno dei famosi sicari incaricato di uccidermi, ed a cui il prete aveva già sborsato un acconto di ottanta scudi.
Come la sera c’imbattemmo nel Dore, questi esclamò vivamente, rivolto al mio compagno:
— Se tu non fossi stato in compagnia di Giovanni Tolu, ti avrei ucciso!
Gli dissi pacatamente:
— E avresti fatto male.
— Avrei fatto bene, poichè costui è un mio nemico!
— Non ti è nemico — soggiunsi con sussiego — Quando fosti aggredito dentro casa a Florinas, Antonio non faceva parte della combricola degli assalitori. Ci saranno stati i Rassu, [184] suoi parenti, ma non lui. Tu ben lo sai quali siano i tuoi veri nemici!
Le gesta di Dore mi erano tutte note. Due giorni addietro, in compagnia d’altri, aveva dato l’assalto ad un ovile d’Ossi, maltrattando un povero servo, a cui rubò quattro pecore.
Scambiate con lui poche altre parole, salutai Dore dicendogli, ch’eravamo diretti ad Ittiri.
— Non vi lascio andar via! — esclamò Dore con affettuosa premura — Stanotte mangieremo un boccone insieme. Ci ho carne grassa da far cuocere!
Era quella delle pecore rubate.
Venne messa intanto la carne al fuoco, ed entrammo nell’ovile. Ero in casa del sicario del prete, e dovevo stare ad occhi aperti.
Avevo meco Pensa pro te, il fido cane, che conducevo a mano con una catena. Anche Dore era seguito da una buona cagna, che mi sbirciava cogli occhi iniettati di sangue.
Si era nel mese di maggio, e verso le nove sedemmo a tavola per mangiare — coi fucili fra le ginocchia, s’intende!
Non avevamo ancora terminato il pasto, quando udimmo i cani abbaiare.
Balzammo in piedi di scatto, e uscimmo tutti e quattro all’aria aperta: io, Rassu, un giovane pastore e Giuseppe Dore. Quest’ultimo si era armato in un attimo di fucile, di pistola e di daga, poichè si considerava come un mezzo bandito.
[185]
— Se sono carabinieri — esclamò con spavalderia — li farò saltare in aria!
Io sorrisi. Coll’occhio intento ad ogni sua mossa, gli stavo alle costole, temendo qualche brutto tiro.
Uscimmo fuori per esplorare i dintorni.
La notte era chiara, serena. Non spirava un filo d’aria.
L’uno dietro l’altro c’inoltrammo per un tratto di terreno, tutto coperto di cardi selvatici.
Io osservai:
— Parmi non sia prudenza andare così uniti. Sarà meglio sbandarci alquanto, per metterci al sicuro da qualche agguato.
Rompemmo infatti l’allineamento, e prendemmo diverse direzioni, l’uno discosto dall’altro.
Siccome non perdevo d’occhio Giuseppe, mi avvidi che due volte mi aveva sbirciato. Egli pensava, forse, di saldare il suo debito col prete!
A un tratto il giovane pastore si fermò; e voltandosi, ci avvertì con voce sommessa di aver veduto qualche cosa muoversi lungo la costiera. Aggiunse che temeva si trattasse di gente appiattata.
Si continuò la strada guardinghi. Tanto il giovane, quanto Dore, fecero diversi spari in direzione della costiera. Io mi guardai dal far fuoco, poichè il bandito col fucile scarico è un uomo morto. I colpi non devono andar perduti!
Ci eravamo così sbandati; ma dopo una mezz’ora, per diverse parti, rientrammo nell’ovile.
[186]
Uno solo mancava di noi quattro: Giuseppe Dore; e invano lo aspettammo...
L’indomani all’alba fu rinvenuto sdraiato bocconi, sull’erba. Lo si credeva addormentato, ma invece era morto da una fucilata.
— Chi l’avrà ucciso?! — esclamò con terrore il giovane pastore.
— Lo saprà Iddio! — risposi facendomi il segno della croce. E a fior di labbro mormorai:
— Decisamente i sicari dei preti non hanno fortuna![24]
Un Dore era sparito, ma restava l’altro.
***
Qualche tempo dopo la morte di Giuseppe, un certo Sanna (un amico che aveva conti da aggiustare con l’altro fratello Giomaria) m’invitò a tenergli compagnia per togliere di mezzo quel cattivo soggetto. Trattandosi di un nemico che odiavo mortalmente, accettai volentieri.
Dovevamo incamminarci verso Sorso, dove allora Giomaria si trovava.
[187]
A metà strada c’imbattemmo per caso nei tre banditi Pietro Cambilargiu, Antonio Spano e Salvatore Fresi; i quali ci confidarono essere diretti a Sorso, incaricati dell’uccisione di Giomaria Dore. Ci unimmo a loro, tacendo che lo scopo della nostra gita era il medesimo.
Movemmo tutti e cinque insieme, guidati da una spia, che doveva indicare la vittima, sconosciuta ai tre sicari.
Arrivati alla punta di un ciglione, la spia si fermò; e dopo averci indicato un individuo lontano, che stava in mezzo ad un campo, proseguì tutto solo per la strada di Sorso.
Come ci appressammo all’uomo designato, io e Sanna (che conoscevamo di persona Dore) avvertimmo i compagni che non facessero fuoco, perchè non era lui.
Intanto la spia, arrivata a Sorso, si era data premura di annunziare che i cinque banditi (me compreso) avevano ucciso Giomaria Dore.
La notizia era falsa, perchè quel giorno ci fu impossibile trovare Dore. Ad altro era riserbata tanta fortuna. Giomaria fu mortalmente ferito una settimana dopo. Ebbe tre palle nella schiena e sopravvisse sette giorni.
La morte dei fratelli Dore fu accolta con viva gioia dagli abitanti di Sorso, di Florinas, d’Ossi, e d’altri villaggi circonvicini. Nessuno pianse la scomparsa dal mondo dei due ladri e sicari. E questa pubblica dimostrazione di contento [188] valse pure a tranquillare la coscienza degli uccisori, che avevano reso un buon servizio al paese.
***
Avevo veduto tante volte i miei nemici in sogno — e ai sogni io credeva.
Un giorno sognai di camminare in una viottola stretta, accompagnato da Pensa pro te. Ad un tratto vidi venirmi incontro i due fratelli Dore e Peppe il Sorsinco. Spianai il fucile contro di essi, ma mi si ruppe il calcio. Diedi allora di piglio alla daga, e ne pugnalai uno. Gli altri due scomparvero nella nebbia. Ma perchè nel sogno non avevo pensato ad aizzare il mio cane contro di essi?
Mi svegliai colla fronte madida di sudore. Pochi giorni dopo, a breve distanza dall’ovile di Sas coas de medallu, venne ucciso Giuseppe.
Un’altra volta vidi in sogno due poliziotti. Ne uccisi uno, ma l’altro scomparve, non so come. All’indomani, a caccia, mi trovai di fronte a due grossi cinghiali: uno ne atterrai, l’altro mi sfuggì, senza che io lo vedessi correre.
Lo confermo: i miei sogni si avveravano sempre![25]
[189]
***
Nei primi mesi della mia latitanza mi aggiravo da una campagna all’altra, sempre sperando d’imbattermi in qualche mio nemico; ma debbo pur dire, che quasi tutti i misfatti che in quel tempo si commettevano, venivano a me caricati. Sotto il mio nome non pochi compivano le loro vendette, o assassinavano per furto, sfuggendo alle ricerche della giustizia. Triste condizione dei banditi! — Basti il fatto, che nel giro di poche settimane vennero istruiti tredici processi per delitti consumati nel territorio di Florinas; e in quasi tutti venni complicato per i raggiri e gli intrighi de’ miei nemici, che si raccoglievano a consiglio nella camera da letto del sacerdote Pittui.
Uno di costoro — Giovanni Antonio Piana, marito della serva del prete e zio di mia moglie — mentre un giorno in campagna conversava con diversi suoi amici, ebbe il braccio spezzato da una fucilata, datagli da incognita mano. Trasportato all’ospedale di Sassari gli vennero estratte le palle, e guarì dopo lunga e penosa malattia.
Anche per questo colpo fu messo in campo il mio nome; ma lo stesso ferito dichiarò, che il tiro non poteva venirgli che da due ladri di buoi, che egli, come capitano dei barracelli, aveva fatto arrestare, costringendoli ad attraversare il villaggio [190] col cuoio rubato sulle spalle. La diceria a mio carico questa volta non mi spiacque: mi spiacque solamente che la fucilata data a Giovanni Antonio gli avesse rotto il braccio, invece di troncargli la vita. Ma su questo fatto tornerò più tardi[26].
Nel medesimo tempo era stato ucciso con arma da fuoco un certo Congiatu, mentre lavorava nella vigna di suo cognato Sebastiano Zara, lo spavaldo cugino del prete. Si affermò da taluno (e diceva il vero!) che l’uccisione era stata fatta per sbaglio da un congiunto dello stesso Zara, che andava in cerai di me. Tuttavia non mancò chi mi volle colpevole, asserendo aver io tolto di mezzo il Congiatu, solo per dare un avviso di minaccia al mio nemico, parente dell’ucciso. Tutte fandonie e calunnie!
La morte del cognato impressionò talmente Salvatore Zara, che egli si chiuse in casa, nè volle recarsi in campagna, temendo ch’io lo uccidessi. Alcuni miei amici e diversi signori di Florinas vennero a me per pregarmi di far grazia allo Zara, che aveva bisogno di lavorare per vivere. Cedetti infine alle preghiere, e feci dire al mio nemico, che andasse pur liberamente [191] in campagna, ma badasse al fatto suo. Egli mi ringraziò, tornò al lavoro, e da quel giorno visse tranquillo. Io ben comprendeva che questi poveri diavoli si atteggiavano a spavaldi, solo per far piacere al prete; poichè infine non potevano odiarmi, dal momento che nessun’offesa avevano da me ricevuto.
Fui parimenti accusato in quei giorni dell’assassinio d’un contadino, che aveva rubate alcune pecore, e il cui cadavere fu rinvenuto in un salto di Giunchi.
L’intenzione di complicarmi in nuovi processi si era manifestata ne’ miei nemici, anche prima ch’io attentassi alla vita di prete Pittui.
Il giorno di S. Francesco (in ottobre) mentre tra la folla assisteva ai fuochi artificiali, veniva ucciso con un colpo di pistola certo Bartolo Piras. L’uccisore finì per essere scoperto e condannato alla galera in vita; eppure, non so ancora perchè, il fisco pretendeva di rendermi complice di quella morte. Mi diedi ragione dell’accusa, quando appresi che l’ucciso era fra i più intimi confidenti di prete Pittui: l’uomo, cioè, di cui egli si serviva per consegnare in mano delle autorità di Sassari i famosi ricorsi, a danno dei nemici che voleva ad ogni costo perdere.
Era questo il prediletto sistema di quei tempi disgraziati. Si sapeva, che una volta cacciato l’uomo in carcere, reo o innocente, esso vi marciva per mesi ed anni, in espiazione delle molestie [192] date ai signorotti del paese, od ai ministri di Dio. Nel 1850 era questa la bella giustizia di Sardegna!
Rassegnato al mio destino, io sopportavo pazientemente le calunnie de’ miei avversari, ma non le dimenticavo. Il rettore di Dualchi aveva sciolto le mie legature, ed io smaniavo di vendicarmi: non solo di quanti erano stati causa della mia disgrazia, ma anche dei vigliacchi che per lucro, per millanteria, o per malvagità, si prestavano a darmi la caccia, o a farmi la spia.
Non potevo sperar tregua, finchè respiravano Francesco Rassu e il sacerdote Pittui.
Nell’ardore de’ miei vent’otto anni mi tormentava la sete della vendetta — ma avevo anche la pazienza di aspettare!
[193]
Alzatosi da letto, guarito dalle contusioni, il prete Pittui si mostrò più feroce che mai contro di me. Da lungo tempo la sua casa era stata il convegno de’ più tristi del paese. Fu là che i fratelli Rassu, i fratelli Dore, il commissario Serra, Giovanni Maria Piana avevano congiurato la mia cattura. Ma non erano ancora riusciti nell’intento, e parecchi di essi erano stati puniti per mano mia, o per mano del destino.
Il sacrilegio da me commesso mi aveva attirato addosso le ire di molti compaesani; il cui scopo, d’altra parte, non era stato che quello d’ingraziarsi l’influente prete, intimo amico dei principali giudici ed avvocati di Sassari
Si conoscevano da lungo tempo, in paese, le tresche, i raggiri, le prepotenze, e sovratutto i ricorsi che il buon ministro di Dio soleva mandare alle autorità di Sassari, contro gli sconsigliati che cadevano in sua disgrazia.
Dopo essere stato un mesetto in casa, il prete tornò a dir messa all’Oratorio di Santa [194] Croce; nè aveva voluto rinunziare alle sue gite a Sassari, dove si recava ogni tanto, sempre scortato da tre o quattro carabinieri, che richiedeva alle autorità per la propria sicurezza.
Trascorso qualche mese, e sbollite le ire, non mancarono in paese le persone che deploravano la non riuscita del mio attentato; perocchè il prete continuava ad inasprire gli animi colle prepotenze, creando i malcontenti.
Certo Pietro Sanna, bosano, e certo Antonio Maria Deiana, vennero un giorno da me, in campagna, offrendosi a facilitarmi il mezzo d’introdurmi in casa di prete Pittui per ucciderlo. Costoro appartenevano ad una combricola di ladruncoli, i quali si vantavano possessori di grimaldelli, che aprivano qualunque porta. Li ringraziai, ma non volli accettare la loro offerta, perchè diffidavo di essi: temevo qualche perfidia da parte del sacerdote, capace di ogni tranello, pur di avermi nelle mani.
Delle congiure che si facevano in casa del prete — come dissi altra volta — io veniva informato da persona intima della famiglia; e posso aggiungere (non lo rivelai finora a nessuno!) che la stessa serva del prete, la zia di mia moglie, mi aveva più volte fatto avvertire, che mi guardassi dai Rassu, dai Dore, e da altri. Non seppi mai spiegarmi tanta tenerezza da sua parte. Temeva forse per suo marito? aveva paura della disperazione di un bandito? sentiva forse rimorso [195] e compassione per la disgrazia toccatami? od era forse qualche recente rancore col suo padrone che la spingeva a sventargli le trame? Non son riuscito a spiegarmelo. Certo è, che dovetti alle sue avvertenze l’essere scampato a molti agguati; e potei, mercè sua, conoscere la perfidia di certi parenti ed amici, che mi tradivano in segreto. Non bisogna negare che la paura di un bandito desta in tutti una viva apprensione, e tutti fanno a gara per offrirgli protezione ed aiuto, per riceverne in cambio aiuto e misericordia — salvo più tardi a tradirlo quando capita il destro.
Una sera stavo seduto a ridosso d’un’alta roccia, a poca distanza dal paese. Vidi ad un tratto sullo stradone due preti che venivano verso Florinas dalla parte di Sassari. Mi parve di riconoscere in uno di essi Giovanni Masala Pittui, e decisi di farla finita con una buona fucilata.
Montai il grilletto, spianai l’arma, e aspettai che i due transitanti mi venissero a tiro.
Come si avvicinarono, mi avvidi di aver preso abbaglio. Erano due preti che venivano da Sassari con la solita provvista dell’olio santo per la parrocchia di Florinas.
Rimisi il fucile in spalla, e mi allontanai dal paese, sperando di essere più fortunato un’altra volta. L’assassino della mia pace domestica, il perfido istigatore di mia moglie, non doveva morire che per le mie mani. Lo avevo giurato!
[196]
***
E Maria Francesca?
Posciachè erano riuscite vane le trattative di pace per mezzo dei missionari, venuti nel settembre a Florinas, e più ancora dopo il mio attentato, vi furono malumori e dissidi fra mia moglie e i suoi genitori. Mio suocero aveva più volte cacciato da casa la figliuola, ritenendo che il vivere insieme dopo la mia latitanza non era cosa prudente, nè per l’una nè per gli altri. Si temevano gli eccessi di un genero e di un marito datosi alla macchia.
Era stata da tutti respinta, la disgraziata; e il prete stesso, che tre mesi prima l’aveva persino costretta a recarsi ai balli pubblici per farmi dispetto, ora non la guardava in faccia. Anche nel cuore di quel cane parlava forse la paura!
Si era giunti intanto ai primi di marzo, mese in cui si aspettava il parto di Maria Francesca. I suoi parenti, con soddisfazione pietosa e maligna, dicevano:
— Se Giovanni Tolu non potrà venire per assistere al battesimo della sua creatura, poco male: — non mancherà gente in paese per accompagnare il neonato, o la neonata in chiesa!
Ciò riferitomi da alcuni miei fidi, mandai un’ambasciata ai parenti di mia moglie, assicurando loro che nessuno si sarebbe permesso di [197] accompagnare la mia creatura al fonte battesimale.
— Se a quel tempo sarò vivo — aggiunsi — nessuno potrà vantarsi di questo accompagnamento, che costerebbe troppo caro. Il frutto di mia moglie non sarà portato in chiesa che dalla sola levatrice... come si pratica per i nati illegittimi!
Il minaccioso mio avvertimento sortì il suo effetto.
Il giorno 5 di marzo (1851) Maria Francesca partorì una bambina; e si avverò in seguito il mio pronostico. Fu portata al fonte battesimale senza che nessuno l’accompagnasse. I parenti di mia moglie, a cui avevo dato qualche lezione, si erano ben guardati di contrariare il mio desiderio. Sapevano che non scherzavo, e che avrei potuto mantenere la parola.
La scelta del nome di battesimo, da imporsi alla neonata, creò impicci ai parenti e provocò lunghe discussioni. Fu deciso infine, con molto senno, che la piccina fosse chiamata Maria Antonia, in ricordo delle due nonne: — della mia, Maria Antonia Scanu, e di quella di mia moglie. Maria Gàmbula.
Avvenuto il parto, i genitori di Maria Francesca si mostrarono più risoluti che mai a non volere in casa la figliuola, temendo fastidi da parte mia. Ond’è, che la disgraziata, per maggior sua punizione, fu costretta a rintanarsi in [198] una catapecchia isolata, nel centro del villaggio, dove campava stentatamente, facendo il mestiere di cucitrice d’abiti da uomo e da donna. Da nessuno ebbe un soccorso, e cominciò a risentire gli effetti della sua caparbietà e della sua disubbidienza.
Mi era stata comunicata la nascita della figliuola con tutte le formalità più scrupolose. Poche settimane dopo, Maria Francesca mi mandò un’ambasciata per mezzo di un fido amico:
— Tua moglie — ei mi disse — è richiesta come balia a Sassari, presso una famiglia di signori ricchi ed influenti, i quali potrebbero impegnarsi per la tua liberazione.
Io gli risposi:
— Dirai a Maria Francesca, che io non voglio accettare la libertà da colei che mi ha reso schiavo. Dio le ha imposto la missione di allevare la sua creatura: — faccia dunque il suo dovere!
Trascorsi alcuni giorni Maria Francesca tornò ad inviarmi lo stesso ambasciatore, prevenendomi, che aveva deciso (col mio consenso, o senza) di recarsi a Sassari come balia, affidando la propria bambina alle cure d’altra balia, in Florinas.
Risposi minaccioso:
— Dirai a mia moglie, che si guardi bene dal mettere in azione il suo proposito. Il giorno in cui ella andrà a Sassari per far la balia, io [199] le ucciderò il padre e la madre, perchè rei di non aver saputo correggerla. In seguito penserò anche a lei!
Dietro questa minaccia, Maria Francesca desistette dal suo proposito, e rimase a Florinas per allevare la sua creatura. Ella continuò a vivere miseramente nel suo tugurio, lontana dai genitori, che la trascurarono.
***
Mio suocero, come ho detto, era sempre malaticcio e non usciva di casa. Dopo la morte di Pietro Rassu e del carabiniere Maronero egli temeva la mia vendetta — poichè si era venuto a sapere, che l’agguato era stato ordito dietro il suo falso rapporto a mio riguardo. Egli sperava sempre che il prete e i suoi sicari fossero riusciti ad uccidermi, o a mandarmi alla forca.
Prete Pittui, completamente ristabilito, continuava a stancare la pazienza di tutti colle sue prepotenze, i suoi ricorsi, e i malumori che suscitava dovunque. Il suo contegno bestiale, indegno di un ministro del Signore, aveva chiamato l’attenzione dell’alto clero, nè si tardò ad inoltrare reclami contro la sua condotta scandalosa.
A Cargeghe io aveva un cugino — certo Paolo Tolu — molto amico di monsignor Varesini, allora arcivescovo di Sassari. Questo Tolu [200] era ammogliato con la nipote del canonico Scarpa rettore di Cargeghe, e più tardi canonico turritano.
Quando nel maggio monsignor Varesini, nel suo giro per la Cresima, si fermò a Cargeghe, il rettore Scarpa si affrettò ad informarlo di quanto era avvenuto fra me e il prete Pittui. Mio cugino Tolu, per le confidenze fattegli dall’amico rettore, fu in grado di fornirmi i seguenti ragguagli:
Recatosi Monsignore da Cargeghe a Florinas, volle interessarsi della mia causa. Anzitutto rampognò il prete Pittui di aver trasgredito gli ordini suoi; poichè, interdetto a dir messa per il sangue versato dietro le mie percosse, esso aveva continuato a consacrare. In seguito chiese schiarimenti ai tre preti di Florinas sulla condotta del loro compagno; ma le informazioni date non furono troppo lusinghiere.
Allora l’Arcivescovo mandò a lui il sagrestano maggiore per invitarlo a venire in chiesa: ma n’ebbe in risposta, che non poteva muoversi perchè ammalato.
Costretto finalmente a presentarsi dinanzi a Varesini, questi lo esortò severamente a smettere la superbia e la prepotenza, e a dare il buon esempio della mansuetudine cristiana, col non intromettersi nei fatti altrui.
Prima di lasciar Florinas, monsignor Varesini impose a prete Pittui di presentarsi entro la [201] settimana alla Curia di Sassari, avendo urgente bisogno di conferire con lui.
Il Pittui — colla solita scorta di carabinieri — venne a Sassari dopo gli otto giorni. Presentatosi verso le nove all’Episcopio, monsignor Varesini gli fece dire dal suo segretario che lo avrebbe ricevuto alle dieci. Ritornato all’ora indicata, lo si pregò che tornasse alle undici. E così di seguito, tre volte alla mattina e tre volte alla sera, fu per otto giorni rimandato il ricevimento, costringendo il povero prete a tante passeggiate inutili ed umilianti. Era questa una delle punizioni ecclesiastiche, che s’infliggevano dall’Arcivescovo ai sacerdoti colpevoli[27].
Trascorsi gli otto giorni, il prete Pittui si era dato a letto, dicendosi ammalato. Egli aveva preso alloggio nella casa di una mia zia — certa Catterina Angela Cugurra, moglie ad Antonio Alivesi — abitante dietro la Munizione vecchia. La famiglia Alivesi era molto amica del prete; il quale, durante la malattia, ebbe da essa cure assidue ed affettuose.
La malattia fu piuttosto lunga. Per una diecina di giorni il prete fu assalito da febbri violenti, e nel delirio non faceva che contorcersi fra le coltri, gridando ogni tanto, rivolto a mia zia:
[202]
— Eccolo... È là!.... egli viene!... Giovanni Tolu mi uccide!
E col mio nome sulle labbra, in preda a fissazioni di percosse e di ferimenti, egli morì a Sassari, nella casa in cui di consueto veniva ospitato[28].
Ebbi ragguagli della sua fine dalla stessa mia zia Catterina.
Il prete Giovanni Masala Pittui scese nel sepolcro sette mesi dopo le percosse da me ricevute — nè furono esse la causa della sua morte, come alcuni osarono asserire. Forse fu Monsignore che l’uccise!
La sua scomparsa dal mondo mi allegerì di un gran peso. Avevo la convinzione che le mie legature fossero finalmente sciolte, e che non tarderei a riacquistare l’intiera mia forza — quella forza, che il rettore di Dualchi diceva in me diminuita!
[203]
Morto il prete, i congiurati divennero più mansueti. Non avevano più impegni da soddisfare, nè odî da sposare per conto di terzi. Diversi avevano già ricevuto una buona lezione, come lo Zara ed il Piana, e non volevano cimentarsi meco, poichè avevano bisogno di vivere dal lavoro.
Lo Zara, per mezzo di amici intermediari, era venuto a spiegazioni, e gli promisi di non più molestarlo; e così parimenti avvenne di Giovanni Antonio Piana, il marito della serva. Costui, dopo la rottura del braccio, viveva in continua agitazione, e finì per raccomandarsi ad amici comuni perchè io non l’offendessi.
Un giorno lo fecero abboccare con me. Io gli dissi:
— Io non ho più ragione di dolermi di te. Fa il fatto tuo, e non verrai molestato. Ben so che sei lo zio di mia moglie; ma puoi vivere in pace, senza immischiarti nelle nostre questioni coniugali. Siamo intesi!
[204]
Il Piana fu assai lieto della nostra conciliazione; tanto più che il prete era nell’altro mondo, ed egli nulla aveva da guadagnare tenendomi il broncio.
Da quel giorno visse tranquillo, e sembrò un altro uomo; tuttavia non riebbe mai la mia intiera fiducia, poichè le riconciliazioni non mi andarono mai a sangue. Perdono sì — ma confidenza col vecchio nemico, mai!
Fatta la pace, un bel giorno Giovanni Antonio mi pregò di accettare un regalo. Egli mi donò una vecchia pistola ed un lunghissimo pugnale, che già appartenevano al prete Pittui. Accettai l’una e l’altro.
***
Il solo congiurato inconciliabile, dopo la morte del prete, era stato Francesco Rassu. Fra me e lui era un odio profondo, che ci celavamo a vicenda, in attesa di un’occasione per manifestarcelo apertamente.
Francesco mi vinceva di otto anni; era un uomo robusto, coraggioso, temerario, e fra i più forti del paese. Me ne guardavo, perchè sapevo che mi avrebbe ucciso, se gli fossi venuto a tiro. La lontana parentela, da cui eravamo vincolati, ci consigliava un po’ di ritegno; ma era un’ipocrisia reciproca.
La prima volta che mi trovai solo con lui [205] fu nelle aie di Corona maggiore, territorio di Florinas. Era di settembre, ed egli dormiva saporitamente sotto ad una pianta. Lo fissai per alcuni minuti, indeciso se io dovessi cogliere l’occasione per ucciderlo. Due pensieri me ne distolsero: la raccomandazione di mio zio, e la storia dei Reali di Francia[29].
— Ucciderlo nel sonno — pensai — sarebbe una vigliaccheria. Ho impresse le parole che il Duca Salardo rivolse a Fioravanti dormente: «— Se lo uccido, diranno che l’ho riconosciuto più forte di me! —»
Mi chinai, e lo scossi.
— Dormi così, eh?
Francesco Rassu balzò sulle ginocchia e mi squadrò quasi atterrito.
— Sì... dormivo.
Gli porsi alcuni aranci, e mangiammo.
— Come vai? — mi disse con un certo interesse.
— Così: piano piano!
Stette un momento soprapensiero, indi soggiunse:
— Ho i saluti da darti per parte di Francesco Serra di Tiesi.
— Vieni di là?
— Sì.
[206]
Il Serra ere il famoso commissario dei Carabinieri.
— Se fosse stato a Florinas — risposi con sarcasmo — non te li avrebbe dati i saluti per me! Qui però non potrebbe trovarmi... a meno che tu non mi facessi la spia!
Francesco mi guardò bieco:
— Io farti la spia... per lui?
— Guardati bene, veh? che tu non pianga i peccati di Francesco Serra!
Ci guardammo alcuni istanti in cagnesco, e lo piantai là, senz’altro dire.
Passarono alcuni mesi da quel giorno; ma quantunque odiassi a morte quell’uomo, volli rispettare la raccomandazione di mio zio, e aver riguardo al vecchio Rassu, col quale ero in buoni rapporti.
Stanco infine delle continue minaccie di Francesco, che mi venivano riferite, ero deciso di farla finita: o ammazzarlo, o farmi ammazzare.
Un giorno, che mi trovavo nell’ovile di mio zio, esclamai con amarezza:
— Io vivo da qualche tempo in angustie per il contegno di quel perfido; non mi trattiene che il tuo consiglio. Temo, però, che qualche giorno io debba pagar cara la mia ubbidienza!
Lo zio quel giorno si strinse nelle spalle, e mi rispose, senza guardarmi:
— Fa come vuoi!
[207]
Non disse altro; e poco dopo mi allontanai dal suo ovile.
Mi diedi a girovagare per la campagna, pregando la mia buona stella che mettesse Francesco a tiro del mio fucile. Ben sapevo che da qualche tempo andava vantandosi, che non avrei potuto sfuggire all’odio suo.
Il giorno seguente — vera fatalità — mentre stavo sdraiato a ridosso d’una roccia, vidi passare nella strada sottostante Francesco Rassu, a cavallo.
Balzai in piedi di scatto, spianai il fucile, e feci fuoco, quasi senza prenderlo di mira.
— Misericordia, son morto! — gridò Francesco, e precipitò di sella.
Una paesana, che veniva dietro a lui, m’impedì di constatare la sua morte. Temendo d’essere riconosciuto, mi cacciai prestamente nelle macchie, e presi il largo senz’essere avvertito.
Errai di qua e di là tutta la notte, contento del colpo fatto. Verso l’alba capitai in un ovile, ed ivi appresi che Francesco era stato trasportato a Florinas, ferito alla milza, e non mortalmente.
Mi morsi le dita per dispetto; e tanta fu la mia stizza per il colpo mancato, che decisi di recarmi la stessa sera a Florinas, per uccidere il mio nemico dentro casa.
E così feci. Approfittando delle tenebre, giunsi fin sulla soglia dell’abitazione di Francesco Rassu, risoluto di fucilarlo sul suo letto; ma, per mia [208] sfortuna, il medico, il pretore, e il cancelliere avevano fatto trasportare il ferito nella camera che dava al cortile, nè mi fu possibile tradurre in atto il mio proposito. Rimandai il colpo a un’altra volta, facendo voti che il mio nemico guarisse presto!
Un mese dopo, completamente guarito, Francesco si era alzato da letto per accudire alle sue faccende.
Quantunque non mi avesse veduto, egli era certo che il colpo non poteva essergli venuto che da me. Seppe però abilmente dissimulare, nè con alcuno mosse lagnanza dell’accaduto. Era scaltro e sapeva il fatto suo!
Un giorno chiamò a sè i miei fratelli Peppe e Giomaria, e disse loro che aveva bisogno di parlarmi.
Quando mi comunicarono il desiderio di Francesco, risposi a’ miei fratelli:
— Datemi prima da mangiare, e poi conducetemelo. Mi troverete alla Serra, vicino al villaggio.
In compagnia de’ miei fratelli e di un suo cognato, Francesco Rassu venne sul tardi all’appuntamento.
— Buona notte! — disse con tono secco.
— Buona notte! — risposi — Come vai?
— Coi piedi! — esclamò bruscamente.
— Non ti chiedo notizie dei piedi, ma della tua ferita!
[209]
Francesco capì che bisognava cambiar tono.
— Non vedi — disse — che mi hanno bucato le costole? Sono qui venuto per parlarti a quattr’occhi!
— Perchè a quattr’occhi? Qui non vedo che tuo cognato e i miei fratelli. Siamo dunque in famiglia, e puoi parlare in faccia a tutti. Nessuno dei presenti ti vuol male, poichè ci unisce un vincolo di parentela.
Francesco, com’era venuto, si era messo al mio fianco; ed avevo notato che teneva le mani sotto al cappotto, carezzando forse la sua pistola. Io stava ad occhi aperti, colla destra sul pugnale, risoluto a freddarlo al minimo movimento. Per fortuna non si mosse, perchè i miei fratelli gli piantavano gli occhi addosso.
— Che vuoi dunque? — gli chiesi, vedendo che esitava a parlare.
— Mi hanno bucato le costole! — ripetè con amaro sorriso — ed io vengo per chiederti aiuto nella vendetta. Sarai compensato con danaro, o con pari aiuto se ne avrai bisogno.
Sogghignai amaramente, e gli risposi con calma glaciale:
— Te ne sei accorto troppo tardi! Tu ben lo sai, che non son buono a nulla! — Quando hai tentato di uccidere Pietro Pintus, ti sei rivolto ad altri, e non a me; e ciò sa tutto il mondo!
Quando hai ucciso Giomaria Ledda, fosti pagato dal signor Antonio Luigi; ma non avesti [210] bisogno del mio braccio. — Quando hai freddato l’uccisore di tuo fratello Paolo (ch’era in tresca con una sua sorella) non chiedesti il mio aiuto, nè compenso in danaro; e con ragione, perchè la tua vendetta era santa. — Quando vilmente hai assassinato l’eremitano di Santa Maria d’Ese per rubargli i porcellini, non è a Giovanni Tolu che hai chiesto mano forte. — Quando a Tissi hai commesso la grassazione in casa del signor Sercis e della sua signora, non hai avuto bisogno dell’opera mia. — Quando, infine, dentro Florinas, hai derubato la casa di Salvatore Piras, non è a me che ti sei rivolto per tenerti il sacco. Te lo ripeto: io non son buono a nulla; e con ragione non mi hai cercato!
— Hai finito?
— Non ancora. Devo dirti una sola cosa, che terrai a mente: — se tu verrai ucciso facendo il fatto tuo, puoi star sicuro che ne proverò dispiacere; ma se mai ti uccideranno facendo il fatto altrui, ti prevengo che godrò della tua morte. Bada, dunque, a’ tuoi affari, Francesco, se vuoi vivere tranquillo! Ricordati, che a Florinas non sono pochi quelli ch’ebbero la disgrazia di essere, come te, feriti; eppure, ravveduti dei loro errori, non hanno più ricevuto alcuna molestia dai nemici. Così pure potrà avvenire di te... se metterai giudizio.
Francesco, a capo chino, ascoltò fino in fondo la mia tirata, senza un atto di dispetto nè d’impazienza.
[211]
— Ho capito, e sta bene! — borbottò; e senz’altro fece cenno a suo cognato d’incamminarsi, e si mosse lentamente verso Florinas — seguito dai due miei fratelli; i quali avevano il dovere di scortarlo fino alla sua abitazione, come si usa in simili convegni.
***
Una settimana dopo venni avvertito, che Francesco si era scatenato contro di me senza alcun ritegno — non curandosi di celare la sua ferma intenzione di uccidermi, dovunque mi avesse trovato. Egli si recava sfacciatamente a far visita di casa in casa in Florinas, e d’ovile in ovile in campagna, col proposito di farmi la spia.
I barracelli — quasi tutti in mio favore — mi tenevano informato d’ogni sua mossa, e mi avvertivano di stare in guardia e di non fidarmi.
Infastidito di questi continui rapporti, capitai una sera nell’ovile dello zio Rassu, col quale mi tenevo in buoni accordi. Lo trovai sulle furie contro il suo nipote Francesco, col quale la mattina si era bisticciato, a causa del passaggio di un branco di pecore sul fiume vicino.
Approfittando del suo stato d’animo, gli dissi con risentimento:
— Zio Giovanni Andrea; devo dirvi che più non riesco ad aver pace per colpa di Francesco. [212] Non siete dunque più buono a correggere vostro nipote?
— La sola palla riuscirà a correggerlo — lasciò scapparsi il vecchio, ancora sdegnato per il diverbio avuto col nipote.
— Dunque...?
— Dunque, se hai conti da liquidare con Francesco, sei matto se non ti aggiusti!
Il vecchio non disse altro, nè d’altro gli parlai, per paura di fargli cambiar idea. Mi allontanai dicendogli:
— Buona sera... e a rivederci!
— Buona sera!
Per tre giorni consecutivi diedi a Francesco una caccia senza tregua. Arrivai persino ad impostarlo, dopo l’imbrunire, a pochi passi dalla sua abitazione, dentro Florinas; ma non mi venne fatto d’imbattermi in lui. La gente era per le vie, lungo le viottole, ed io non volevo troppo espormi.
Non è facile nei nostri villaggi tendere l’agguato ad un uomo; poichè colui che crede di aver nemici non batte mai la stessa strada, sì nell’uscire, come nell’entrare in paese.
Dopo la terza notte ch’io tentavo Francesco, mi venne l’idea di fargli la posta in un punto non troppo lontano dal paese, per dove speravo potesse ei passare per recarsi in campagna. Il mio nemico cambiava cento volte di strada, ed io doveva affidarmi al solo caso.
[213]
L’inferno questa volta volle favorirmi.
Ero stato colà tutta la notte, intirizzito dal freddo. Mancavano ancora due ore all’alba, ed eravamo ai primi di gennaio.
Mi ero dato a percorrere per lungo e per largo la regione di Badu ludrosu, quando vidi un individuo a cavallo che percorreva una viottola, seguito da un braco.
Non ne feci caso, perchè avevo notato che quell’uomo aveva le brache di lino, e non i calzoni neri che soleva portar Francesco. Tuttavia volli tenergli dietro per curiosità, perchè mi parve di riconoscere il suo cane.
Rifeci un lungo giro per le tanche, fino a trovare una posta comoda e sicura.
Era proprio lui: Francesco Rassu, armato, e a cavallo. Io era a piedi.
Mi fermai al punto di Pedru majolu; montai il grilletto del fucile, e, quando Francesco mi venne a tiro, gli sparai.
Il colpo non partì; ed egli continuò la sua strada senz’alcun sospetto.
Gli tenni sempre dietro saltando siepi e scavalcando muri, e tornai a montare il grilletto, dopo aver rinnovato il fulminante.
Mancatomi il colpo anche questa volta, mi venne in mente una rivelazione fattami parecchie settimane addietro. Francesco Rassu, dopo esser stato da me ferito, era andato a consultarsi da un suo zio frate; il quale lo aveva esorcizzato, [214] assicurandogli che di piombo non sarebbe più morto.
Per alcuni sassi da me smossi saltando un muro, Francesco si accorse finalmente d’essere pedinato; e allo sbocco d’una stretta gola smontò da cavallo, con animo deliberato di affrontare l’avversario. Era un uomo coraggioso ed audace, e faceva assegnamento sulla propria forza.
Senza più esitare gli andai arditamente incontro; spianai il fucile, e feci scattare il grilletto.
Neanco questa volta l’arma prese fuoco.
Il Rassu, colto all’improvviso, fece un brusco movimento, come per scansare il colpo; ma io, vedendomi ormai perduto, colla sveltezza di un gatto selvatico, gettai a terra il fucile, spiccai un salto, e mi riuscì di afferrare la canna della sua pistola, nel momento che egli me la scaricava quasi a bruciapelo. Era un pistolone antico, a piastra; la pietra focaia aveva acceso la polvere nella cassetta, ma il colpo non era partito.
Io stringeva colla destra il suo pugno, e colla sinistra giunsi ad afferrarlo per i lunghi capelli, che gli scendevano sulle spalle. Francesco, alla sua volta, mi teneva per la barba, e cercava di colpirmi alla testa colla canna della pistola.
Restammo alcuni minuti in piedi, lottando corpo a corpo con tutte le forze, per disvincolarci. Era questione di vita o di morte: uno di noi quel mattino doveva scomparire dal mondo.
I nostri due cani abbaiavano, ma non osavano [215] avventarsi, poichè nessuno di noi si curò di aizzarli.
Finalmente il mio avversario vacillò, perdette l’equilibrio, e stramazzò supino, dando fortemente della testa sopra una grossa pietra, ch’era in mezzo alla strada. Il sangue gli colava dalla nuca.
Continuammo la lotta disperata. Nel silenzio di quel mattino tenebroso non si udivano che i latrati dei due cani, e il rantolo affannoso che usciva dalle nostre strozze.

Francesco riuscì a rizzarsi sulle ginocchia e continuava a percuotermi colla canna del pistolone. Ricadde.
Finalmente mi venne fatto di portare la mano all’elsa del mio pugnale; lo tolsi dal fodero, e glie lo immersi nel petto.
Egli allora gridò con quanto fiato aveva in gola:
— Perchè mi uccidi, Giovanni Tolu?!
— Oggi le paghi tutte! — gridai inferocito e ansante; e continuai a ferirlo a più riprese, [216] passandolo parte a parte, fino a che dal suo labbro non uscì neppur l’alito[30].
Chi lo avrebbe mai detto? La lama di prete Pittui, lunga due palmi, mi era servita a liberarmi dal più odiato de’ suoi sicari!
Ricacciato il pugnale nel fodero, continuai soddisfatto la mia strada, seguito dal mio fido Pensa pro te.
L’altro cane era rimasto vicino al cadavere del suo padrone, poco distante dal cavallo, il quale rosicchiava tranquillamente qualche ramo verde che usciva da un cespuglio.
[217]
Quando più tardi giunsi a conoscere la perizia giudiziaria sull’assassinio di Francesco Rassu, un sorriso di compassione mi venne sulle labbra. Il medico ed i periti avevano dichiarato, che la vittima era stata assalita da quattro uomini, e che la prima ferita alla nuca era stata prodotta da un colpo di bastone. Fu parimenti dichiarato, che Francesco era stato grassato, dopo aver ricevuto oltre trenta ferite. Fidatevi ora delle perizie ordinate dall’autorità giudiziaria!
Appresi in seguito, che il primo che s’imbattè nel cadavere di Francesco fu un suo zio, fratello della suocera, il quale si era impossessato del pistolone, che tempo addietro aveva regalato al nipote. Da ciò l’asserzione dei periti.
Il sole era appena spuntato, quando capitai in un podere, in cui lavoravano alcuni miei amici. Fra essi era Giovanni Antonio Piana, col quale mi ero riconciliato.
[218]
Come mi vide, costui mi venne incontro per dirmi ch’era mancato un bue, e che si sospettava lo avesse rubato Francesco Rassu. Mi raccomandava di fare indagini per rintracciarlo.
— Posso assicurarti — risposi — che il ladro non è Francesco. L’ho lasciato or ora a Pedru majolu, e in condizioni tali, che non potrà più rubar buoi... nè farmi la spia!
E così dicendo lanciai uno sguardo significante al marito della serva del prete, per fargli capire che avrebbe fatto la stessa fine, se non si fosse in tempo ravveduto.
La stessa mattina andai a trovare mio fratello Giomaria e un mio cognato, che zappavano in un podere vicino. Confidai loro che avevo ucciso Francesco Rassu.
Verso sera, passando dinanzi all’ovile di Giovanni Andrea (lo zio di Francesco) volli entrarvi per salutare il vecchio.
Appena egli mi vide, mi si piantò di botto dinanzi; e dopo avermi a lungo fissato cogli occhi spalancati, mandò dalla gola rantoli e sbuffi. Uscì infine in queste parole:
— Non è la morte di Francesco che mi dispiace; ma lo scempio fatto al suo cadavere! Crivellarlo con trenta pugnalate? è azione indegna, vigliacca!
Il sangue mi montò alla testa; e facendo un passo verso il vecchio gli mostrai il pugno, gridandogli minaccioso:
[219]
— Segno che tante glie ne abbisognavano!
E aspettai una seconda frase insultante, per freddare a’ miei piedi un altro Rassu.
Per fortuna egli non fiatò, nè si mosse; ed io mi allontanai voltandogli le spalle, senza neppur salutarlo.
***
Per distrarmi alquanto mi recai alla Nurra, dove rimasi alcune settimane.
Mi trovai colà più volte con Salvatore, il figlio di Giuseppe Rassu, che da qualche tempo era al servizio di mio cognato Ignazio Piana. Quantunque il giovane cercasse di avvicinarsi a me, io lo tenevo a debita distanza, perchè nipote de’ miei nemici.
Intanto nell’estate (tempo in cui si sogliono condurre le pecore al Fiume Santo per abbeverarle) Salvatore ebbe un diverbio con un suo compagno; e dopo avergli spezzato il cranio con un grosso sasso, si era dato alla macchia. Portatosi allora segretamente a Florinas, per chiedere alla zia ed al prete parte del danaro lasciato loro in custodia, gli fu risposto:
— I tuoi danari ci serviranno per toglierti alle mani della giustizia; e così potrai goderteli!
Essendo figlioccio del prete, col quale la zia conviveva, Salvatore si rassegnò ad aspettare; ma intanto, passando per Cargeghe, volle ivi consultarsi [220] col bandito Antonio Maria Derudas (che in quel tempo mi era compagno, come dirò in seguito).
Poco dopo venni chiamato da zio Giovanni Antonio Rassu; il quale mi confidò, che il pretore di Ploaghe desiderava abboccarsi col giovane Salvatore, per giovargli nella causa. Egli chiedeva il mio parere.
— Se tuo nipote andrà dal pretore, te lo manderà in galera! — risposi.
Il vecchio allora mi disse con accento di preghiera:
— Perchè non lo prendi in tua compagnia per guidarlo?
— Perchè non lo voglio! — risposi recisamente — Egli si mostrò disubbidiente col babbo, colla mamma, collo zio, e lo sarà parimenti con me. Non assumo una simile responsabilità. Se Salvatore venisse ucciso, si darebbe a me la colpa!
Così risposi, perchè non potevo fidarmi del vecchio nè del giovane Rassu, dopo quanto mi era accaduto a Pedru majolu. Sarebbero stati capaci di un tranello per vendicare il loro congiunto da me ucciso.
Quantunque nessuno mi avesse veduto, la voce pubblica mi accusava della morte di Francesco; ed i parenti ne erano certi, perchè io non avevo cercato di smentire la diceria. Nessuno di quelli a cui avevo confidato l’omicidio poteva parlare; poichè in quei tempi l’esser chiamato a [221] testimonio era doppiamente pericoloso: verso la giustizia, e verso i protettori dell’ucciso.
Il giovane Salvatore, a cui era nota l’intenzione di volerlo a me affidare, aveva esclamato imprudentemente:
— Perdio! avrei vergogna di accompagnarmi coll’uccisore di mio zio Francesco, ch’io devo vendicare. Toglierò dal mondo Giovanni Tolu!
— Bambino imbecille! — esclamai, quando mi vennero riferite le sue parole.
***
Annoiato della mia solitudine, durata per oltre un anno, mi ero unito in quel tempo ai banditi Antonio Maria Derudas e Gio. Maria Puzzone, di Cargeghe; i quali battevano la campagna dopo l’assassinio del capitano de’ barracelli, da loro freddato nel piazzale della chiesa del paese, mentre rincasava.
Un giorno il vecchio Giovanni Andrea Rassu ebbe l’imprudenza d’invitare il Derudas ad unirsi a Salvatore per sbarazzarsi di me.
— Mio nipote è troppo giovane — gli aveva detto — e da solo non potrebbe fare il colpo.
Il Derudas tenne il segreto per alcuni giorni; ma siccome in precedenza mi aveva informato dell’abboccamento chiestogli dal vecchio Rassu, finì per tutto confessarmi.
Da quel giorno Salvatore fece il gradasso, [222] fidando forse nell’aiuto del Derudas. Sulle prime presi le cose in scherzo; ma in seguito, persistendo egli a darmi noia, decisi di dargli una lezione.
Non tardò anche lui a seguire lo zio. Egli venne ucciso da una fucilata vicino alla lacana d’Ossi, in territorio di Florinas. Il cadavere fu trasportato sulle fascine al villaggio[31].
***
Ed ecco quattro dei Rassu — Pietro, Paolo, Francesco e Salvatore — tolti dal mondo per mano mia, o per mano d’altri!
Ne restavano ancora due; ma di essi volle occuparsi l’Eterno, poichè io feci loro grazia.
Giuseppe Rassu, l’ultimo dei quattro fratelli, (come ho già detto) era ammogliato con una mia zia, la quale mi voleva un bene dell’anima.
Un giorno andai a trovarla, e le dissi:
— Cara zia, bada! temo molto che non tarderai a diventar vedova!
— Che intendi dire? Mio marito è sano e robusto.
— Ma io l’ucciderò, se non farà da bravo. Egli ha sinistre intenzioni a mio riguardo.
[223]
— Non temere, Giovanni. Tu sai ch’io ti voglio bene. Se io mi accorgessi che Giuseppe avesse intenzione di farti male, sarei la prima a renderti avvisato. Egli mi è marito, e tu mi sei nipote: vi ho cari entrambi. Non potrei permettere che tu l’offenda, perchè c’è di mezzo il giuramento del matrimonio; — ma parimenti vedrei di mal occhio che egli torcesse un capello a mio nipote. Va tranquillo, figliuolo mio; finchè io vivo non riceverai il minimo danno da lui!
E mantenne la parola. Donna energica e risoluta, ella seppe imporsi al marito, che mi lasciò in pace, come in pace lasciai lui.
Risparmiai parimenti il vecchio zio Giovanni Andrea Rassu, che si rassegnò alla perdita dei suoi quattro nipoti, puniti dalla giustizia di un Dio, che odia i traditori e le spie.
L’uno e l’altro morirono tranquilli sul proprio letto — quantunque non meritassero una simile fortuna!
[224]
Recatomi un giorno alla Nurra, capitai nell’ovile di Campanedda, dov’era stato ucciso Agostino Alvau: il giovane algherese, che finì la sua carriera di bandito, quasi nello stesso tempo in cui io la cominciava. Ebbi dai pastori minuti ragguagli sulla morte di costui; ed io ne tesserò brevemente la storia, quantunque essa non abbia relazione con la mia vita.
Agostino Alvau era un giovane studente di Alghero. D’animo focoso, audace, e coraggioso fino alla temerità, un giorno era andato a caccia senza porto d’armi. Sorpreso dai carabinieri, e invitato a cedere l’arma, egli rispose colla ribellione. Riuscito a fuggire, si diede alla macchia, e iniziò la sua carriera di bandito, senza aver sparso una goccia di sangue umano.
Quantunque giovanissimo, senza un pelo in faccia, e di fattezze femminili, divenne in breve famoso per le sue gesta, tanto audaci quanto feroci.
[225]
Mi era simpatico perchè lo avevo conosciuto di persona. Qualche tempo prima ch’io prendessi moglie, mi trovavo a capo d’una compagnia di mietitori, nelle aie di Florinas. Avevo sotto al mio comando molti lavoratori. Tra i quali Rafaele Alvau — fratello di Agostino — uno degli incaricati della trebbiatura. Una quantità di cavalli e di cavalle, condotti dai paesi vicini, trottavano sulle aie per pestare i covoni, com’è costume nei nostri villaggi.
Agostino Alvau (già famoso nell’isola) era venuto in quel tempo a Florinas, per visitarvi il fratello Rafaele. Travestito da zappatore sassarese, ma armato di fucile e di coltello, si presentò a noi come acquisitore di grano, in compagnia del massaio Antonio Sanna e di certo Vincenzo Paschino, padrone delle cavalle del signor marchese (?).
Siccome Rafaele era al mio servizio per la trebbiatura, i tre visitatori vennero ad alloggiare in mia casa. Fu allora, che, in tutta confidenza, Agostino mi si diede a conoscere. L’ospitai per un giorno, e sul tardi tornò alla campagna.
Per pochi anni Agostino Alvau fece il bandito, ma bastarono per renderlo celebre. Mentre un giorno attraversava un ponte sulla strada che da Alghero conduce alla Murra, fu circondato da molti carabinieri, che gli avevano teso un agguato; ma egli colla pistola alla mano, [226] seppe affrontare gli armati, e sfuggì loro audacemente tra il fischio delle palle.
Poco dopo egli cercò di disfarsi di certo Antonio Maria Tanchis, che la voce pubblica designava qual commissario dei carabinieri. I commissari saranno sempre i benemeriti della società, ma per i banditi non sono altro che spie!
Fra gli amici più fedeli di Agostino Alvau erano i fratelli Paolo e Antonio Sechi della Nurra — il primo dei quali fra i migliori tiratori ch’io mi conobbi. Lo ricevevano con molta cordialità — come d’altronde si ricevono tutti i banditi... per amore o per forza!
Abitava a Sassari in quel tempo un tal Antioco Agus, di Bonorva, in fama di uomo faceto e di poeta estemporaneo. Poeta e faceto era del pari il commissario Tanchis, che pretendeva superarlo nell’improvvisare i versi
Intimo dei pastori nurresi, ed uomo doppio, l’Agus cercava di strappare qualche segreto al commissario, sapendo che costui congiurava contro la libertà degli amici. Un giorno lo invitò ad entrare in una bettola, col pretesto di una sfida poetica; ma il Tanchis lasciò sfuggirsi:
— Oggi non posso, perchè devo recarmi ad Osilo coi carabinieri, per un bandito che dobbiamo tradurre a Sassari. Accetterò con piacere la gara al mio ritorno!
Fu sollecito l’Agus d’informare del caso i due pastori Secchi e l’Alvau; i quali vennero a [227] Sassari, e in compagnia del poeta si recarono sul tardi al Molino a vento, per preparare un agguato al commissario Tanchis, che di là doveva passare coi carabinieri, diretti ad Osilo.
Giunti a cavallo sul luogo designato, i quattro uomini si appiattarono di fronte al predio del prete Ciboddo.
Finalmente, ad ora tarda, passarono di là dodici carabinieri, che circondavano il commissario Tanchis, loro guida.
Fu primo Alvau a far fuoco sulla spia; ma il colpo gli andò fallito. Sparò in seguito Paolo Secchi, e la sua palla attraversò il corpo del Tanchis, che cadde fulminato da cavallo.
Sgomentati per gli spari nell’oscurità, i carabinieri tornarono indietro a spron battuto. I due Secchi e l’Alvau ripresero la via della Nurra; ma l’Agus, a cui era scappato il cavallo, si vide costretto a rientrare a piedi in Sassari per la porta di Sant’Antonio. Volendo allontanare il sospetto, il poeta ebbe l’accortezza di presentarsi l’indomani al capitano dei barracelli, per denunziare la bestia che gli era mancata.
Altra impresa ardita, a cui l’Alvau dovette la popolarità, fu l’uccisione di Antonio, detto Ammmazzacavalli — uno dei più famosi cavallerizzi e domatori del tempo. Commissario anch’esso dei carabinieri, si era vantato bastargli l’animo di arrestare il forte algherese, inseguendolo a cavallo.
[228]
Informato il giovane bandito della minaccia di quel millantatore, giurò di ucciderlo. Temerario com’era, osò una sera vestirsi da prete e presentarsi alla casa di Ammazzacavalli, posta nel rione di San Donato. Ma il colpo gli andò a vuoto.
Immaginò allora un nuovo strattagemma, togliendo a pretesto il carnevale.
Era usanza a Sassari di andar mascherati a cavallo, per trar sollazzo dal getto dei confetti.
Abbisognando di un compagno per eseguire il suo disegno, l’Alvau si era rivolto ad Antonio Sechi.
In un giorno festivo, in cui la piazza Castello rigurgitava di maschere e di curiosi, i due amici salirono per il Corso, inforcando due superbi cavalli. Avevano una gonnella al collo, la maschera al viso, e le pistole nascoste sotto le vesti. Inoltravano al passo, distante l’uno dall’altro, come se ciascuno si divertisse per proprio conto.
Antonio Sechi, che si spingeva avanti, aveva ricevuto la consegna di gettare i confetti sulla folla, non appena avesse adocchiato l’Ammazzacavalli. Al resto doveva pensare l’Alvau.
Erano giunti così fino al centro di piazza Castello, dove la folla era immensa. Da per tutto si ballava, si gridava, si faceva getto di coriandoli, per far disperare le signorine che ridevano come matte.
[229]
Finalmente l’Alvau, che aspettava con ansia il segnale convenuto, vide il compagno lanciar con furia manate di confetti alla folla. Spinse avanti il cavallo, e scorse a breve distanza lo Ammazzacavalli, che se la rideva in mezzo ad un crocchio d’allegri amici.
Gli fe’ cenno colla mano di avvicinarsi, e quegli incautamente gli obbedì:
— Che vuoi, maschera?
— Fammi un piacere. Accorciami di un punto la cinghia che regge la staffa. Sto male in sella.
L’Ammazzacavalli, senza nulla sospettare, si fe’ presso al cavaliero, e si chinò ad aggiustargli la staffa.
Colla rapidità del lampo, il giovane bandito gli puntò la pistola sulle spalle, lasciò partire il colpo, die’ di sprone al cavallo, ed uscì dalla porta Castello, facendosi largo tra la folla compatta.
L’Ammazzacavalli era caduto bocconi, mortalmente ferito. Gli astanti, atterriti, gridarono al soccorso, all’assassino, e si sbandarono di qua e di là, come sfuggendo ad un pericolo immaginario.
Antonio Sechi, come nulla avesse veduto, continuava indifferente il getto dei confetti, mentre l’Alvau, a precipizio, divorava la strada che conduceva al Pozzo d’Arena. Montava un ottimo cavallo (fattosi prestare da Gavino Spanedda di Nurra) e l’inseguirlo non era impresa facile.
[230]
Alcuni carabinieri — che conducevano a mano i cavalli all’abbeveratoio — udendo le grida della gente, cercarono fermare il fuggitivo; ma questi, mostrando loro la pistola, seppe tenerli lontani.
Arrivato allo stabilimento Lombardi, Agostino rallentò la corsa, mise il cavallo al passo, ed entrò tranquillamente in Porta d’Utzeri, internandosi verso turritana, per riparare in casa di alcuni amici nurresi.
Dicesi che la stessa sera Agostino Alvau, vestito da donna, avesse osato presentarsi all’ospedale (dove il moribondo era stato ricoverato d’urgenza) risoluto di finirlo a pugnalate. Egli dichiarò d’essere la madre del ferito; ma non fu lasciato entrare, stante l’ora tarda.
***
Questo giovane coraggioso, audace in modo straordinario venne ucciso a tradimento nella Nurra; e dirò come.
Fra gli ovili che l’Alvau soleva visitare, era quello di Giovanni Careddu, ammogliato con giovane e bella donna, e senza figli. Spensierato e fidente nel proprio coraggio, il galante bandito si era dato a corteggiare la moglie dell’amico. Costei conviveva con una sorella belloccia, fidanzata a Giuseppe Sale, giovane sassarese, che pur frequentava l’ovile.
[231]
Accortosi il Sale della tresca dell’Alvau, disse un giorno alle due sorelle:
— Perchè accogliete quell’uomo in casa vostra? Mandatelo via, se non volete aver danno!
La moglie del Careddu riferì segretamente al suo Agostino le parole del Sale, facendogli quasi intendere che di lui fosse geloso.
Alvau, senz’altro, tolse di mezzo l’importuno con una fucilata.
Poco tempo dopo, trovandosi insieme i due banditi cugini, Antonio Santo Careddu di Sorso e Paolo Careddu di Sennori, dissero ad Agostino Alvau:
— Senti, giovinotto. A noi pare che le tue visite all’ovile di Campanedda siano troppo frequenti. Si direbbe che ti sei liberato di Giuseppe Sale, per renderti padrone anche della sua fidanzata. Intendiamoci bene! — noi siamo disposti a far giuramento di non offenderci a vicenda; ma se tu non ti allontani dalla casa del nostro congiunto Giovanni, ci terremo sciolti da ogni promessa. Lo sai!
Agostino Alvau — sdegnoso sempre d’ogni consiglio, e sempre più invaghito della giovane moglie — non solo si astenne dalle visite all’ovile di Careddu, ma vi andò con più frequenza, e rese più scandalosa la tresca.
Era acciecato d’amore — e l’amore doveva perderlo!
Da qualche tempo il Governo aveva promessa [232] l’impunità ed un premio in danaro a qualunque bandito avesse ucciso, o fatto arrestare Agostino Alvau. I due cugini Careddu pensarono di ottenere l’una e l’altro, vendicando in pari tempo il loro congiunto tradito.
In un giorno piovoso si trovarono riuniti nell’ovile di Campanedda Paolo Careddu, Antonio Santo, e Agostino Alvau. Si giuocava alle carte, e Paolo si era seduto a fianco di Agostino. A un certo punto Antonio Santo esclamò con stizza:
— Ma perdio! c’è un fumo d’inferno qua dentro!
E così dicendo si era alzato con impeto, fingendo correre alla porta per aprirla; ma giunto vicino all’uscio, si voltò di scatto, e vedendo Agostino intento alla partita, gli puntò il fucile addosso e fece fuoco[32].
Quantunque mortalmente ferito in pieno petto, l’Alvau balzò in piedi, e portata la mano all’elsa del suo lungo stocco, cercò snudarlo per avventarsi sul traditore. Paolo, però, che stava attento, gli afferrò le due braccia da tergo, in modo che l’arma non uscì che a metà dal fodero.
L’Alvau, ad un tratto, si contorse, mandò [233] un sordo rantolo, e stramazzò come fulminato. Era morto.
Antonio Santo era uscito con furia all’aperto per correr dietro a compare Maurizio; il quale venuto all’ovile in compagnia d’Alvau, era rimasto in una stanza vicina. Prevedendo la catastrofe, costui si era salvato saltando da una finestra e cacciandosi nel vicino bosco.
A poca distanza dall’ovile — nella Valle del legname — trovavasi certo Giovanni Manunta; il quale, saputo il caso, montò in sella e a spron battuto si recò a Sassari per informare le autorità, che Antonio Careddu e Antonio Santo erano degni di premio, avendo ucciso il terribile bandito algherese.
Maurizio, alla sua volta, era corso a Portotorres per annunziare ai carabinieri l’uccisione di Agostino Alvau.
Nel frattempo Antonio Santo, afferrato il cadavere d’Agostino per i piedi, lo aveva trascinato all’aria aperta, fino al limite del piazzale.
Accorsi primi i carabinieri di Portotorres, scaricarono i loro fucili sul cadavere, fingendo aver ucciso il bandito algherese in uno scontro.
Il governatore di Sassari però, che in precedenza aveva ricevuto l’avviso della morte di Alvau, non tardò a concedere la promessa libertà ai due cugini uccisori, ed a punire i carabinieri [234] per l’assalto simulato che venne scoperto e facilmente provato[33].
Questa la versione veridica della fine di Agostino Alvau, da me attinta a fonte non dubbia.
[235]
Ho già parlato dei due banditi Antonio Maria Derudas e Giovanni Maria Puzzone, di Cargeghe, datisi alla campagna dopo aver ucciso il capitano dei barracelli, che li disturbava nelle loro imprese rapaci. Questi giovani vagabondi erano ladruncoli, che prendevano diletto a uccider buoi e cavalli, a danno del barracellato.
Poco dopo l’uccisione del capitano, un altro giovine di Cargeghe — Angelo Masala — uccise certo Manconi suo compaesano, e sfuggì alla giustizia dandosi alla macchia. Si ebbero così, in breve tempo, tre banditi di Cargeghe.
Il fratello dell’ucciso — Giovanni Manconi — volendo vendicarsi dell’assassino, chiese l’aiuto dei due banditi Derudas e Puzzone; e tutti e tre riuscirono a freddare con una fucilata Angelo Masala, che sotterrarono in campagna, senza che alcuno li vedesse.
Il prete Luigi Tolu di Cargeghe, mio cugino, un giorno si rivolse a me, pregandomi di proteggere il bandito Derudas, che voleva liberare [236] ad ogni costo, ritenendolo un disgraziato, più che un cattivo soggetto. E fu dietro alle sue insistenti raccomandazioni, che mi decisi ad unirmi col Derudas e col Puzzone, coi quali rimasi per circa un anno, sebbene non di continuo.
Un giorno, insieme al Derudas, attraversavo il sito detto Sa funtana de sa piarosa, di fronte alla cantoniera di Campomela, nel tenimento di Don Battista Solinas di Cargeghe. A un certo punto il mio compagno si fermò, e, indicandomi una zolla, mi disse sorridendo:
— Vedi? Io, Puzzone e Manconi abbiamo qui seppellito il cadavere di Angelo Masala!
Trascorsi quattro o cinque mesi, il Puzzone fu arrestato; ed io continuai a tener compagnia al Derudas, separandomene però di tanto in tanto, poichè diffidavo di lui.
Due volte, in quel tempo, mi riuscì di sfuggire ad un agguato di carabinieri.
La prima volta fu nel salto di Banari. Mi ero cacciato in una grotta della Scala di Antonio Faedda (territorio di Florinas) dove passai una notte ed un intiero giorno. Recatomi in seguito nell’ovile Panzano (a Giunchi) i nostri cani abbaiarono fermi — indizio che vedevano gente ferma. In quei dintorni, infatti, erano appiattati una ventina di carabinieri. Pensai di attraversare il campo deludendo la loro vigilanza. Mi cacciai il cappuccio sugli occhi, chiesi a un pastore le pecore, e mi diedi a guidarle, passando arditamente [237] in mezzo a’ miei nemici, che continuavano a tener d’occhio l’ovile. Fui salvo.
La seconda volta mi trovavo nello stesso ovile, dove avevo passato la notte insieme a Derudas. Verso l’alba diedi ordine ad un mandriano d’esplorare i dintorni, raccomandandogli, che, nel caso avesse visto carabinieri, si fosse affacciato alla roccia de sas coas de medallu, gridando: — I buoi non ci sono! — Quel semplicione, invece, gridò forte al suo padrone:
— Zio Antonio Luigi, ci sono i carabinieri!
Ne avevo veduto sei a cavallo nella pianura; gli altri erano appostati nel bosco, credendo che per di là noi si scappasse. Svegliai il Derudas che dormiva; girammo la collina, salimmo la montagna, e di là scorgemmo i carabinieri, che ci aspettavano al varco. Anche questa volta, con un po’ di astuzia, ero riuscito a sfuggire a un agguato, preparato con molta sagacia militare.
Lascio i carabinieri per narrare i miei casi col Derudas.
Nel territorio di Banari era il molino di proprietà della contessa Musso. Il mugnaio, che lo aveva in affitto, viveva in continui litigi colla propria moglie, poichè costei teneva seco una bambina illegittima, che turbava la pace domestica.
Tanto io, quanto il mio compagno Derudas, capitavamo con frequenza nel molino, e la moglie del mugnaio si sfogava con noi, mettendoci a parte dei disaccordi coniugali.
[238]
Un giorno che mi trovai solo con essa, la moglie inasprita mi raccomandò caldamente di liberarla dal peso del marito, uccidendolo.
Feci di tutto per smuoverla dal suo proposito: — Metti giudizio, e sta savia! — le dicevo — Non dar retta ai tristi consigli della tua coscienza. Fa la pace con tuo marito, e vivete tranquilli!
Il mugnaio era un buon uomo; ci dava ospitalità con piacere, e di tanto in tanto mi regalava qualche scudo. M’irritavano, dunque, gli eccitamenti di quella femmina, che ad ogni costo voleva diventar vedova.
Ma la donna è tenace ne’ suoi proponimenti di vendetta; e la moglie del mugnaio, vedendo la mia ripugnanza a compiacerla, mi lasciò in pace. Ella si rivolse segretamente al mio compagno, a cui offrì sessanta scudi per eseguire il colpo.
Il bandito Derudas si lasciò, convincere dal danaro e dalle tenerezze della bella mugnaia; e un bel giorno, con una buona fucilata, le tolse dal fianco l’importuno marito.
Quando appresi il fatto, rimproverai acerbamente il mio compagno:
— Che cosa hai fatto? Perchè uccidere l’uomo che ci dava a mangiare e ci offriva asilo nei giorni del pericolo? Sei un tristo e un miserabile!
Il Derudas si strinse nelle spalle e mi disse:
— Oh, sta a vedere che un bandito dovrà lasciarsi vincere da uno scrupolo!
[239]
Avvenne intanto, che il mio compagno erasi pazzamente innamorato di Maria Grazia, la bellissima vedovella di un altro mugnaio, il quale conduceva il molino di San Lorenzo, nei dintorni di Florinas, da me pure frequentato. Antonio Maria Derudas fece di tutto per celarmi la sua fiamma; ma non tardai ad accorgermi che sospettava di una segreta relazione fra me e la vedova.
Io rideva delle sue smanie gelose, poichè sapevo che la vedovella, una bellissima donna, era realmente innamorata di un terzo: di un giovane, col quale erano passati accordi di matrimonio.
Il giovane innamorato erasi con me aperto, svelandomi che le relazioni colla vedova erano di natura molto intima. Egli chiedeva un mio consiglio.
Io, che sapevo scaltra la vedova, poichè nelle assenze del giovane cercava di tirare a sè anche il Derudas, gli dissi:
— Apri gli occhi, fratello! Tu devi fidare nella mia sola amicizia. Quando ti avviserò di non andare più da lei, ubbidiscimi!
E il giovane, infatti, aveva cominciato a rendere più rare le visite al molino, dopochè si era accorto che la vedovella aveva un cuore sì largo, da poter dare ricovero a due.... ed anche a tre!
Nondimeno la scaltra mugnaia, accompagnata dal suo giovane amante, un bel giorno fece una gita a Sassari, insieme ad altro mugnaio [240] colla rispettiva moglie. Le due coppie presero alloggio in un’osteria, ordinando una camera separata, per ciascuna. Questo fatto fece mormorare i maligni, e specialmente i coniugi mugnai, ch’erano stati testimoni della scandalosa intimità dei due compagni di viaggio. Tornata la vedovella al molino, non tardò a notare la freddezza del giovane e la corte più assidua che le andava facendo Derudas, ignaro del fatto dell’osteria. Temendo che il mugnaio e sua moglie, colle chiacchiere, riuscissero a far aprir gli occhi a Derudas sull’episodio di Sassari, la vedovella si strinse vieppiù a quest’ultimo, esortandolo ad uccidere i due testimoni pericolosi, non so per quali torti, che diceva aver ricevuto.
Il Derudas un bel giorno venne a confidami le apprensioni della vedova, la quale gli consigliava ad uccidere il mugnaio e la moglie, perchè ci facevano la spia.
Io, che tutto sapevo dal giovane amante, gli risposi infastidito:
— Ma non ti accorgi dunque, che sei menato per il naso? Da qualche tempo a questa parte mi vai contando frottole, che mi rivelano la tua poca lealtà. Fammi toccare con mano che i coniugi mugnai ci fanno la spia, e mi prenderò io l’incarico di spararli, poichè nel tiro sono di te più esperto. Cessa, però dallo spacciarmi tante fandonie. Apri gli occhi da una buona volta, ed ascoltami! Il giorno che tu torcerai un capello [241] a quel buon uomo, od a sua moglie, avrai da farla con me! I capricci e gli amori ti costeranno ben cari!
Il Derudas si offese, e mi tenne il broncio; ed io mi accorsi che cercava vendicarsi. Legato alla vedova da relazione amorosa, si erano entrambi proposti di farmi arrestare, colla speranza di conseguire la loro felicità. La causa del Derudas era meno grave della mia, ed egli sperava di ottenere dal Governo l’impunità, a prezzo della mia cattura o della mia morte, ottenute col mezzodì una delazione o di un tradimento.
Era questo il sogno di Maria Grazia, che voleva disfarsi di me, per unirsi in matrimonio con un bandito graziato. Il giovane si era stancato di lei, ed ella non voleva perdere il secondo partito.
Ricordando le mie minaccie, e temendo il mio furore, il Derudas tornò a parlarmi della convenienza di uccidere i due mugnai, che ci facevano la spia. La vedovella pareva preoccupata di quel certo caso dell’osteria di Sassari, che poteva mandare a monte il suo matrimonio.
Ero sul punto di tutto svelare al mio compagno, ma mi contenni. Mi limitai a rispondergli con malagrazia:
— Di nuovo colle supposte spie? Decisamente le donne t’empiono la testa di vento. Te l’ho pur detto di non più parlarmene!
E così dicendo mi alzai con stizza, come per uscire dalla capanna, in cui entrambi si era.
[242]
— Dove vai? — mi chiese Derudas con tono risentito.
Mi voltai, squadrandolo con disprezzo:
— Vado dove mi pare e piace! D’ora innanzi, se ti è cara la mia compagnia, dovrai venirmi dietro come un cane. Io non ti comunicherò più le mie intenzioni!
— Allora sarà meglio che ciascuno faccia la sua strada! — mi disse con aria brusca.
— È precisamente quello che desidero! — risposi secco. — Ti predico, però, che dentro l’anno cadrai nelle mani della giustizia..... e ti arresteranno addormentato. Io conosco quanto vali!
Così dicendo piantai il mio compagno; e da quel giorno ci guardammo in cagnesco. Io voleva solamente accertarmi del suo proposito di farmi la spia, di concerto colla scaltra vedovella. Una volta avute in mani le prove della loro perfidia, avrei io pensato al modo di fargli pagar caro il tradimento.
[243]
Farò un passo indietro per narrare due casi avvenutimi, durante il tempo ch’ebbi a compagno il bandito Derudas.
Antonio Maria Cosseddu, di Banari, da qualche tempo cercava di farmi la spia. Era stato tre volte in carcere, ed uscitone, volle seco in compagnia due pastori banaresi (certi fratelli Antonio Maria e Salvatore Carta) perchè non venisse molestato dai nemici. I due fratelli erano ricchi, onesti, e molto stimati nel paese.
Il Cosseddu aveva in custodia molti porci e capre, a lui affidati da un agiato proprietario di Banari.
Incorsi in una contravvenzione, i fratelli Carta erano stati condannati a un mese di carcere. Poco dopo pubblicata la sentenza, fui invitato a pranzo nel loro ovile, dove mi trovai in compagnia di Derudas, di Gio. Antonio Nuvoli, e del prete florinese Massidda. Appresa la recente condanna, tutti d’accordo consigliammo i due fratelli a costituirsi in carcere l’uno alla [244] volta, perchè così potessero sorvegliare il proprio bestiame. Promisi, da mia parte, che avrei tenuto d’occhio la loro proprietà, durante il tempo della prigionia dell’uno e dell’altro.
E così, infatti, essi fecero.
Durante il tempo che Gio. Maria scontava il suo mese di carcere, la spia Cosseddu ebbe un vivo diverbio coll’altro fratello Salvatore, e fu sul punto di ucciderlo, facendo accorrere sul luogo i carabinieri. Quest’intervento dell’arma benemerita era stato forse concertato con la spia, allo scopo di farmi sorprendere nella capanna insieme al mio compagno Derudas. Scampai al pericolo — ma giurai di vendicarmene.
Costituitosi in carcere Salvatore (dopo uscitone il fratello Gio. Maria) quest’ultimo si mostrò molto risentito del perfido contegno del Cosseddu, e mi pregò di ucciderlo.
Io gli risposi:
— La vendetta sarebbe giusta; ma che avverrà in seguito? Tutti ormai sanno che siete nemici del Cosseddu; e se io l’uccidessi, voi sareste arrestati come esecutori o mandanti. Anch’io avrei bisogno di punirlo, ma questa volta la mia vendetta non tornerebbe che a danno vostro.......
— Che fare, dunque?
— Cercare il mezzo di ottenere lo scopo senza compromettere la vostra libertà.
— E questo mezzo? Consigliami tu!
[245]
— Rispondi. È egli vero che Antonio Maria Cosseddu è un volgare sicario, che ha sulla coscienza molte pelli?
— È ben noto al paese!
— Tu e gli amici tuoi, siete in grado di conoscere i delitti da costui commessi?
— Li conosciamo.
— Puoi tu mettere insieme otto testimoni delle scelleraggini di quel cattivo soggetto?
— Anche venti!
— Mi bastano otto. Quando li avrai riuniti, dammene avviso, ed io ti dirò quanto devono fare.
Radunate le otto persone in campagna, col pretesto d’una partita di caccia, Gio. Maria Carta mi diede l’appuntamento.
Salutata la comitiva, presi la parola, e dissi loro:
— Siete voi tutti consapevoli degli assassinî commessi da Antonio Maria Cosseddu?
— Sì.
— Proprio in coscienza?
— Ognuno di noi può asserirlo con prove di fatto.
— Or bene, allora fate così. Quattro di voi si presentino al procuratore del re di Sassari, denunziandogli i fatti che si conoscono. Ritornati questi, partiranno gli altri quattro, per fare altrettanto. Raccolte dal fisco le denunzie in iscritto, egli ha il dovere di spiccare il mandato di cattura, e istruirà il processo.
[246]
Il mio consiglio fu seguito scrupolosamente; e il Cosseddu venne arrestato, processato, condannato a morte, e impiccato a Sassari.
Dopo la condanna, dissi al pastore Gio. Maria:
— Vedi tu come si fanno le cose? Tu non sei rovinato nella persona e nella roba; io non ho la pelle di un sicario sulle spalle; il nostro nemico è punito; e la giustizia può andar lieta di aver tolto dal mondo un miserabile assassino!
Il Cosseddu aveva a Banari un cognato prete; e il paese diceva che costui era riuscito a strapparlo tre volte alle carceri, per mezzo delle fattucchierie. Dopo la condanna a morte, una mattina, il prete fu trovato svenuto sul pavimento della sacristia; e fu detto che il diavolo lo avesse abbandonato, perchè non era riuscito a strappare il cognato al carnefice. Il povero prete, dopo l’impiccagione del Cosseddu, si chiuse in casa per sei anni, e non volle più vedere anima viva[34].
I fratelli Carta erano buona gente, ed io volevo, ad ogni costo, toglierli alle seccature. Costava poco, a un bandito, uccidere un uomo come Cosseddu; ma non volevo compromettere [247] i due amici, dai quali avevo sempre ricevuto gentilezze. Ero certo che su loro sarebbero caduti i sospetti dell’uccisione della spia, per gli screzi e le minaccie che in precedenza si erano verificati. La spia Cosseddu aveva scontato le sue perfidie e i suoi delitti — e la mia coscienza era tranquilla.
***
Mi trovavo ancora a Banali, quando, un giorno, m’imbattei nel bandito Derudas, prima della nostra rottura. Egli mi confidò che due ladri d’Ittiri avevano derubato un suo fratello, togliendogli persino i sacchi, che teneva sotto il basto del cavallo che montava. Quest’audacia lo inasprì talmente, che mi dichiarò di odiare tutti gli ittiresi.
In compagnia di diversi amici ci trovammo l’indomani a Badu Sinaghe, dove si mangiò allegramente, e si bevette non poco. In sul finire del pranzo, mentre si chiacchierava col padrone del luogo, venne un pastore ad avvertirlo, che quattro ittiresi erano entrati nel tenimento per tagliar legna.
Il padrone, indignato, ordinò al servo di mandarli via.
— Perchè non andiamo noi a trovarli? — esclamò vivamente Derudas, alzandosi. — Non posso dimenticare che hanno derubato mio fratello.
[248]
— Non saranno certo gli stessi! — osservai scherzando.
— Che importa? sono ittiresi, e basta!
Così dicendo il mio compagno si mosse, e noi gli tenemmo dietro.
Il padrone sgridò quei ladri sfacciati, ed io tolsi loro i picchi e le ronche, dicendo che li avrebbero ripresi un’altra volta.
Uno dei ladruncoli — che certamente non ci conosceva — si fece innanzi con baldanza, e venendomi incontro mi gridò con disprezzo:
— Tu fai il gradasso perchè sei armato di fucile!
Il sangue mi fe’ velo agli occhi, e gli saltai addosso, strappandogli di mano la scure.
L’ittirese mi afferrò allora per la barba; ed io, cieco, lo percossi colla scure, ferendolo gravemente al braccio.
Mi accorsi, lo confesso, d’essere stato troppo focoso, e di aver commesso una brutta azione. Sebbene l’afferrare un sardo per la barba sia l’insulto più atroce che si possa fare, pure riconobbi che il torto era mio, ed ebbi vergogna di me stesso. Debbo dichiarare, che di questo eccesso ebbi ad arrossire per tutta la vita. In quel momento non avevo pensato che a vendicare il mio compagno Derudas, senza badare quanto sia ingiusto e ridicolo bisticciarsi per conto di un terzo.
Pochi giorni dopo ricevetti una lettera dal [249] cav. Suzzarello, colla quale mi esortava a restituire i ferri ai quattro ittiresi, uno dei quali era un suo servo. Meno male che il Suzzarello non mi tenne rancore; egli, più tardi, mi raccomandò di procurargli un buon mastino per caccia grossa, avendogli un robusto cinghiale sbranato nove cani, in una partita di caccia a Giunchi. Lo compiacqui, e se ne mostrò soddisfatto.
L’ittirese da me ferito non tardò a guarire, e ne fui lieto.
Racconto questi episodi per darvi un’idea della vita di noi banditi. Ne taccio molti altri insignificanti, per non tediare chi leggerà la mia storia.
***
A Banari, come in tutti i paesi del circondario, destavo sempre una curiosità singolare. Quando passavo in quella regione, il medico Peppe Canu avvertiva i cavalieri, i quali colle loro famiglie si recavano a far pranzo in campagna, per il solo gusto di conoscermi da vicino.
Quei cavalieri m’invitarono molte volte a prender parte ai loro pranzi; e per consueto mi s’incaricava di fare le porzioni a tavola, meravigliati, i commensali, della mia abilità nel tagliare le carni, che distribuivo in un momento, con equa misura. Si era talvolta in venticinque [250] o trenta individui in campagna, e tutti si mostravano avidi di conoscere qualche episodio della mia vita di bandito, ch’io raccontavo loro con piacere.
Un giorno, nel salto di Badu Sinaghe, in Giunchi, dovendosi preparare i soliti regali a Monsignore e a diversi signori di Sassari, venni incaricato dell’uccisione del bestiame; e uccisi ben quattordici porci e troie a palla, dando spettacolo di valentìa col colpirli tutti nell’occhio, per non far loro perdere il sangue[35].
Ho antecipato un po’ gli avvenimenti; ed ora ritorno al mio compagno Derudas, prima di abbandonarlo al suo triste destino.
[251]
Da poco tempo ero separato dal Derudas, quando egli uccise il bandito, che aveva scelto a suo nuovo compagno. Dirò brevemente il fatto.
Un ricco possidente d’Ossi si era bisticciato vivamente con un suo servo — certo Antonio Elias; e s’inasprì talmente, che lo percosse. Il servo, più robusto di lui, si avventò al suo padrone, e dopo averlo picchiato si salvò colla fuga.
Il ricco proprietario, volendo vendicarsi dell’atroce insulto, mi chiese un abboccamento in campagna. Egli mi propose una larga ricompensa, se avessi tolto dal mondo quel servo prepotente ed ingrato. Gli risposi che si fosse ad altri rivolto, poichè io non solevo uccidere chi non mi aveva offeso.
Appresi in seguito che il padrone si era rivolto a Derudas, proponendogli la stessa uccisione. Il Derudas osservò che non osava fare il colpo, perchè temeva la mia collera e la mia vendetta.
[252]
Allora il proprietario di Ossi, coll’intento d’incoraggiarlo, gli fece credere avergli anch’io promesso di sbarazzarlo dal servo audace.
— Pensaci, dunque, se vuoi guadagnare ottanta scudi!
Anche questo colloquio era venuto a mia conoscenza, per la relazione di confidenti, che a me non mancavano.
Avevo intanto saputo, che il bandito Elias, il servo prepotente, si era dato a scorrazzare la campagna insieme al Derudas, che se lo aveva associato come compagno di ribalderie.
Un giorno Derudas osò venirmi incontro. Avendolo poco prima veduto con Elias, gli dissi seccamente:
— E perchè ti presenti solo? Non è forse degno il tuo compagno d’essermi presentato? Chiamalo pure, se lo hai nascosto!
Derudas si accostò al ciglione, e lo chiamò con un lungo fischio. Quando comparve l’altro bandito, lo apostrofai:
— Perche ti accompagni con Derudas? Non hai capito ancora che egli fu pagato per ucciderti? Abbandonalo, se ti è cara la vita!
Il Derudas mi fulminò con un’occhiata, ma tacque. Senz’altro dire, fece un brusco cenno al compagno, e si allontanarono.
Ero sul punto di fargli fuoco addosso, ma poi mi contenni. Due o tre volte era venuto a tiro del mio fucile, ma sempre lo risparmiai, non [253] volendo si dicesse che io uccidevo i miei compagni. Uccidere il proprio compagno è per i banditi la più grande delle vergogne e delle vigliaccherie; poichè darebbe a sospettare che l’uccisione sia seguita nel sonno. Aspettai un’occasione più propizia. Volevo d’altronde accertarmi, che insieme all’amica mugnaia egli mi facesse realmente la spia.
Non trascorse una settimana da quel nostro incontro, quando Derudas uccise il giovane Elias, per la cui morte gli vennero sborsati ottanta scudi dal ricco proprietario d’Ossi. Questa somma gli abbisognava per la liberazione. In noi banditi era radicata la credenza, che la giustizia avesse bisogno di soldi per chiudere gli occhi ed alleggerire la mano — e la giustizia d’allora non era quella d’oggi! I giudici erano anch’essi complicati nei partiti, e ciascuno aveva i suoi bravi protetti e protettori, specialmente a Sassari.
Verso quel tempo Derudas aveva tentato di separarsi dalla vedovella; ma questa gli disse:
— Bada, Antonio Maria, a quello che fai! Ricordati che per te ho licenziato un giovane che mi voleva bene. Se persisti ad abbandonarmi perchè stanco di me, ti prevengo che mi raccomanderò a Giovanni Tolu per aggiustare la faccenda!
Questa minaccia sortì il suo effetto, poichè Derudas aveva paura di me. Egli finì per sposare la vedovella in casa del rettore, a Banari. [254] La teneva in un molino, dove andava a trovarla di tanto in tanto, dandole appuntamenti in questo o in quel punto, come usano tutti i banditi ammogliati, che non possono avere una casa coniugale.
Non corse lungo tempo, che Derudas venne arrestato, avverandosi la mia profezia. I carabinieri lo avevano colto mentre dormiva. L’imbecille si era svegliato in carcere!
La mancanza di prove testimoniali favoriva la causa di Derudas. I processi erano per la maggior parte indiziarî; e correva la voce della probabile assoluzione del bandito mio compagno. Si accennava da taluni a persone influenti, a qualche giudice a cui si erano dati gli 80 scudi di Elias per diventare più giusto. Non mancò chi mi pose in avvertenza, dicendomi che la bella mugnaia era intesa col detenuto marito per ottenere l’assolutoria, facilitandola colla mia cattura.
Quest’ultima diceria — che correva da qualche tempo — mi aveva messo i brividi addosso. Sentivo di essere feroce. Ero pentito di non aver ucciso Derudas; maledicevo gli scrupoli e i riguardi ridicoli, che avevano trattenuto il mio braccio.
Quale umiliazione per me, se si fosse avverato il pronostico! Io in carcere, e Derudas in libertà? questo pensiero mi torturava.
Avevo bisogno di convincermi, che realmente Maria Grazia mi tendesse un’insidia. Non volevo [255] prestar fede ai molti che mi assicuravano, che fra il detenuto e la moglie (annuente la polizia) correvano segreti rapporti.
Vivevo irrequieto; le mie notti erano turbate da sogni angosciosi. Avrei voluto travestirmi da guardia carceraria per uccidere il mio perfido compagno nella sua cella di San Leonardo.
S’ei fosse uscito dal carcere prima della mia cattura, sarei stato più contento, poichè avrei potuto ucciderlo al fianco della propria moglie; ma chi mi assicurava che la sua libertà non era subordinata alla mia perdizione?
In preda a questi tormenti non pensai che a procurarmi le prove del tradimento a mio danno.
Aggirandomi un giorno nelle vicinanze del molino della moglie di Derudas, mi cacciai nel vicino bosco, dove vidi la sua bella servetta, che andava in traccia d’un maiale sbandato. Siccome in altri tempi le avevo fatto un po’ di corte, me le avvicinai sorridendo:
— Buon giorno, Catterina. Come stai?
— Oh! beato chi ti vede! È un bel pezzo che non vieni a trovarci nel nostro molino!
— Dacchè hanno arrestato il tuo padrone ho sospeso le visite al molino per non dar pasto alla maldicenza.
— Che scrupoli! E perciò hai avuto paura di rivedermi? Ben gentile!
— Riparerò al mio torto fra breve. Verrò a salutare Maria Grazia... e te più di lei.
[256]
— Possibile! e quando? La mia padrona sarà tanto contenta di rivederti. Mi parla sempre di te.
— Verrò... Tra due giorni; venerdì, o sabato... dopo l’imbrunire.
— Davvero?
— Bada di non dirlo a nessuno, Catterina! Addio, belloccia!...
— Tieni le mani a posto!
— Sei proprio adirata con me?
— Te lo dirò quando verrai al molino.
E la servetta, si allontanò, saltellando come una capriola.
Nè il venerdì, nè il sabato mi mossi per andare al molino; ma la sera stessa pregai un mio parente, perchè si appiattasse per tre giorni in un punto lontano, per sapermi riferire le persone che sarebbero andate a far visita alla mugnaia.
— È questione forse di gelosia?
— No: è un mio capriccio. Bada di non farti vedere!
La domenica mattina il mio congiunto tornò a me. Era alquanto turbato.
— Ebbene? — gli chiesi — Hai scoperto il misterioso visitatore?
— Altro che visitatore! Venerdì sull’imbrunire mi sono imbattuto in sei carabinieri sulla strada di Codrongianus. Erano diretti al molino, e li ho visti sparire nel vicino boschetto. Certo si trattava di un appiattamento, perchè vi sono [257] rimasti due notti. Erano guidati dal maresciallo, il quale entrò due volte nel molino, dopo le dieci.
La trama era scoperta, ed io non potevo più dubitare della perfidia di Maria Grazia, che cercava di vendere la mia pelle per salvare quella di suo marito.
Dovevo dunque pensare alla vendetta: punire il marito dentro carcere, e strapparlo per sempre alla moglie; e tutto ciò senza far uso del mio fucile.
Il tempo stringeva. Il dibattimento di Derudas era incominciato, ed ogni ritardo poteva pregiudicare il mio disegno.
Mi ricordai della confidenza fattami un anno addietro da Derudas, dinanzi alla cantoniera di Campomela.
Senza frapporre indugio mi recai al villaggio di Mores, per abboccarmi con Antonio Masala di Cargeghe. Era costui il fratello di Angelo — dell’uomo assassinato da Derudas e da Puzzone per incarico e col concorso di Manconi.
Trovato il Masala gli dissi:
— È una vergogna, o Antonio! Com’è ch’hai fatto sì poco conto di tuo fratello assassinato?
— E che doveva io fare, quando mi sono ignoti gli uccisori? o per dir meglio, quando mi mancano le prove?
— Le prove si trovano sempre, quando si cercano!
— Così fosse! Che cosa mi consigli di fare?
[258]
— Fidarti di me. Hai tu avvocato a Sassari?
— Sì. Il dibattimento credo sia già incominciato.
— Chi è il tuo avvocato?
— Cossu, il grande.
— Ebbene, bisogna scrivere al tuo avvocato.
— Scrivere che cosa?
— Presso a poco nei termini che io ti suggerirò.
— Sentiamo.
Ed io dettai, accentuando le parole:
Illustrissimo Signor avvocato,
«Le do alcuni ragguagli, che Ella si affretterà a comunicare al procuratore del re. I testimoni Ignazio Tolu e Giovanni Manconi, già esaminati dal giudice istruttore subito dopo l’assassinio di Angelo Masala, tacquero quanto sapevano perchè i banditi Derudas e Puzzone battevano allora la campagna, e li avrebbero uccisi se avessero deposto il vero. Ora però, che l’uno è morto, e l’altro è in carcere, essi possono parlare. Oso sperare, che l’eccellentissimo Tribunale vorrà perdonare ai due disgraziati testimoni, i quali deposero il falso, solamente per timore di perdere la vita. Angelo Masala disparve, nè si ebbero le prove della sua morte per malefizio. Il suo cadavere fu sotterrato dagli assassini nel tenimento [259] di Don Battista Solinas nel sito sa funtana de sa piarosa, in faccia alla cantoniera di Campomela. Si mandi a dissotterrare il cadavere, seguendo le traccia che a calce della presente verranno indicate.» (E qui diedi i più minuti schiarimenti sulla località da me conosciuta).
Questa lettera fu distesa e mandata all’avvocato Cossu.
Il dibattimento, che era in corso, venne sospeso e rinviato. Si esumò il cadavere; si fece la perizia; furono uditi i testimoni indicati — e il risultato del nuovo giudizio fu la condanna di Antonio Maria Derudas ai lavori forzati a vita. Egli morì in galera dopo quattro anni di pena.
Il mio procedimento ebbe il risultato propostomi. Mi ero vendicato di un compagno traditore e di una moglie spia. La società venne liberata da un malfattore volgare; ma ben pochi seppero che la giustizia era stata illuminata dal bandito Giovanni Tolu![36]
[260]
Darò alcuni ragguagli su tre banditi, ch’ebbi per qualche tempo a compagni, e di cui mi occuperò nel corso della narrazione.
La prima volta che io vidi Pietro Cambilargiu fu a Monte fenosu, verso Scala di Ciogga, nell’ovile di Pietro Migheli, suo cugino.
Pietro Cambilargiu fu ritenuto come il bandito più celebre del Logudoro. Le sue gesta sanguinarie sono tuttora argomento dei racconti del popolo. Tesserò brevemente la sua storia, quale l’ho udita tante volte da lui stesso, durante i sei mesi che gli fui compagno. Riferirò quanto egli narrò a me e ad altri banditi, senza rendermi garante delle vicende riguardanti la sua vita in continente ed in Corsica.
Non devo tacere che Cambilargiu aveva la debolezza di menar vanto delle sue scelleratezze: nessun altro bandito conobbi mai più millantatore di lui, nè più crudele nel vendicarsi. Più che la morte, egli voleva lo strazio della vittima.
[261]
Pietro Cambilargiu non era un uomo d’armi, nè di campagna, come noi lo eravamo. Modesto e povero calzolaio, aveva trascorso in giovinezza nel suo paesello d’Osilo, dando continue prove della sua irascibilità e della sua impertinenza.
Contava appena 18 anni, quando Nicolò Cherchi, il suo mastro calzolaio, gli diede uno schiaffo. Indispettito della punizione ricevuta, esplose una pistola contro il suo principale, ferendolo leggermente. Venne arrestato, e condannato a tre anni di lavori forzati. Mentre scontava la pena nell’ergastolo di Cagliari, riuscì ad evadere, e battè le campagne d’Osilo, come bandito. Uccise poco dopo certo Pietro Marongiu, perchè dicevasi volesse fargli la spia. Vedutolo un giorno a cavallo, gli mosse incontro, e gli diede una fucilata, dopo avergli detto: — ti do quello che ti spetta!
Egli si era unito a due altri banditi — a Pietro Dore e a Giomaria Ledda, suoi compaesani. Il Ledda per ottenere la libertà gli fece la spia, e i barracelli un bel giorno, nel sobborgo di S. Vittoria, riuscirono ad arrestarli tutti e tre.
Cambilargiu fu condannato alla galera in vita. Frustato prima dal boia, (come voleva la giustizia d’allora) fu in seguito condotto ad Osilo col remo in spalla e con la corda al collo, per fargli baciare il piede della forca, piantata dinanzi alla fontana di Rinnu. Dicesi che, attraversando così il paese, ad ogni sbocco di via gli [262] si presentasse sogghignando il Ledda, quasi per gioire del suo supplizio; e Cambilargiu per due volte gli disse: — Prega Iddio che non abbiamo a rivederci un giorno!
Cambilargiu fu mandato all’ergastolo di Villafranca, e il Ledda, graziato per lo spionaggio fatto, si ritirò ad Osilo per esercitarvi il mestiere di fabbro.
Nell’ergastolo di Villafranca il Cambilargiu lavorò da calzolaio, e divenne abile nella professione. Uno dei superiori del Bagno penale lo incaricò di provvedere di calzatura la famiglia, ed era tanta la fiducia in lui riposta per la buona condotta, che lo si lasciava andare a comprar le pelli e la suola nei negozi della città, accompagnato da una sola guardia ciurma. I lavori di calzoleria inappuntabilmente eseguiti, le belle maniere del giovane osilese, la sua condotta esemplare, fecero sì che Cambilargiu si attirasse la benevolenza dei superiori.
Intanto il galeotto era riuscito colla furberia ad informarsi delle distanze e dell’accidentalità del terreno fra Villafranca e la frontiera francese, nonchè del fiume che bisognava guadare per raggiungere la terra straniera.
Un bel giorno, uscito come al solito in compagnia della guardia per provvedersi di pelli in città, invitò a bere il suo compagno in un’osteria, fino ad ubbriacarlo; e portatolo in un certo punto, all’estremità del paese, gli propose di sedere alquanto [263] per riposare. Quando vide la guardia sonnolente per il vino bevuto, gli strappò di mano la carabina, svoltò una viottola, e si diede a correre come un capriolo per guadagnar la campagna.
La guardia balzò in piedi barcollando, credendo si trattasse di uno scherzo; ma quando si avvide del brutto tiro fattogli, si diede a gridare al soccorso con quanto fiato avea in corpo.
Cambilargiu, correndo, aveva raggiunto la montagna, e si era cacciato in un folto cespuglio, dove rimase appiattato tre giorni e tre notti. Ivi riuscì a liberarsi della catena per mezzo di una lima, e cambiò la giubba e il berretto da galeotto con altri panni che aveva seco portati. Non volte spingersi fino al ponte, poichè sapeva che di qua e di là era guardato dalle sentinelle italiane e francesi. Alla mezzanotte del terzo giorno uscì dal nascondiglio e si diresse al fiume, che costeggiò per breve tratto, fino a trovare un guado possibile. Cambilargiu si spogliò; assicurò le vesti e le scarpe alla punta di una lunga pertica di cui si era munito, e giunse a toccare l’opposta sponda, coll’acqua fino alla gola.
Il primo passo era fatto. Egli si trovava in terra francese.
Rivestitosi de’ suoi panni, l’evaso continuò a camminare con coraggio e disinvoltura, finchè capitò fra gli agenti di polizia, che lo tradussero dinanzi ad un Commissario. Egli dichiarò di essere [264] un soldato italiano disertore, il quale voleva servire la Francia.
— Come ti chiami?
— Michele Serra.
— A qual reggimento appartieni?
— Al reggimento della Regina.
— Il nome del tuo capitano?
— Cav. Luigi Bianchi.
— Vuoi servire come soldato, o ti piace lavorare?
— Preferisco il lavoro, perchè il mio mestiere era quello di calzolaio.
Dopo essere rimasto una ventina d’anni in Francia, per lo più a Marsiglia, Cambilargiu passò in Corsica; e trovò occupazione presso una calzoleria, in cui lavoravano una diecina di operai. Egli entrò nelle grazie del principale e della moglie di costui, che presero a volergli bene ed a proteggerlo.
Certo è, che quell’uomo singolare, evaso due volte da galera, non aveva che un pensiero fisso: vendicarsi di colui che ad Osilo gli aveva fatto la spia, per consegnarlo ai carabinieri.
Morì intanto il proprietario della calzoleria; e Pietro Cambilargiu, giovane ancora, e audace quanto libertino, si die’ a fare la corte alla vedova, riuscendo a mettersi in intima relazione con lei.
Questa vedova aveva quattro fratelli, di carattere violento ed energico, come d’ordinario [265] lo sono i corsi; e mal soffrendo la tresca scandalosa, che faceva mormorare il paese, imposero a Michele Serra (così Cambilargiu continuava a farsi chiamare anche in Corsica) di sposare la sedotta loro sorella. Siccome gli affari della calzoleria andavano maluccio, e Cambilargiu smaniava di far ritorno al suo paesello natio per vendicarsi di Giomaria Ledda, egli finse di accondiscendere all’invito dei futuri cognati — e chiese alcune settimane di tempo per aggiustare le sue cose in Sardegna, e per munirsi delle carte necessarie per il matrimonio.
Sbarcato sul litorale di Castelsardo egli riparò nelle campagne d’Osilo, deciso di allontanarsi per sempre dalla Corsica.
Capitato nell’ovile di alcuni suoi parenti, vi fu ravvisato da una vecchia zia, quantunque parlasse in francese e si fosse spacciato, prima per un mendicante di Villasor, e poi per un negoziante di bestiame. Veduto ch’era inutile mantenere l’incognito, si diede a conoscere a suo cugino Pietro Migheli, e svelò addirittura la sua intenzione di uccidere il maniscalco Giomaria Ledda, già suo compagno bandito, e allora libero per il tradimento fattogli a Santa Vittoria.
Per mezzo di diverse persone, fra le quali l’arciprete, egli mandò a salutare l’antico collega, facendogli dire che avrebbe avuto il piacere di riabbracciarlo fra breve!
Il Ledda credette scherzo l’ambasciata, sicuro [266] com’era che Cambilargiu scontava la pena nell’ergastolo di Villafranca.
Il giorno di S. Vittoria, Cambilargiu, favorito da alcuni suoi parenti, si appiattò in un cortile ch’era di contro all’officina di Giomaria Ledda.
Certo Matteo Serra, volendo ferrare un suo cavallo, si era quel giorno portato dal fabbro maniscalco.
Mentre il Ledda, sulla strada, era intento a ferrare il cavallo — fra il servo che teneva sospesa la zampa della bestia, e il Serra che assisteva all’operazione — quest’ultimo si accorse del bandito, nascosto in una catasta di legna. Cambilargiu gli fe’ cenno colla mano di scostarsi. Matteo Serra indietreggiò, balbettando: — Giomaria! Giomaria! Ledda indovinò tutto, e fece alquanti passi per afferrare il suo fucile, ch’era appoggiato allo stipite della porta. Non giunse a toccarlo, perchè cadde fulminato dalle palle di Cambilargiu.
Da quel giorno Pietro Cambilargiu divenne celebre in tutta l’isola. Le sue gesta sanguinarie, che si seguirono senza tregua, venivano in mille modi esaltate dai parenti e da’ suoi compaesani; però, in fondo, egli non aveva alcun valore, nè per destrezza, nè per abilità nel tiro. Dovette la sua fama alle sue volgari astuzie, alla sua crudeltà, all’impeto feroce con cui assaliva i nemici. La vendetta più assennata fu per lui l’uccisione [267] del maniscalco spia; in seguito lasciossi trasportare a eccessi feroci, prestandosi anche a togliere per danaro la vita ad altri per conto di terzi.
Si unì prima col bandito Antonio Spano di Ossi; poi con Francesco Palmas e Salvatore Fresu, e in ultimo con me, come si vedrà più tardi.
Il paese d’Osilo era impressionato dalle continue scelleratezze di quel ribaldo. Approfittando del terrore che Cambilargiu destava nei dintorni, i suoi parenti commettevano ogni sorta di delitti. Scorrazzando per le campagne, essi rubavano frutti, uccidevano bestiame, chiedevano danaro; e nessuno fiatava, temendo che il bandito prendesse le difese de’ suoi congiunti ladri.
Era giunta a tal segno l’esaltazione entusiastica, che un gran numero di malviventi si spacciavano parenti di Cambilargiu, solo per poter commettere impunemente le più audaci imprese.
Eppure, chi lo crederebbe? dinanzi al nemico, Pietro Cambilargiu non dava mai prove di destrezza nè di coraggio. In faccia al pericolo perdeva facilmente il suo sangue freddo, ed agiva per impeto, senza riflessione.
Citerò un solo fatto. Un giorno quattro carabinieri avevano ordito un appiattamento per dar l’assalto a Cambilargiu, che trovavasi in compagnia del nulvese Peppe Luigi Santona, [268] nel molino d’una sua cugina, presso Nulvi. Furono entrambi bloccati dentro casa.
Come avvertirono il suono delle sciabole dei carabinieri, Peppe Luigi uscì risoluto sul piazzale, e, messo il fucile in faccia, prese di mira il maresciallo, che ferì mortalmente. Cambilargiu, invece, sbigottito, non osando venir fuori all’aperto, perdette la testa; e, veduta un’ombra attraversare il piazzale, fece fuoco su di essa, e colpì in pieno petto il suo compagno Santona, che cadde fulminato. Per fortuna egli riuscì a sfuggire ai carabinieri, gettandosi capofitto sotto la cascata del molino, con pericolo della vita. Di quest’errore Cambilargiu si dolse sempre; e con ragione, poichè non tornava ad onore della sua perspicacia.
Fra gli omicidi più crudeli commessi dal bandito osilese, noterò quello del giovinotto Leonardo Satta. Fui quasi testimonio, involontariamente, del fatto.
Come dirò in seguito, da qualche tempo ero in relazione coi banditi Cambilargiu, Spano e Fresu, coi quali mi accompagnavo con frequenza.
Un giorno, tornando insieme da Florinas, Pietro ci pregò di tenergli compagnia fino ad Osilo, poichè aveva bisogno di abboccarsi colà con un suo compare, al quale desiderava parlare in presenza di testimoni.
Movemmo insieme sull’imbrunire, e nella notte ci recammo in casa del notaio Giovanni [269] Satta. Dopo scambiati i saluti, Cambilargiu gli disse:
— Compare Giovanni; per la fede di battesimo che ci unisce, sono in dovere di darvi un’avvertenza. Badate! io so che vostro nipote Leonardo è in rapporti intimi col commissario dei carabinieri, il quale ha la consegna di farmi la spia. So pure che fra loro esiste una corrispondenza epistolare. Se voi non lo persuaderete a mettere giudizio, penserò io ad aggiustare le cose. Ve lo prevengo!
Il notaio, invece di prendere in buona parte le parole di Cambilargiu, montò addirittura sulle furie, e gli rispose con tono minaccioso:
— Se oserete toccare un sol capello a mio nipote, l’avrete da fare con me!
Conoscendo il carattere bestiale di Pietro, m’interposi fra l’amico e il notaio, e dissi a quest’ultimo:
— Lei parla male, signor notaio! Le buone parole sono più persuadenti delle minaccie, massime fra compari di battesimo. Lei non dovrebbe ignorare, che suo fratello Gavino Satta, stabilito a Florinas, fa il fatto suo, nè si occupa di me. Se egli se ne fosse occupato, a quest’ora non sarebbe vivo. Ritiri dunque le minaccie, e si aggiusti con compare Pietro!
Cambilargiu, vivamente piccato dal linguaggio del notaio, gli rispose aspramente:
— Compare Giovanni; poichè la prendete [270] così in alto, vi prometto di dare a vostro nipote la lezione che merita. Lo ucciderò sotto ai vostri occhi!
Ciò detto gli volse bruscamente le spalle, ed uscimmo tutti.
Pochi giorni dopo un amico riferì a Cambilargiu, che il giovane Leonardo sarebbe andato a Sassari per conferire coi carabinieri. Vedutolo da lontano a cavallo, insieme al prete Canalis, che se lo aveva preso in groppa, il bandito spronò la cavalla e gli tenne dietro per un buon tratto di strada. A un certo punto — verso la fontana del fico — il giovane smontò e si unì ad un gruppo di agricoltori che lavoravano in un campo.
Comparso Cambilargiu, Leonardo saltò alcuni muri e si diede a correre. Allora il bandito gli fece fuoco addosso, e lo ferì leggermente ad un piede.
Smontato da cavallo, Cambilargiu saltò anch’esso i muri, e corse dietro al giovane, gridando:
— Fermati, chè non ti farò alcun male!
Leonardo si fermò tremante.
— Dunque ti ostini a farmi la spia? — gli gridò il bandito.
— Non è vero.
— Dimmi la verità!
— Io sono innocente.
— Questa non è la verità! Inginocchiati e prega, perchè ti uccido!
Leonardo cadde in ginocchio, e congiunse [271] le mani con aria supplichevole, mentre Cambilargiu armava il grilletto.
Un vecchio agricoltore, che si trovava presente, cercò intenerire il bandito:
— Perdonalo, Pietro! Non vedi che è un ragazzo?
Il bandito si rivolse a lui:
— Ebbene? e dai ragazzi mi lascerò dunque rovinare? Anch’io ho diritto di vivere; e chi mi fa la spia deve pagarla cara!
Così dicendo mise il fucile in faccia; e dopo aver puntato il giovinotto supplicante, lo fulminò con tre palle nel petto.
Il feroce bandito ebbe il coraggio di frugare nelle tasche del cadavere, e dopo avervi tolto alcune lettere, alla presenza di tanti agricoltori terrorizzati, rimontò a cavallo e si allontanò freddamente com’era venuto.
Il bandito osilese commise quel giorno una vera vigliaccheria, che più volte gli rinfacciai.
Tralasciando per ora le altre uccisioni fatte da Cambilargiu, dirò poche parole sui due altri miei compagni di ventura.
***
Ad Antonio Spano, di Ossi, era stata uccisa barbaramente la madre: una donna ancor giovane, bellissima ed onesta. L’avevano freddata in un oliveto, mentre raccoglieva le olive, perchè [272] non aveva voluto cedere alle disoneste proposte di alcuni giovinastri, a cui rispose con parole di sdegno e di minaccia.
Il figliuolo Antonio, ferito nell’anima, si era proposto di vendicare l’insulto fatto alla madre, e per diversi anni attese l’occasione per mantenere il suo giuramento.
Trascorso un po’ di tempo, trovatosi Antonio in lieta comitiva in un territorio fra Sassari e la Nurra, si bisticciò vivamente con uno dei compagni, minacciandolo di punizione.
Costui, per canzonarlo, gli volse le spalle; e chinandosi gli disse, tra il serio e il faceto:
— Sparami sotto la schiena, se è vero che sei così valoroso!
Cieco di sdegno, Antonio Spano spianò il fucile, e uccise l’amico.
Dopo quest’accidente, egli si diede alla macchia, e sentì più forte il bisogno di vendicare l’oltraggio fatto alla madre.
Pietro Cambilargiu, a cui Antonio si era unito, era molto amico del capo degli uccisori della bellissima donna; e tanto influì sull’animo del giovane bandito, che lo indusse a risparmiargli la vita. Nondimeno Antonio non volle rinunciare alla vendetta, e tolse dal mondo parecchi dei giovani libertini, che gli avevano uccisa la madre.
Il capo degli infami uccisori della donna venne più tardi arrestato; ma Cambilargiu, valendosi [273] della sua influenza, subornò i testimoni, e riuscì a farlo assolvere dai giudici di Sassari.
Avendo molti parenti ladri e sicari, Antonio Spano si era dato a commettere non pochi furti e scelleratezze, e finì per fare anche il sicario per danaro, prestando facile orecchio ai cattivi consigli dei congiunti.
***
Il terzo mio compagno — Salvatore Fresu d’Osilo — si era dato anche lui alla macchia, dopo avere ucciso un ortolano in un campo di granone. Unitosi poco dopo a Cambilargiu (suo cugino in secondo grado) gli fu compagno fedele per due o tre anni. Il Fresu, che aveva moglie e molti figliuoli, era un miserabile. Egli si mascherava con frequenza, e scorrazzava di qua e di là per estorcere denari e bestiame a questo e a quello, in nome sempre del cugino Cambilargiu, ed anche in nome mio.
Antonio Spano, mio coetaneo, era allora trentenne; Cambilargiu e Fresu avevano oltrepassata la cinquantina.
[274]
Di ritorno dalla Nurra per recarmi a Florinas, mi fermai un giorno all’ovile di Pietro Migheli in Scala di Ciogga, dove trovai Pietro Cambilargiu e Antonio Spano.
In quel tempo io avevo a compagno Leonardo Piga, giovane bandito, a me raccomandato dai parenti.
Come mi presentai all’ovile, lo Spano mi disse:
— Se tu fossi qui venuto in compagnia di Leonardo Piga, lo avrei ucciso!
— Ed io avrei ucciso te! — gli risposi bruscamente. — Perchè tant’odio contro di lui?
— Perchè Leonardo mi ha ucciso un amico la cui perdita mi addolora l’anima!
— Se il tuo amico si fosse comportato bene non avrebbe forse perduto la vita. Ma, purtroppo, certi uomini si fanno forti dell’amicizia di un bandito per dar fastidio agli altri!
Cambilargiu mi diede ragione; e quando presi commiato da entrambi, mi disse:
[275]
— Senti, figlio mio! — (soleva darmi questo nome) — tu ci farai un favore. Dovendo attraversare il territorio di Florinas per recarci a Torralba, abbiamo bisogno di una guida, pratica dei dintorni.
— Vi accompagnerò ben volontieri — risposi — Trovatevi a Pedras serradas, nell’ovile di mio cognato, il luogo è sicuro. Di là muoveremo insieme.
Fedeli all’appuntamento, vennero in tre: Cambilargiu, Antonio Spano e Salvatore Fresu.
Nell’ovile di mio cognato si erano riuniti alcuni nostri amici, smaniosi di conoscere i tre famigerati banditi. Quel giorno si fece pranzo insieme, in aperta campagna, lontani dall’ovile — com’è costume dei banditi, per evitare sgradite sorprese.
Insellati quindi i cavalli (cortesemente favoritici) movemmo, uniti, per Torralba. Io guidavo i compagni.
Fatta un po’ di strada, i tre banditi mi esternarono il desiderio di passare in Banari, dove avevano un amico.
— Chi è costui? — chiesi loro.
— Antonio Luigi Pischedda.
— Nè voi, nè io, andremo da lui!
— Perchè?
— Perchè gli hanno ucciso due nipoti.
— Eppure ha promesso di farci un regalo, se saremmo andati a visitarlo!
[276]
— Pischedda è in urto con tutto il paese, per l’uccisione dei due nipoti; nè voi riuscireste ad uscire di là, senza aver le giacche forate dalle palle dei banaresi. Siete sotto la mia custodia, e non dovete andarci!
Li condussi invece in casa di Gio. Antonio Pais, che era assente dal villaggio. Fummo ricevuti dalla moglie, che mandammo subito a comprar vino. Ci fermammo tutti sulla pubblica piazza a mangiare ed a bere; ed io mi divertiva a gettar noci e mandorle in mezzo alla folla, per il gusto di vedere i ragazzi impigliati fra le gonnelle delle vezzose forosette.
Riposati alquanto, ci rimettemmo in viaggio e visitammo Bessude, dove Cambilargiu aveva un amico — certo Pietro Chessa, suo antico compagno di galera.
Salendo poscia per il monte Pelau, arrivammo a Bonnanaro, e condussi i compagni in casa di un mio zio, a cui li presentai come barracelli d’Osilo in cerca del mancamento[37].
Lo zio mi scambiò con mio fratello Giomaria, ch’era barracello di Florinas.
— Non sono Giomaria — mi affrettai a rispondere — sono Giovanni Tolu.
Lo zio sbarrò tanto d’occhi:
— Tu..... sei Giovanni?!
[277]
— Sì... e i miei compagni sono anch’essi banditi.
Il buon uomo pareva sulle spine, non riuscendo a celare la grande paura che aveva in corpo.
Cenammo nondimeno allegramente, e poi si andò a riposare. Ci sdraiammo vestiti su due letti, colle armi vicine.
Mio zio sembrava inquieto, e balzava ogni tanto in piedi, tendendo le orecchie.
— I cani, stanotte, abbaiano troppo! — diceva.
Volendo tranquillarlo, lo pregai di mandar subito a chiamare il capitano dei barracelli di Bonnanaro, ed altri amici.
Vennero in quattro, e si combinò di uscir tutti in campo aperto, per essere più sicuri. Ci sdraiammo sull’erba, e allo zio tornò l’animò in corpo. — Erano le due dopo mezzanotte.
Verso l’alba ci fu servito il caffè, fra le roccie, ed a mezzo giorno divorammo allegramente il lauto pranzo, che lo zio aveva preparato agli ospiti famigerati.
Sull’imbrunire mandammo un espresso a don Ciccio Corda, di Torralba, perchè venisse subito da noi. Egli venne con tre servi: uno ne spedì per i cavalli, e due per la provvista dei viveri.
Sopraggiunta la notte, don Ciccio ci fece condurre in altra sua tanca, tutta in campo aperto, per riposare più sicuri.
[278]
Di là, verso l’alba, passarono a cavallo don Francesco Corda di Clave, don Giovanni Diez, e due loro servi.
Avendoci riconosciuti, don Francesco si accostò a noi.
— Perchè siete qui?! don Ciccio non è uomo che possa farvi male, ma certo non sa custodire persone gelose, quali voi siete! Questo non è luogo sicuro!
— Ci ha fatto fermare qui — risposi — perchè deve mandarci due cavallini.
— Aspetterà forse che i cavalli nascano per regalarveli! — esclamò don Francesco, sghignazzando. — Venite con noi, chè vi daremo cavalli nati. Voi potrete stare nelle nostre terre sette od otto giorni, senza il pericolo di venir molestati!
Ci alzammo in piedi e movemmo incontro ai quattro individui, ch’erano intanto smontati da cavallo. Le quattro bestie dovevano servire per otto uomini. Io presi in groppa uno dei due servi, e Salvatore Fresu fece altrettanto con l’altro. Cambilargiu sedette in groppa al cavallo di don Francesco Corda, e Antonio Spano in groppa a quello di don Giovanni Diez.
Così accomodati, due uomini per cavallo ci mettemmo in cammino, a mezzo trotto.
Curioso, invero, vedere i quattro più famosi banditi del Logudoro trottare con tanta audacia e disinvoltura sulla strada maestra! Se ci avessero [279] quel giorno messo a cimento, Dio sa qual battaglia sanguinosa ne sarebbe avvenuta!
A mezzogiorno in punto i quattro cavalli, carichi di otto uomini, attraversavano allegramente il villaggio di Torralba, passando sotto la caserma dei carabinieri. Noi guardammo alle finestre con aria di trionfo. Chi lo sa? Forse a quell’ora, attraverso ai vetri, qualche carabiniere assisteva al passaggio dell’allegra cavalcata, ben lontano dall’immaginare che quattro uccelli grossi sfidavano la vigilanza dei benemeriti cacciatori!
Arrivati a un certo punto, al di là del paese, smontammo da cavallo; e i due cavalieri coi rispettivi servi tornarono indietro, per riprendere la via di Sassari.
La sera, per altro cammino, volgemmo di nuovo a Bonnanaro, e sostammo in casa del cav. Delogu, il quale ci offrì buon vino e polvere eccellente. Si chiacchierò a lungo; finchè sopraggiunta la notte, uscimmo dal villaggio per salire alla punta di Monte Santo — uno dei rifugi più sicuri in quel tempo, perchè tutto boscoso.
Fummo, lassù, ricoverati dall’amico bonorvese Baldassare Saba; il quale volle uccidere due bestie, per mettere molta carne al fuoco.
Spuntata l’alba, uscimmo sulla spianata, per divertirci alquanto al bersaglio.
[280]
***
La mattina stessa scendemmo da Monte Santo per recarci ad Ardara. Arrivati alle falde, Cambilargiu vide alcuni maialetti, e ne sparò uno colla pistola.
Alla detonazione accorsero alcuni pastori.
— Figli miei! — esclamò Cambilargiu con aria compunta — badate: vi ho ucciso un porcetto!
Uno dei pastori gli rispose umilmente, col riso sulle labbra:
— Se è vero che lo avete ucciso, lo metteremo al fuoco — se non lo avete ucciso, lo uccideremo!
Fatta colazione in fretta e furia, uno dei miei compagni chiese ai pastori un buon cagnetto di razza.
— Ve ne darò uno eccellente fra qualche mese. Lo sto allevando.
— Verrò io stesso a prenderlo! — dissi; e il pastore a me rivolto:
— Se verrà Giovanni Tolu, lo porterà via; ma se non venisse, prometto che il cane morrà in mio potere, poichè non lo darò mai più a nessuno![38]
[281]
A proposito di questo cane, narrerò per inciso un episodio.
Alcuni mesi dopo, ripassando in quell’ovile per ricordare l’adempimento della promessa, trovai il pastore (Bastianu Zamburru) in urto fortissimo col proprio cognato Gio. Maria Sanna. Le cose erano tese al punto, da rendere inevitabile una catastrofe.
Volli fare un’opera buona. Valendomi dell’influenza che esercitavo sulle due famiglie, mi recai in persona all’ovile di Sanna, e costrinsi costui a recarsi dal cognato per far la pace. Io stesso invitai le donne delle due famiglie a riunirsi ad un pranzo comune, a cui presi parte. Si passò la giornata allegramente, e ricordo di aver fatto un brindisi al cagnetto, a cui si doveva la riconciliazione dei due cognati.
Non lo dico per millantarmi. Tutte le volte che io riusciva a fare un’opera buona ed a pacificare fra di loro gli avversari, provavo un’intima soddisfazione, pari a quella di una vendetta compiuta. Amavo la pace degli altri; eppure non ero mai riuscito a pacificarmi coi miei nemici!
***
Riprendo la gita dei quattro banditi.
Arrivati ad Ardara ci presentammo a quel rettore, nativo di Nughedu.
[282]
Egli ci squadrò sospettoso. Cambilargiu gli disse:
— Non tema, signor rettore!
— Non ho paura! — rispose il prete. — Conosco agli occhi l’uomo dalle sinistre intenzioni. Qui siamo in campagna, nè si può avere quello che si vuole. Mangeremo alla buona qualche uovo e un po’ di pane. Ho mandato a Sassari per la provvista del vino, nè può tardare ad arrivarmi.
E infatti, il buon uomo, ci trattò bene, e fummo soddisfatti.
Appena pranzato, pregammo il rettore che facesse venire suo fratello, il capitano dei barracelli, col quale volevamo conferire.
— Che volete da lui?
— Ci abbisognano quattro buoni cavalli per portarci fino a Florinas.
— Ve li provvederò io![39]
Arrivati, dopo un’ora, all’ovile di un comune amico, nelle vicinanze di Ploaghe, rimandammo con un servo i cavalli al rettore di Ardara, e passammo subito in altra capanna di Salvatore Casula. Ciò per abituale precauzione, temendo che il servo potesse rivelare ad altri il luogo del nostro rifugio.
Ci fermammo all’ovile tutta la giornata.
[283]
Venne intanto a trovarci un amico de’miei compagni — scaltro furbone — che guardai subito con diffidenza. Non tardai a capire, che la sosta dei tre banditi nelle vicinanze di Ploaghe aveva per scopo quell’abboccamento, dato in precedenza a mia insaputa.
Ciò mi spiacque, ma feci l’indifferente. Non dovevo dimenticare che io mi ero prestato come guida ai tre compagni nei territori del mio paese.
Il furbone disse ai tre banditi, senza preoccuparsi della mia presenza:
— Io ho una lite con Gio. Antonio X, e corro il serio pericolo di venire ucciso da lui. Mi rivolgo dunque a voi perchè mi liberiate dal mio avversario.
Cambilargiu, un po’ impacciato alla mia presenza, gli rispose:
— Giacchè la tua vita è minacciata, perchè non togli di mezzo Gio. Antonio?
— Io?! Siete voi che dovete ucciderlo. A me spetta il compensare le vostre fatiche.
I tre banditi si scambiarono un’occhiata e ammutolirono. Io pensai un poco, e poi dissi, accentuando le parole:
— Se non mi fossi trovato qui, in vostra compagnia; se non avessi sentito la proposta del vostro amico, non mi sarei certo occupato dei fatti vostri. Avendo però assistito al vostro discorso, è duopo che le cose prendano una [284] piega diversa. Voi non ucciderete Gio. Antonio e se lo ucciderete, ne farò tale uno scandalo da mettervi in impicci colla giustizia, facendovi perdere molti buoni amici. Io non sono qui venuto per servir di guida a sicari! Siamo nel territorio del mio paese!
Aspettavo che i miei compagni aprissero bocca, per piantarmeli là bruscamente; ma in vece nessuno più parlò di uccisioni alla mia presenza.
Venuta la sera ci mettemmo tutti in viaggio a piedi, prendendo la montagna, per recarci ad Osilo. Fu appunto in quel giorno, che Cambilargiu ci pregò vivamente di accompagnarlo in casa del notaio Satta, lo zio di quel tal Leonardo, ucciso barbaramente verso la fontana del fico.
All’indomani lasciai i miei tre compagni ad Osilo, e feci ritorno a Florinas.
***
Poco tempo dopo, Pietro Cambilargiu si era separato da Antonio Spano, del quale diffidava.
Anche Salvatore Fresu finì per essere licenziato dal cugino, poichè egli non faceva che scroccare danari a questo e a quello per poter mantenere la moglie e i figliuoli poveri.
Non passò gran tempo dalla separazione [285] quando Fresu cadde in potere dei carabinieri. Egli venne arrestato colla maschera sul volto, e messo in prigione. Fattogli il dibattimento, venne assolto. Solita giustizia dei giudici, i quali condannano tanti innocenti, per dare la libertà a tanti birbanti matricolati. Noi banditi vedevamo troppo spesso simili spropositi, i quali certamente non facevano che raffreddare la nostra fede verso i tribunali.
Continuai nonpertanto la mia relazione cogli altri due banditi, e specialmente con Pietro Cambilargiu, ch’ebbi a compagno per altri sei mesi, come vedremo in seguito.
[286]
Farò intanto un passo indietro.
Scorrazzava da qualche tempo nei territori di Florinas una compagnia di ladruncoli, i quali svaligiavano le case, e vi uccidevano anche i proprietari, se il bisogno lo richiedeva. Due volte avevo sorpreso e conosciuto quei furfanti, ma non volli denunziarli. Siccome però ero amico dei barracelli, e mi stava a cuore la tranquillità del mio paese, provavo un vivo dispetto per quell’accolta di vagabondi, i quali, non rispettando la roba d’altri, comprometteva gli interessi de’ miei amici e compaesani. Deciso di dar loro una buona lezione, aspettai l’occasione propizia.
Mi erano ben noti questi ladri. Due di essi mi avevano un giorno proposto di unirmi a loro e ad un terzo (che nominarono) per andare a Giave. Scopo della gita era quello di depredare una vecchia signora, che possedeva oltre otto mila scudi, in contanti, e che viveva sola in casa con una serva. Risposi loro sdegnosamente, che [287] non intendevo rendermi complice di simili ribalderie.
Nondimeno quei ladri, non volendo rinunziare all’impresa, si recarono in tre a fare il colpo: Gio. Antonio Gasu, Pietro Sanga di Bosa, e Antonio Maria Deia di Giave — incaricato quest’ultimo di indicare la casa della ricca signora e di diriggere la spedizione.
Aperta la porta ed entrati in casa, i tre furfanti imposero alla serva, con minaccie, di soffocare i latrati del cagnolino.
Penetrarono quindi nella camera della vecchia, che trovavasi a letto.
— O consegnaci la chiave dello scrigno in cui custodisci il danaro, o rassegnati ad essere scannata.
La vecchia tentò gridare, ma uno dei ladri fu pronto a cacciarle una mano in bocca; e siccome colei glie la stringeva fra i denti, il morsicato le tagliò la gola col pugnale.
Sgozzata la donna, i tre assassini si diedero a frugare da per tutto, finchè rinvennero una cassetta pesante, che portarono via. Quando i ladri l’aprirono per dividersi il bottino, rimasero di sasso. La cassetta non conteneva che i moccoli di cera, sopravanzati alla festa delle Anime dei purgatorio, che ogni anno soleva farsi per cura e spese della vecchia devota.
Un altro giorno gli stessi due ladri m’invitarono a fare il sesto in una comitiva, organizzata [288] per derubare la bottega di un negoziante di Bosa. Questa volta, non solo rifiutai di prender parte alla grassazione, ma osai arditamente rimproverarli per le azioni turpi che commettevano.
I ladri si strinsero nelle spalle, e fecero a meno di me. Guidati dall’orefice bosano Andrea Licheri, si recarono a Bosa. Facevano parte della combricola, fra gli altri, Deia, i fratelli Pietro e Francesco Rassu, e Giomaria Ghiu. Aperta coi grimaldelli la porta della casa del negoziante, non vi rinvennero che gli attrezzi dei fuochi d’artifizio, ch’erano serviti alla festa di Santa Filomena, ricorrente all’indomani.
Delusi anche questa volta, lasciarono Bosa; e usciti dal paese scalarono un cortile per rubarvi una ventina di galline, che si divisero — unico bottino di quella malaugurata spedizione.
Malgrado i miei sdegnosi rifiuti, quei malandrini mi tentarono una terza volta. Secondo loro, un bandito non doveva rifiutarsi ad una ribalderia.
Nelle vicinanze di Florinas, venne a me Sanga il bosinco, e mi invitò ad unirmi ad una comitiva, formatasi per derubare Gavino Matteo Marche.
— Chi tutti siete? — gli chiesi con premura, fingendo aderire per conoscere il nome dei complici.
— Me compreso siamo in dodici; — i fratelli Rassu con due loro amici, Deia, Lichinu, Giomaria Ghiu, Gio. Antonio Giasu, e Don Ciccio bosinco. (Quest’ultimo era un cavaliere [289] di Nulvi, ammogliato a Florinas, molto povero e ladro.)
Sdegnato del furto che si voleva commettere nel mio paese, cercai di sventarlo senza inasprire i ladri.
— Badate: a Florinas c’è il barracellato, al quale appartengono due miei fratelli. Chi va per rubare è disposto anche ad uccidere... non si sa mai! Eppoi, ve lo dichiaro: c’entra di mezzo la mia riputazione, e tengo alla tranquillità del mio paese, che mi sa bandito. Voglio che queste cose non si facciano... e voi non le farete!
La mia dichiarazione ebbe il suo effetto. Sanna il bosinco riferì le mie parole ai compagni, e fu sospesa la grassazione che doveva consumarsi in casa di Marche, entro popolato.
Essendo dunque a me noti gli individui componenti la comitiva dei ladri, mi adoperavo perchè il mio paese fosse da essi rispettato. Se a Florinas avevo nemici, avevo pure molte persone di cui godevo la stima, e che contavano sulla mia protezione.
***
Narrerò ora, come quest’odio ai ladri e quest’amore al mio paese mi tornarono quasi fatali. È un aneddoto ben noto all’arma benemerita, e più volte lo rammentai al maggiore dei carabinieri Cav. Ferrè.
[290]
Una notte, dopo aver scorrazzato per la campagna, volli spingermi fin dentro paese, e venni ricoverato in una fida casa, dove si fece cena con diversi amici.
Volle il caso, che in quella stessa notte si fosse concertato un segreto appianamento fra i carabinieri ed i barracelli di Tissi; i quali avevano circondato le case di due dei ladri da me menzionati, perchè in sospetto di aver preso parte a un furto audace commesso in Tissi, a danno di un certo signor Selis. Questi due ladri avevano domicilio a Florinas.
Finito ch’ebbi di cenare, abbandonai la casa ospitale, accompagnato fino all’uscita del paese da un amico guardaboschi, col quale avevo combinato di andar l’indomani a mangiar fichi in una campagna vicina. Il guardaboschi aveva invano insistito perchè io rimanessi un altro giorno a Florinas.
Essendo stato durante la giornata a caccia di pernici, avevo il fucile carico a pallini — cosa rare volte avvenutami, dovendo il bandito tenersi sempre pronto in caso di una sorpresa.
Uscimmo insieme all’aria aperta. Erano le due dopo mezzanotte, e faceva un buio pesto.
Attraversando il largo in cui erano le case abitate dai ladri, scorsi due individui seduti, addossati alla porta di Antonio Maria Deia di Giave. Sospettai subito che qualche cosa di sinistro si tramasse a danno di un mio compaesano.
[291]
Mi scostai risoluto dal mio compagno e mi diressi in punta di piedi verso i due ladri, colla speranza di sventare qualche brutto tiro.
Uno di essi era appoggiato allo stipite e pareva dormisse.
— Non ti svegli, dunque? — Gli gridai con tono energico.
Desto di soprassalto, quell’uomo balzò di scatto in piedi, e vedendo a sè dinanzi un armato, con movimento rapido spianò il fucile e mi fece fuoco a bruciapelo.
La palla, fischiante, mi passò sotto l’ascella.
L’altro compagno fece anch’esso un brusco movimento, come per assalirmi; ma io, pronto come il lampo, scaricai sull’uno e sull’altro le canne del mio fucile, carico a pallini.
Chi lo avrebbe detto? Quei due uomini non erano altri che il maresciallo dei carabinieri ed un barricello di Tissi — entrambi là appostati per sorprendere i ladri, che dovevano rientrare in casa, di ritorno dalla grassazione di Selis. Dalla parte opposta, nel cortile, erano molti altri carabinieri e barracelli, parimenti appiattati per lo stesso fine.
Avevo colpito il maresciallo in piena mammella, ma il colpo al barracello mi era andato fallito, per l’oscurità della notte[40].
[292]
Come mi avvidi dell’errore, feci un salto indietro, mi diedi a correre come un capriolo, e guadagnai la campagna.
Il maresciallo, ferito a pallini, non tardò a guarire.
Allo scoppio delle tre fucilate erano accorsi i barracelli ed i carabinieri che si trovavano nel cortile; e, saputo il caso, e chi io mi fossi, diedero in ismanie. Mi venne riferito, che uno dei carabinieri (certo Ribichesu), quando accorse sul luogo dello scontro, si millantò che non sarei riuscito a sfuggire alla sua palla, se invece del collega fosse stato lui a sedere sulla soglia.
Si vedrà, nel corso della narrazione, come la fatalità trasse sui miei passi questo carabiniere millantatore.
Quest’incidente fu uno dei più curiosi della mia vita. Per voler sorprendere e punire i ladri del mio paese, ero andato a cadere fra le braccia di un barracello e del maresciallo dei carabinieri. Io, che da mattina a sera studiavo i mezzi per sfuggire ai lupi, ero andato a cacciarmi come uno sciocco nella loro bocca.
Manco male che la lezione non andò perduta, poichè in avvenire fui più cauto nel pedinare i malandrini. Non si sa mai: sotto [293] alle vesti di un ladro può nascondersi anche un carabiniere!
Il mio incidente fu risaputo, e destò rumore. Lo narrai, minutamente, al maggiore Ferrè, quando mi chiamò in salvacondotto per interrogarmi sull’uccisione del bandito Gianuario Murgia di Siligo. Io conchiusi:
— Ella vede, signor Maggiore, com’è facile ad un bandito uccidere un carabiniere, anche senza volerlo!
***
Eppure non fu quella la sola volta che caddi in bocca al lupo; i casi furono molti, ma io mi fermerò sui più salienti, seguendo l’ordine della narrazione.
Ripiglierò la storia, ritornando ai famosi banditi, ch’ebbi a compagni nella mia vita avventurosa.
Antonio Spano, dopo un vivo diverbio, si era separato da Pietro Cambilargiu; e siccome era ricercato dalla giustizia e mi aveva in uggia, carezzò il pensiero di acquistare la sua libertà, con un agguato a mio danno.
Di ciò informato per mezzo degli amici, mi misi in guardia.
Il fratello di lui, Salvatore Spano, introdottosi un giorno per far erba nel predio di Dionisio Matti di Sassari, fu da questi sorpreso e acerbamente [294] rampognato. Inasprito dalle parole, Salvatore gli puntò la pistola sul petto. Dionisio denunziò il fatto all’autorità giudiziaria, e l’aggressore fu arrestato e condannato a sei mesi di carcere.
Questo fatto era capitato parecchi mesi dopo la morte del figlio tredicenne di Dionisio, ucciso accidentalmente dentro la propria bottega, nello scontro avvenuto fra i Saba ed i Macioccu.
Nel frattempo che Salvatore scontava in carcere la pena, Antonio Spano volle vendicare il fratello; e travestitosi cogli abiti del muratore Antonio Depalmas, riuscì ad uccidere Dionisio con una fucilata.
Poco dopo la mia gita ad Osilo coi tre banditi (dai quali mi ero separato), Pietro Cambilargiu si recò all’ovile di mio cognato Gio. Antonio Bazzone, nelle vicinanze di Florinas, e lo pregò di fargli ottenere un abboccamento con me.
Due giorni dopo andai a trovarlo.
— Che volete, zio Pietro?
— Ascolta, figlio mio. Tu sei solo, e solo sono io. Perchè non unirci? In due si sta meglio che soli: non ti pare?
— Uniamoci pure! — risposi.
E così, per oltre sei mesi, fummo compagni quasi indivisibili.
[295]
***
Eravamo insieme da parecchi mesi, quando un giorno, in territorio d’Osilo, venne a trovarci la moglie di Cambilargiu. — Era costei la vedova di un suo cugino, da lui resa madre, e poi sposatala per minaccia dei fratelli e dei parenti.
Si pranzò tutti insieme. Io ero serio e taciturno.
— Cosa hai, figlio mio? — Mi chiese il compagno, appena la moglie andò via.
— Ho l’umor nero, nè so perchè.
— Ebbene, cercherò allora di divagarti. Andremo a passar la notte in un molino di Nulvi; di là passeremo a cogliere un po’ di carciofi nella vigna di un mio cugino prete, e li faremo cuocere per la cena.
Movemmo insieme verso Nulvi. Fermatici alquanto nella cardiera del prete, per spiccarvi non più di due dozzine di carciofi, continuammo la nostra strada, quando udimmo alcune fucilate nella vigna di Giorgio Vacca, posta in regione di Nuzzi, a mezz’ora da Osilo.
— Hai sentito? — Dissi rivolto al compagno.
— Sarà il padrone della vigna: un medico di casa, che mi è amico.
Ci fermammo dinanzi al cancello. Io dissi a Pietro:
[296]
— Entra tu per il primo, poichè vi sei conosciuto.
Cambilargiu passò avanti; io mi fermai a rinchiudere il cancello, e gli tenni dietro.
Fatti alcuni passi udimmo abbaiare un cane, che comparve sulla porta della casa, distante una trentina di passi dal cancello. Quasi subito venne fuori un zappatore, il quale, dopo aver imposto al cane di tacere, guardò verso di noi e si fermò con senso di sgomento.
In un attimo sbucarono dalla casa sette carabinieri, che si schierarono sul piazzale, come per meglio esaminarci. Il zappatore, certamente, aveva pronunciato il nome di Cambilargiu.
Questi si volse a me dicendo:
— Coraggio, figlio mio, non temerli: sono carabinieri!
Io diedi un salto all’indietro e corsi ad aprire il cancello gridando:
— Vieni fuori subito! Ci sono io qui!
Cambilargiu mi raggiunse; e allo stesso tempo una scarica di quattro o cinque fucili mandò in ischeggie parte del cancello. Il denso fumo della polvere c’impedì di vedere i carabinieri; nondimeno, io e Cambilargiu puntammo i fucili in direzione degli armati e facemmo fuoco, dandoci poi alla fuga.
Eravamo illesi per vero miracolo. Una palla mi aveva spezzato la bacchetta del fucile, ed un’altra era strisciata lungo la manica della [297] mia giacca, senza toccarmi la carne e senza farmi versare una stilla di sangue.
Era il 10 giugno 1853, di venerdì.
L’indomani ci venne riferito, che un carabiniere era caduto morto, e ad un altro la palla aveva spezzato il calcio della pistola. Se alla mia palla, o a quella di Cambilargiu, si dovesse la morte del carabiniere, nessuno di noi seppe mai: certo è che i carciofi del prete, anche questa volta, mi avevano cacciato in bocca al lupo[41].
Avendo noi preso, nello scappare, due diverse [298] direzioni, ci perdemmo di vista, e non ci trovammo insieme che la domenica, due giorni dopo lo scontro fatale.
Chi avrebbe mai detto, che anche in quel giorno io doveva essere messo a più dura prova? Eppure così volle il destino, come dirò nel capitolo seguente.
[299]
Era la domenica. Trovato per caso Cambilargiu, mi pregò di tenergli compagnia fino all’ovile de’ suoi cugini Migheli, posto sul Monte fenosu, in faccia a Scala di Ciogga. Messici in cammino, mi confidò di aver dato colà appuntamento ad una persona distinta, che desiderava conferire con lui.
Arrivati alla capanna, chiesi a Cambilargiu il nome dell’uomo che aspettava.
— È un sassarese: Carlo Tiragallo.
— Chi è costui?
— Un regio impiegato; un segretario dell’Intendenza; un signore ricco.
— Ben soventi questi signori ci fanno la spia!
— Non è di questi tali. Trattasi di persona ammodo, molto distinta.
— Caro zio Pietro; i signori si vendicano sempre, quando si presenta loro l’occasione, ed è meglio non fidarsene.
[300]
I fratelli Migheli, punti dalle mie osservazioni, soggiunsero a me rivolti:
— Tu sei un miserabile, un pusillanime, e non vali nulla!
— Basta — conchiusi con calma — ora qui siamo, e qui resteremo; però vi dichiaro, che non pranzeremo insieme. Voi starete nell’ovile colla famiglia, e noi all’aperto, in un punto vicino, dove ci porterete da mangiare, ed accompagnerete l’uomo distinto, che verrà per conferire con Cambilargiu.
— Si direbbe che tu hai paura!
— Amo la prudenza. Voi siete abituati a trattare coi signori di Sassari, i quali vi danno i buoni bocconi, in cambio dei magri agnelli che uccidete per loro. Ci avete il tornaconto, lo so; ma badate che i bocconi della città non vi facciano nodo alla gola!
Quantunque io avessi insistito, Cambilargiu fu di parere di far pranzo comune dentro la capanna, insieme al signore che sarebbe arrivato da Sassari.
I fratelli Migheli, colle rispettive mogli, figli e servi, abitavano in due distinte capanne vicinissime. D’ordinario le due famiglie convivevano insieme.
Mezzogiorno era appena trascorso, quando comparve Carlo Tiragallo, in compagnia del figliuolo ventenne Giuseppe. Le carni erano cotte, e ci mettemmo quasi subito a tavola, apparecchiata nella capanna più grande.
[301]
Carlo Tiragallo (come in seguito appresi dallo stesso Cambilargiu) si era recato a Monte Fenosu per chiedere informazioni sull’individuo che aveva sparato suo padre (il maggiore Agostino Tiragallo) mentre si trovava in un suo predio di Sassari.
— Se lo hai sparato tu — gli aveva detto il signor Carlo — siamo disposti a perdonarti; ma se il tiro gli venne dal bandito Antonio Spano, io ne voglio vendetta, e mi affido a te per compierla.
Il maggiore Tiragallo aveva inseguito il suo aggressore, ma non potè raggiungerlo, nè riconoscerlo. L’uomo che gli aveva dato la fucilata (andata a vuoto) era realmente Antonio Spano.
Riprendo la narrazione.
Sedemmo a tavola, io, Cambilargiu, i due Tiragallo padre e figlio, e i due fratelli Migheli colle rispettive mogli e figli; una ventina in tutti, compresi i seni e le serve, e senza contare i quattro uomini posti a vedetta fuori della capanna, com’è usanza fra banditi, quando si riuniscono in un luogo chiuso.
Era la una dopo mezzogiorno.
Con sorpresa avevo notato, che Carlo Tiragallo, prima di sedere a tavola, si era tolto dalle saccoccie due pistole nuovissime; una ne aveva deposto sul letto delle donne, l’altra se l’era messa alla cintola, dopo averne montato il grilletto.
Quest’operazione mi aveva messo in diffidenza; [302] ond’è che io, per precauzione, volli sedermi armato di pugnale e di fucile tra i due Tiragallo — deciso di pugnalarli entrambi se si fossero rivolti contro di noi, o se avessi avvertito la presenza dei carabinieri. Da questo lato, lo confesso, io era il più intransigente dei banditi.
Si chiacchierò allegramente durante il pranzo; e Tiragallo, colle sue barzellette, fece ridere le donne. Terminato di pranzare, Cambilargiu disse a me rivolto:
— Figliuolo mio, tu devi scusarmi se ti lascio solo un momento, per andare all’aperto a conferire col signor Tiragallo.
E i due commensali uscirono per recarsi sul promontorio ingombro di macchie, che sovrastava la seconda capanna, distante da noi una quarantina di passi. Ivi sedettero, per parlare non visti e senza testimoni.
Pochi minuti dopo si alzò da tavola anche Giuseppe Tiragallo, e con lui tutti i commensali, che uscirono all’aperto per ridere e chiacchierare. Era un giorno di festa e si era tutti allegri.
Dentro la capanna non ero rimasto che io, ed una giovinetta quindicenne, a cui avevano affidato una bambina che si teneva sulle ginocchia. Non volli uscir fuori perchè temevo d’esser veduto dalla punta di Scala di Giocca, dove non mancano sassaresi a passeggiare, massime nei giorni di festa.
Mentre Cambilargiu e Tiragallo discorrevano [303] sul promontorio boscoso, e le donne e i bambini ridevano e scherzavano sul piazzale, Pietro Migheli — uno dei due proprietari dell’ovile — era rientrato nella capanna per scambiare qualche parola con me.
A un tratto si udirono abbaiare i cani, e il Migheli si fe’ all’uscio.
— Non è nulla — disse rientrando. — Lo schiamazzo dei bambini e il riso delle donne rende inquiete le bestie.
Dopo alcuni minuti i cani tornarono ad abbaiare più forte; Migheli tornò ad affacciarsi alla porta, e rientrò subito pronunciando una sola parola:
— Carabinieri!
— Va fuori! — gli gridai balzando in piedi — e lasciami solo!
La giovinetta quindicenne, che conobbe il pericolo, si diede a piangere; e volgendomi ad essa le gridai imperiosamente:
— Va fuori anche tu, e sta zitta!
Rimasi tutto solo dentro la capanna.
In un lampo, con mente serena, abbracciai la situazione. Guai al bandito che nei momenti del pericolo perde il suo sangue freddo: egli è morto!
Nove carabinieri a cavallo, guidati dal maresciallo, correvano all’impazzata dall’una all’altra capanna dei fratelli Migheli. Erano venuti dal versante di mezzogiorno, senz’essere avvertiti [304] dalla vedetta, che imprudentemente aveva abbandonato il suo posto.
Altri venti carabinieri a piedi (come appresi più tardi) si erano appostati alle falde boscose di Scala di Ciogga, di fronte a Monte Fenosu.
Come Cambilargiu avvertì dall’altura i soldati che salivano la collina, aveva piantato Carlo Tiragallo, e se l’era svignata cacciandosi di macchia in macchia, inosservato. Affettando indifferenza, Tiragallo era venuto giù, passo passo, fino al piazzale della capanna, dov’io mi trovavo.
Il momento era solenne; ma mi erano bastati pochi secondi per prendere la decisione estrema. Assicurai con una cordicella la mia pistola al polso destro; afferrai la pistola lasciata da Tiragallo sul letto, e me la legai parimenti al polso sinistro. Mi accertai che la lama del mio pugnale uscisse liberamente dal fodero; montai i grilletti del mio fucile a due colpi, e mi cacciai in fondo alla vastissima capanna, nell’angolo più oscuro, pronto all’assalto ed alla difesa. Avevo di fronte la porta (esposta a levante) e vedevo chiaramente quanto accadeva sul piazzale. Sentivo il pianto delle donne, gli strilli dei bambini, e il rumore delle sciabole dei carabinieri, i quali correvano di qua e di là come indemoniati.
Il maresciallo, a cavallo al par degli altri, si piantò dinanzi alla porta, alla distanza di cinque o sei passi. Egli si rivolse a Carlo Tiragallo, che gli era vicino, ma ch’io non vedevo:
[305]
— C’è nessuno dentro la capanna?
— Nessuno. La capanna è vuota! — rispose deciso Tiragallo, certamente persuaso che anch’io fossi uscito all’aperto, riuscendo a mettermi in salvo prima dell’arrivo dei carabinieri.
Il maresciallo si rivolse a’ suoi dipendenti:
— Qualcuno di voi smonti da cavallo e s’introduca nella capanna.
Un carabiniere smontò di sella, e cacciò più volte la testa dentro la capanna, senza però varcarne la soglia. Era titubante ed aveva paura.
L’oscurità in cui mi trovavo gli impediva di vedermi.
La situazione diventava più critica. Se i carabinieri si fossero assembrati dinanzi alla porta, la mia uscita sarebbe stata impossibile.
Feci due passi in avanti, risoluto di slanciarmi con impeto all’aperto, dando uno spintone al carabiniere che stava sulla porta. La mia sorte era decisa: o salvarmi per miracolo coll’audacia, o cader fulminato dalle palle di venti carabine.
Il carabiniere che con titubanza cacciava la testa nella capanna, senza decidersi ad entrare, si era alquanto scostato, lasciando libera la porta.
Il maresciallo allora, o che avesse avvertito la mia presenza, o che volesse sgomentare un bandito nascosto, puntò il fucile verso l’interno della capanna e fece fuoco. La palla andò a conficcarsi nello stipite, ed una scaglia colpì al labbro il carabiniere vicino.
[306]
Costui, sentendosi ferito, indietreggiò, dicendo che gli avevano fatto fuoco dall’interno della capanna.
Gli altri carabinieri smontarono allora da cavallo, e si fecero alla porta, gridando:
— Compagni, coraggio!
Colla furia di un gatto selvatico mi slanciai fuori all’aperto, col fucile in faccia. Scaricai una delle canne a destra, e l’altra a sinistra, e vidi un carabiniere stramazzare. I compagni, da una parte e dall’altra, fecero un movimento istintivo, come per scansare il colpo — ed io ne approffittai per saltare come un capriolo in mezzo ai miei aggressori. Svoltai a sinistra, in faccia a Scala di Ciogga; gettato a terra il fucile scarico, impugnai le due pistole, e giù a capofitto, fra gli armati, a raggiungere il ciglione del monte.
Oltrepassata di una diecina di metri la capanna, dietro un piccolo promontorio coperto di macchie, mi trovai a sinistra dinanzi a quattro carabinieri in agguato. Con un coraggio disperato mossi loro incontro, puntando le due pistole; essi abbassarono la testa per schivare il colpo; ma io, colla rapidità del lampo, mi voltai di scatto, raggiunsi il ciglione della roccia a picco, tesi in alto le braccia stringendo in pugno le pistole, spiccai un leggero salto, e mi lasciai cadere nel vuoto, per un’altezza di oltre venti metri.
La falda della montagna era tutta roccie e bosco, con piante altissime di elci.
[307]

Caddi in piedi, senza urtare per miracolo in alcun ramo; battei leggermente la schiena contro un sasso, ma arrivai a terra illeso. Ero salvo. Non avevo perduto che il berretto ed il fucile. Pensai allora che i carabinieri sovrastanti mi avrebbero fatto fuoco dal ciglione, dandomi la caccia. Strisciai come un serpe fra macchie, roccie e grossi sassi lungo il dorso del monte, fino a che giunsi ad un tratto nudo e roccioso, che io non poteva attraversare senza sfuggire all’occhio vigile de’ miei cacciatori. [308] Camminai carponi, mi aggrappai alle roccie e alle macchie, strisciai tra i lentischi e gli elci, mi lasciai rotolare dove il passo era impossibile, e mi trovai alfine alla base del monte. Lamentai allora la perdita del fucile, perchè sentivo di essere un uomo nullo.
Continuai a camminar carponi, finchè m’internai nel bosco un’altra volta, dove i carabinieri non mi potevano scorgere, nè inseguire.
Sedetti alcuni minuti, perchè avevo bisogno di riposo; indi mi diedi a contemplare l’alto monte, compiacendomi dell’avventura toccatami.
Trenta carabinieri si erano recati lassù per arrestare il terribile Cambilargiu, ed invece era stato io l’eroe della giornata. Circondare un bandito dentro il suo covo, e lasciarselo scappare, non era certo un’impresa degna di encomio per l’arma benemerita!
Ma perchè i carabinieri non mi fecero fuoco addosso? Ne suppongo la ragione: — quelli che circondavano la capanna si erano disposti in modo da impedire la mia fuga; ma non avevano pensato, che venendo io fuori, essi non avrebbero potuto spararmi senza ferirsi a vicenda. I quattro, che trovai in agguato a poca distanza dal ciglione, tacquero di avermi veduto, forse per non esser puniti.
Il carabiniere da me colpito a Monte Fenosu era Ribichesu: precisamente colui che a Florinas si era vantato che mi avrebbe ucciso, se si fosse [309] trovato dinanzi alla porta di Antonio Maria Deia. Fu il destino che me lo cacciò fra i piedi![42]
Camminai a grandi passi per una mezz’ora, finchè giunsi dinanzi all’ovile di Giovanni Mangattia. Mi accorsi che vi erano donne, e per non spaventarle finsi l’indifferente e mi accostai cantarellando.
— Non ci sono uomini, qui?
— Li abbiamo in giro. Che volete, Giovanni?
— Vorrei una cavalla. Ho saltato una roccia e mi son fatto male ad un piede. Le precauzioni non sono mai troppe!
La donna andò a slegare una cavalla, che si diede a tirar calci.
— Che vuol dir ciò? è stata sempre docile, ed ora fa la matta!
La donna non si era accorta, che la cavalla aveva sentito l’odore della polvere. Quando avviene uno scontro, c’è sempre uno spirito infernale che si mette di mezzo; e questo spirito s’era impadronito della cavalla di Mangattia. Non tutti [310] ci credono, ma io l’affermo perchè ne ho avuto l’esperienza. Infatti, quando una cavalla (che vede più d’un uomo) adocchia sulla strada uno spirito, s’impunta; e se noi, smontando, non facciamo il segno della croce, non c’è verso che essa vada innanzi[43].
Saltai sulla cavalla, dicendole:
— Ora che ti ho sotto, sbuffa, starnuta, calcitra, o crepa: l’hai da fare con me!
E rivolto alle donne:
— Fra un’ora ve la rimanderò.
— Tienila quanto vuoi.
Attraversai a mezzo trotto Badde Olia, Cannedda, Bunnari, Planu de murtas. Fatta un’ora di strada giunsi ad un’alta punta, nel sito chiamato Scala Ruja, in territorio d’Osilo. Di là potevo scorgere chiaramente la sommità di Monte Fenosu, dov’era avvenuto l’attacco.
Il sole era vicino al tramonto, ed io vidi il lucicchio di un gran numero di fucili.
Seppi più tardi, che, poco prima della mia fuga dalla capanna, s’era mandato un espresso a Sassari per chiamare un aumento di forza. Fu spedita sul luogo una compagnia di soldati, guidata dallo stesso colonnello. Ma era tardi. I due uccelli avevano preso il volo.
Arrivati dinanzi alla capanna, il colonnello esternò il sospetto di qualche nascondiglio [311] nell’interno, che servisse di rifugio a Cambilargiu; e senz’altro diede ordine di appiccarvi il fuoco, dopo averne fatto togliere le masserizie.
Si era dunque avverata la mia profezia ai fratelli Migheli: — badate che i bocconi della città non vi facciano nodo alla gola!
Carlo Tiragallo e suo figlio Giuseppe furono sospesi dall’impiego per ordine del Governo. Il primo, tradotto a Cagliari, fu condannato a diversi mesi di carcere, sotto l’accusa di favoreggiare i banditi. La presenza di Carlo Tiragallo a Monte Fenosu, e la sua affermazione che nella capanna non c’era nessuno, lo avevano pregiudicato. Noi credemmo, invece, ch’ei si fosse prestato a farci un po’ la spia. Quantunque punito dal Governo per la menzogna e per l’insuccesso della spedizione, ho sempre creduto che anche il suo arresto fosse una commedia, per metterlo in salvo dalle nostre vendette. Non è neppure improbabile, che lo scorno fatto subire alle armi regie nella giornata del 12 giugno 1853 avesse provocato lo sdegno del Governo. I Tiragallo erano coraggiosi ed audaci, e la loro venuta a Monte Fenosu per vendicare l’insulto fatto al Maggiore Agostino, non era forse estranea al complesso degli avvenimenti.
[312]
Dalla punta di Scala Ruja mi recai all’ovile di mio cognato (in su Crastu mal’a servire) nel territorio di Codrongianus e di Cargeghe.
Colà appresi, dal mio congiunto, essersi già divulgata la voce, ch’io fossi rimasto ucciso, od arso vivo, nell’assalto di Monte Fenosu.
Arrivati insieme nelle vicinanze di Florinas, dissi a mio cognato:
— Dammi il fucile ed il berretto, e precedimi nel paese. Io resterò qui, fino al tuo ritorno.
Mio cognato trovò molta gente che faceva ressa dinanzi alla porta della nostra casa. La mamma, le sorelle, i miei fratelli piangevano la mia morte. I signori di Florinas si fingevano addolorati per la disgrazia toccatami, e cercavano di consolare i miei congiunti; ma in fondo erano contenti di essersi liberati di me.
Mio cognato entrò in casa tutto allegro, e rivolto ai signori e a’ miei parenti, esclamò:
— Cessate il pianto e consolatevi! Nulla [313] di grave è avvenuto. È appena una mezz’ora che ho lasciato Giovanni, sano e salvo come siamo noi!
La mamma e le mie sorelle, pazze dalla contentezza, ringraziarono Dio; ma non so davvero se i signori florinesi abbiano fatto altrettanto!
Mi fu subito mandato da casa un berretto nuovo; e pregai mio cognato che mi lasciasse per un po’ di tempo il suo fucile.
Una settimana dopo venne a trovarmi Pietro Cambilargiu, per informarsi s’ero stato ferito, e se avessi riportata qualche contusione nella caduta.
Narratogli il mio caso, lo esortai ad unirsi a me per raggranellare dagli amici la somma necessaria per l’acquisto di un nuovo fucile.
Si andò insieme a trovare Salvatore Pinna, il capitano dei barracelli di Florinas; il quale, a nome di tutta la compagnia barracellare, mi sborsò dieci scudi, prelevati dalla cassa sociale. Si mandò in seguito un’ambasciata anche a Gianuario Masia e a certo Marongiu, capitano e tenente dei barracelli d’Ossi.
Essi risposero, di lasciarci vedere nell’ovile dello stesso Masia, nella Nurra, dove si sarebbe stabilita la somma da consegnarsi.
Pietro Cambilargiu, sempre diffidente ed ombroso, mi disse con certo risentimento:
— Mi avvedo oramai che gli abitanti d’Ossi [314] sono tutti d’accordo per farmi arrestare, collo scopo di procurare la impunità al loro compaesano Antonio Spano. È un complotto fatto!
— Hai torto a parlare così! Essi pensano solamente a soccorrermi, non a tendere un’insidia al mio compagno.
Pochi giorni dopo Cambilargiu volle farmi una confidenza:
— Senti, figlio mio. Ti avverto che, a tua insaputa, ho fatto scrivere a mio nome una lettera a Monsignor Varesini. Gli ho chiesto cento lire, dicendogli che ti abbisognavano per comprare un fucile, avendo perduto il tuo nello scontro di Monte Fenosu. L’arcivescovo di Sassari mi fece avere la somma... ed io me ne sono servito. Aggiusteremo i conti un’altra volta[44].
A Cambilargiu erano abituali queste truffe, che io detestava. Un giorno gli consegnai una somma, pregandolo di acquistare ad Osilo l’orbace necessario, per farmi fare una giacca dalla moglie, molto abile in simili lavori. Non vidi più denaro, nè giacca!
Una sera, finalmente, il capitano dei barracelli d’Osilo mi avvertì, che un mercante di panno, certo Vigliano Altea, aveva un buon fucile da vendere. L’arma mi piacque, e il capitano [315] l’acquistò per cento lire, che prelevò dalla cassa sociale del barracellato.
Quel giorno Cambilargiu mi disse:
— Ed ora siamo in pace; tu possiedi il fucile, ed io mi tengo le cento lire dell’Arcivescovo di Sassari!
Non fiatai; ma il mio compagno non era contento. Parecchie settimane dopo mi fece una nuova proposta:
— Senti, figlio mio. Giacchè il capitano dei barracelli d’Ossi non si è ancora degnato di sborsarti la somma promessa per l’acquisto del fucile, andiamo a rubargli un cavallo; e poi gli diremo che se vuol riscattarlo ci dia qualche soldo.
Secondai questa volta l’amico per un doppio scopo. Ci recammo insieme ad un’aia, dove sapevamo essere un buon cavallo, appartenente ad uno zio di Antonio Spano, l’antico nostro compagno, col quale eravamo in rottura, ed a cui volevamo fare un dispetto.
Il cavallo era stato ritirato dal padrone pochi giorni prima; ed allora portammo via un’altra buona cavalla, del valore d’una trentina di scudi. Allo stesso tempo mandammo a dire al capitano dei barracelli d’Ossi, che la bestia era in nostro potere, e che lui poteva da noi ritirarla mediante lo sborso di soli sei scudi.
Il capitano Masia ci mandò subito 35 lire, che Cambilargiu intascò avidamente.
[316]
— No — diss’io — bisogna essere di parola. Ho detto sei scudi, e non devono essere sette!
Ed imposi al mio compagno di rimandare al capitano uno scudo e la cavalla.
Anche estorcendo l’altrui danaro, bisognava essere onesti e galantuomini!
[317]
I fratelli Migheli, dopo lo scontro avvenuto nei loro ovili di Monte fenosu, temendo giustamente d’essere presi di mira per aver dato ricetto a due famosi banditi, si erano dati alla macchia. Non tardarono a cadere nelle mani della giustizia, e furono chiusi in carcere.
Diversi signori di Sassari, amici loro, volendo mettere in libertà i due innocenti, si rivolsero a me ed a Cambilargiu, per impaurire alcune autorità colle minaccie.
Da qualche tempo, infatti, i giudici usavano un rigore eccessivo contro i nostri ricettatori; e bastava che io o Cambilargiu fossimo accolti in un ovile, perchè i poveri pastori venissero perseguitati e messi in carcere. Ai ricorsi anonimi seguiva immantinenti il processo, e la condanna.
Simile misura ingiusta ci amareggiava l’anima. Che colpa, infatti, ai poveri pastori od ai contadini, se ci davano ricetto e vitto quando [318] ci presentavamo alle loro capanne? E come avrebbero osato negarci un soccorso, quando la nostra vendetta poteva farli pentire del rifiuto datoci?
L’ospitalità sarda è generosa, illimitata, cieca; nè vi ha capanna, nè ovile, nè casolare di campagna che abbiano mai negato rifugio e pasto ad uno straniero, che si presenta per chiederli! Non è solamente la paura di un bandito che provoca la generosità di un pastore o di un signore: nessuno nega un soccorso a chi lo chiede; ed è meglio cento volte essere tacciato di ricettatore, che macchiarsi d’infamia vendendo il proprio ospite.
L’ospitalità non si concede ai soli banditi. Cento volte io venni rifugiato, sfamato, soccorso, senza sapere ch’io mi fossi. Il pastore, infatti, si guarda bene dal chiedere il nome dell’ospite che capita nel suo ovile, poichè ben sa che nessuno ha il dovere di declinarlo.
La giustizia ha dunque torto di perseguitare e punire i ricettatori di un bandito. Quanti furti, quante grassazioni, quanti omicidi risparmiati per quell’asilo concesso, per quel tozzo di pane dato, per quel riposo consentito! Le compagnie barracellari dovevano all’amicizia dei banditi la sicurezza delle campagne; poichè senza di essi non avrebbero potuto conseguire benefizio alcuno. Il vero bandito sardo fu il terrore dei ladri di campagna; una sua minaccia li atterriva. Io ben [319] so, che la giustizia fa il suo dovere — ma so ancora che molti giudici, diventati liberi cittadini, non si rifiutarono mai a dar ricetto ai latitanti. È rarissimo il caso di un tradimento. Quanti nomi di persone ragguardevoli potrei io qui registrare, le quali mi hanno dato asilo e soccorso, mantenendo il più scrupoloso silenzio sulla loro generosa protezione in nome dell’ospitalità, ed anche colla coscienza di aver contribuito a fare un bene e non un male alla società! — Avrei voluto vederli i signori giudici al posto dei nostri ricettatori, che vivevano solitari in aperta campagna!
La persecuzione crudele verso i ricettatori, lo ripeto, ha sempre indisposto i banditi; ond’è che io e Cambilargiu non potevamo rimanere insensibili alla dura sorte toccata ai fratelli Migheli; i quali in ogni tempo ci avevano dato ospitalità, più per bontà del loro animo, che per il vincolo di parentela che li legava a Cambilargiu.
Fra i più severi e inesorabili nemici dei ricettatori era il giudice Satta, ploaghese, stabilito da molti anni a Sassari. Costui era un vero cerbero; faceva arrestare a diritta ed a manca quanti concedevano un giaciglio o un tozzo di pane ad un bandito.
Dissi un giorno a Cambilargiu:
— Senti: bisogna che da una buona volta ci decidiamo a fare qualche cosa per giovare [320] alla causa dei nostri amici e tuoi cugini fratelli Migheli. Ho studiato il modo di rendere mansueto e tollerante il giudice Satta.
— Che hai pensato?
— Ho una bella idea: mettere il giudice Satta nella critica condizione dei ricettatori. Vieni con me, e secondami.
Il giudice Satta possedeva a Sassari, nella regione Eba ciara, una piccola campagna, dove soleva passare una buona parte del maggio e dell’ottobre, insieme alla famiglia. Sapendo che il giudice trovavasi colà da qualche settimana, io mossi a quella volta in compagnia di Cambilargiu.
Era mezzogiorno, quando arrivammo sotto al colle dei Cappuccini.
Aprimmo il cancello, attraversammo il viale, e ci spingemmo fino alla modesta casetta. Dall’acciottolìo dei piatti e dal rumore delle posate ci accorgemmo ch’era l’ora del pranzo.
Fattosi alla porta il vignataro, gli dissi risoluto:
— Di’ al tuo padrone, che abbiamo urgente bisogno di conferire con lui!
Fummo fatti entrare addirittura nella sala da pranzo. Erano a tavola una diecina di persone, compresi i bambini.
— Il signor giudice Satta? — chiesi rispettosamente, ponendo la mano al berretto.
Il giudice levò gli occhi su di noi, e ci fissò [321] sbigottito, pallido per la paura. Certamente, vedendoci armati di fucili, di pistola e di pugnale, capì subito che aveva da fare con banditi.
— Sono io! — balbettò con voce fioca e tremante — E voi... chi siete?!
— Io sono Giovanni Tolu! — risposi umilmente.
— Ed io Pietro Cambilargiu! — soggiunse il mio compagno, con bontà rispettosa.
Il giudice sbarrò tanto d’occhi. Alcuni giovanotti, udendo i nostri nomi, si erano alzati vivamente da tavola ed avevano scavalcato la bassa finestra della sala terrena.
Io mi affrettai a soggiungere:
— Non abbiano paura; non veniamo qui per far male a nessuno. Siamo banditi, e abbiamo il diritto di vivere come tutti gli altri uomini. Chiediamo ben poca cosa. Abbia la bontà, con suo comodo, di mandarci una trentina di lire per mezzo del suo vignataro. Gli indicheremo il sito, dove troverà la persona a cui consegnarle.
— Non mancherò di farlo! — rispose il giudice Satta, respirando più liberamente. — Sono spiacente di non aver la somma presso di me...
— Non si disturbi. La manderà domani, con suo comodo.
Il giudice Satta e la famiglia ci fecero allora buon viso, e ci offrirono da mangiare e da bere; ma Cambilargiu si affrettò a dire, col suo solito fare brusco ed insolente:
[322]
— No: non vogliamo bere nè mangiare, poichè potreste darci il veleno!
Ciò detto, augurammo il buon appettito ed uscimmo dalla sala.
Oltrepassato il cancello dissi al mio compagno:
— Hai capito? D’ora innanzi il giudice Satta sarà più clemente coi ricettatori di banditi. Anche lui ci ha dato ricetto, ci ha offerto da bere, e ci manderà denaro! Puoi star certo che farà silenzio sulla nostra visita!
— Bravo! — mi disse Cambilargiu — hai dato prove di abilità e di furberia!
***
Sollecitati di nuovo ad adoperarci per la liberazione dei fratelli Migheli, io dissi a Cambilargiu:
— Che pensiamo di fare per i tuoi cugini? Non bisogna dimenticare che i due figli di Salvatore Spano, di Ploaghe, sono impiegati nella magistratura di Sassari!
— Andiamo dunque a trovare Salvatore a Ploaghe!
— No. È più prudente farlo venire in campagna; e a questo penserò io. Mettiamoci in viaggio.
Giunti nelle vicinanze di Florinas, mandai a chiamare Salvatore Pinna, ex barracello, al [323] quale diedi incarico di recarsi a Ploaghe per far venire lo Spano al molino di Badu-canu, dove noi lo aspettavamo.
Raccomandai intanto a Pietro Cambilargiu che frenasse il suo carattere irritabile, mostrandosi umile e sottomesso col proprietario Salvatore Spano, uomo grave, di buon senso, e fra i più saggi del paese.
Un’ora dopo lo Spano ci stava dinanzi:
— Che si vuole di me?
— L’abbiamo qui chiamato per farci una carità.
— Dite pure.
— La preghiamo di raccomandare a’ suoi figliuoli, impiegati a Sassari, di usare un po’ di misericordia ai fratelli Migheli, d’altro non rei che di aver dato ricetto nella loro capanna a Pietro Cambilargiu ed a Giovanni Tolu.
— Non mancherò di farlo. Ricordatevi però, che i figli miei non rappresentano il governo di Sassari. Essi sono semplici impiegati, che dipendono da un’autorità superiore. Procuratevi dunque altre ingerenze, e così uniti potremo giovare alla causa dei vostri raccomandati.
Pietro Cambilargiu, con l’aria spavalda che gli era abituale, disse rivolto allo Spano:
— Badi di fare qualche cosa, chè altrimenti quei signori l’avranno da fare con noi!
Il vecchio Spano corrugò la fronte, e disse gravemente rivolto al mio compagno:
[324]
— Pietro, tu parli male! Quando si domanda una grazia, non si ricorre a minaccie nè ad insolenze, che con me sono inutili. I miei figli sono signori, vivono a Sassari, nè possono temere alcun danno da te. Se vuoi essere ascoltato, parla come uomo, non come un insensato!
Allontanatosi Salvatore Spano, ebbi un vivo diverbio col mio compagno per le sue maniere ruvide e villane.
— Hai dimenticato che siamo nelle vicinanze del mio paese! — gli dissi — Io tengo a non essere insolente, nè sgarbato colle persone dabbene!
Messici poi d’accordo, combinammo di rivolgerci ad uno studente, per scrivere alcune lettere all’indirizzo di persone autorevoli, in relazione con giudici.
Le pratiche nostre, unite a quelle dello Spano, ebbero un ottimo risultato. Poche settimane dopo i due fratelli Migheli venivano rimessi in libertà dal tribunale di Sassari.
[325]
Faccio un passo indietro. Ho bisogno di dichiarare che io non posso seguire scrupolosamente l’ordine cronologico dei fatti avvenuti. Per essere più chiaro, intraprenderò, ramo per ramo, la storia della mia vita. Non si deve dimenticare, che io narro gli avvenimenti di quarant’anni, nè potrei interrompere un episodio per riprenderlo a salti, secondo i diversi tempi in cui si svolse.
Erano appena iniziate le prime pratiche per la liberazione dei fratelli Migheli, quando il comune di Florinas pensò alla riorganizzazione della compagnia barracellare per l’esercizio 1853-54.
Il Consiglio comunale aveva deliberato di far cadere la nomina di capitano dei barracelli su Peppe, il mio fratello gemello. Era evidente che si voleva tutelare la sicurezza della proprietà col prestigio del mio nome di bandito.
Peppe me ne aveva già parlato, e il Consiglio [326] chiedeva il mio parere, prima di accingersi alla nomina definitiva,
— Non voglio assolutamente che tu sia il capitano! — risposi a mio fratello: — Tu devi rifiutare. Penserò io ad aggiustare le cose.
Partecipata la rinunzia al Consiglio, questo per tre volte confermò la nomina di Peppe Tolu; e quando si seppe che mio fratello rifiutava per mio suggerimento, alcuni consiglieri pregarono il sindaco di consultarsi con me per formare la compagnia barracellare di Florinas.
Il sindaco uscì un giorno dal paese, come per diporto, e venne ad abboccarsi con me in campagna.
— È egli vero che tu ti opponi perchè tuo fratello non accetti la carica di capitano, che vuole affidargli il Consiglio?
— È verissimo!
— E perchè ciò?
— Perchè mio fratello non può, nè deve accettare la carica di capitano dei barracelli!
— Lo credi forse incapace a coprirla?
— Lo credo capace, quanto abile ed onesto; ma è troppo povero, e gli mancano i mezzi per disimpegnare convenientemente simile carica. Il capitano ha bisogno di comoda stalla per custodirvi i cavalli, quando capita la ronda dei barracelli d’altro comune; ha bisogno di essere agiato per mettersi in grado di invitare a pranzo gli amici, quando l’occasione si presenta; ha [327] bisogno di spendere del proprio, perchè non ha disponibile che la sola metà del salario anticipato dai vassalli. Di questo salario non potrebbe servirsi, poichè dev’essere ripartito alla fine della gestione fra i barracelli che rondano e lavorano lungo l’anno: — se si verificano danni dovrà pagarli subito; se c’è benefizio, dovrà fare il riparto equo. Mio fratello è troppo povero, nè potrebbe senza sagrifizi ed umiliazioni disimpegnare una carica così delicata. Credo in coscienza, che l’agiatezza e il benessere siano indispensabili a chi è chiamato ad amministrare la roba d’altri; e la miseria è sempre cattiva consigliera. Vi indicherò io la persona da presciegliere per capitano dei barracelli. Intanto vi prego di far venire qui don Ignazio Piras: ho bisogno di conferire con lui.
Venuto a me don Ignazio, prese a dirmi col sorriso bonario dei signori, che vogliono canzonare i poveri diavoli:
— Ma perchè non vuoi permettere che tuo fratello faccia il capitano? Tornerebbe ad onor tuo questa nomina; poichè quando si sapesse che il capo della barracelleria è stretto congiunto ad un famoso bandito, i ladri si guarderebbero dal recar danno all’altrui proprietà!
— Si persuada, don Ignazio; noi possiamo ancor vivere senza quest’onore. Non insista più oltre, e mi risponda!
— Sentiamo.
[328]
— Quanti agricoltori può ella contare sotto la dipendenza della sua casa?
— Una ventina; tu lo sai.
— E il dottor Andrea Serra?
— Altrettanti.
— Ciò vuol dire, che le vostre due case dispongono dell’intiera popolazione. Invece, dunque, di un capitano, vi suggerisco di nominarne due; e la scelta non dovrà ricadere che su don Ignazio Piras e sul dottor Serra. In tal modo la popolazione di Florinas dipenderà dalle vostre famiglie. Il numero dei barracelli, fissato in 15, e che potreste raddoppiare, voi non lo porterete che a soli 25; e così il barracellato, alla cui riorganizzazione è concorso tutto il paese, non sarà inviso alla popolazione, la quale vivrà tranquilla nell’unione e nella concordia. È questa la mia opinione!
Don Ignazio fece subito convocare il Consiglio comunale, e gli comunicò la mia proposta, che venne accettata dalla maggioranza con viva soddisfazione.
Formata la compagnia barracellare sulla base da me suggerita, venni invitato a recarmi segretamente a Florinas[45].
Trovandomi in quel tempo insieme a Pietro Cambilargiu, lo pregai di tenermi compagnia.
[329]
Ci presentammo in casa del capitano don Ignazio Piras, dove già trovavasi il suo collega dottor Serra, nonchè i 25 barracelli, colà attirati dalla curiosità di veder me e Cambilargiu, del quale avevo preannunziato la visita.
Come ci presentammo nella sala, don Ignazio fece far silenzio, e rivolgendosi a me, prese la parola solennemente:
— Giovanni Tolu; noi abbiamo seguìto il tuo suggerimento. Devo però dirti, che il Consiglio ha deliberato di nominar te e Cambilargiu a far parte della nostra barracelleria. Non pretendiamo che voi andiate alla ronda (c’è abbastanza gente per farla!), ma desideriamo solo che esercitiate una scrupolosa sorveglianza, massime verso i ladri di bestiame. Dei guadagni della compagnia, voi sarete messi a parte al pari degli altri; quanto alle perdite, non dovete preoccupacene: pagheremo noi la vostra quota! Accettate?
Fatto un inchino rispettoso, io risposi:
— Don Ignazio, dottor Serra, amici tutti: io posso assicurarvi che la capitaneria di questo anno avrà un esito soddisfacente, e apporterà buoni frutti. Essa riuscirà più famosa di quella, che la tradizione ci dice formata un’ottantina d’anni fa, sotto il comando di Baingio Canu. Questo capitano (nominato quasi a dispetto del Consiglio comunale) non volle seco che un solo barracello: il proprio nipote Pietro Canu. Vi [330] ricorderò il fatto, quale lo raccontano i nostri vecchi.
«Narrasi, che la notte susseguente alla costituzione della strana compagnia di due individui, si verificò il furto di due cavalli, eseguito coll’intenzione dispettosa di farli pagare al capitano ed al nipote. Avuta la relazione della mancanza del bestiame, Baingio Canu andò, sull’imbrunire, a trovare il nipote:
«— Pietro — gli disse — prendi il fucile e seguimi!
«Baingio Canu era un uomo energico e risoluto: buono o cattivo, a seconda le circostanze.
«Si recarono entrambi, a notte tarda, dinanzi alla casa di colui, che sapevano essere l’autore del furto.
«— Bada di far fuoco sul ladro, appena si presenterà alla porta! — fece Baingio al nipote.
«— Sono agli ordini del capitano! — rispose Pietro, che rappresentava l’intiera compagnia.
«Lo zio picchiò risoluto alla porta.
«— Apri Antonio, e vieni fuori: sono io!
«Il disgraziato si fece all’uscio, e cadde fulminato da una fucilata.»
— Così, o signori, finirà questa capitaneria — conchiusi, rivolto all’adunanza. — Spero, però, che non avremo bisogno di spargere sangue umano, poichè i ladri ci rispetteranno!
[331]
Gli astanti si congratularono con me, e la seduta fu levata[46].
Pietro Cambilargiu non disse una parola; egli ben sapeva, come mio compagno, che non doveva opporsi a quanto avevo stabilito.
Terminata la discussione, don Ignazio Piras ordinò ai suoi servi di andare in cantina a spillare il miglior vino. Fu dato a tutti da bere, e si chiacchierò allegramente per una mezz’ora.
Uscimmo dalla casa di don Ignazio per recarci in quella del dottor Serra, dove ci fu offerto lo stesso trattamento.
La moglie del dottore, colla quale ero in [332] confidenza, m’abbracciò, e mi baciò sulla guancia, alla presenza di tutti.
Cambilargiu, ch’era al mio fianco, mi disse con una certa amarezza:
— Vedo che sei proprio ben voluto nel tuo paese!
Uscimmo sulla via, seguiti dai nuovi barracelli e da molti amici. Eravamo costretti a fermarci di casa in casa, poichè ognuno voleva offrirci da bere. Una folla di curiosi ci veniva dietro, e tutti parevano soddisfatti di vedere i due banditi, resi maggiormente celebri dopo i recenti attacchi di Nuzzi e di Monte Fenosu.
A Pietro Cambilargiu davano solo il benvenuto; ma io ero fatto segno a dimostrazioni affettuose. Tutte le donne del mio paese, vecchie e giovani, venivano sulla porta per stringermi la mano e per baciarmi, compiangendo il mio triste destino. Ero vivamente commosso; mi pareva di sognare, in mezzo a quella gente che mi aveva veduto nascere, o colla quale avevo trascorso i più bei giorni della giovinezza.
Mi accorsi che quell’accoglienza affettuosa e spontanea era una spina al cuore di Cambilargiu. Egli mi camminava al fianco imbronciato e riflessivo. Io, che conosceva la sua natura diffidente e sospettosa, gli leggevo in fondo all’anima. Egli certamente supponeva, che i tanti amici miei non potevano essere che suoi nemici, poichè volentieri avrebbero a lui teso un’insidia [333] per concedere a me l’impunità a prezzo della sua morte. Pensiero eterno del bandito, che lo spinge a diffidare dell’amore, che altri nutre per un compagno d’infortunio!
Finalmente ci separammo, poichè non era prudenza rimanere più a lungo in quel luogo — quantunque a Florinas non vi fossero carabinieri, e don Ignazio avesse preso le debite precauzioni, prima di chiamarmi in paese.
[334]
Dopo la nostra nomina a barracelli di Florinas, non tardai ad accorgermi che Cambilargiu mi guardava in cagnesco, e non era con me leale, come prima. Egli forse pensava, ch’era impossibile un’illimitata confidenza fra un giovane trentenne ed un uomo grave di mezzo secolo. Era invidioso della benevolenza che mi dimostravano i Florinesi: indizio questo, che il mio paese non mi considerava come un tristo, ma bensì come un disgraziato; e se avevo nemici a cui la mia esistenza dava cruccio, avevo pure amici che mi volevano bene.
Un solo fatto basterà a provare che la mia famiglia era ritenuta onesta e di buon conto in paese. Io avevo imposto ai miei parenti di non mai immischiarsi nelle mie vendette. Bastavo io solo per compierle: essi non dovevano compromettersi. Con orgoglio posso dunque affermare, che mentre i congiunti degli altri banditi vennero uccisi, molestati, o tratti in prigione, a nessuno de’ miei parenti fu recato alcun danno, nè [335] da’ miei nemici, nè dalla giustizia. Io solo fui il disgraziato e il perseguitato, e ciò torna ad onore della mia famiglia!
Continuai ad accompagnarmi con Cambilargiu, ma l’uno ormai era di peso all’altro. In lui l’invidia e il rancore per l’affetto che mi addimostravano i Florinesi; in me il disgusto delle sue triste azioni, che mi ripugnavano.
Ogniqualvolta si andava insieme ad Osilo, fermandoci negli ovili, Cambilargiu domandava con insistenza una pecora od un capretto ai poveri pastori; i quali glieli davano subito, perchè avevano di lui una paura maledetta. Ma non basta: egli portava quel capretto o quella pecora nelle aie dei ricchi possidenti, e là si mangiava tutti insieme, me compreso.
Eseguita diverse volte questa vergognosa estorsione, un bel giorno io dissi a Cambilargiu in uno di questi pranzi:
— Zio Pietro, vuoi che ti parli chiaro? Non mi piace questo tuo sistema. Tu strappi con violenza un agnello ai poveri pastori che hanno i figli scalzi, per darlo a mangiare ai ricchi che possiedono pecore ed agnelli in abbondanza. Non trovo troppo lodevole le azioni tue!
Queste mie parole, pronunciate a tavola, alla presenza di tutti, inasprirono Cambilargiu e i benestanti commensali. Essi me ne mossero acerba lagnanza, ma io feci il sordo e non risposi.
Un altro giorno ci trovammo insieme nelle [336] vicinanze di Osilo, dove la sua burbanza raggiungeva il colmo. Mentre si chiacchierava in un’aia, scappò di là la famosa cavalla che avevano preso ad Ossi, per far dispetto al capitano dei barracelli. Cambilargiu pretendeva che andassi io a rintracciarla.
— No, zio Pietro. Qui siamo nel territorio del tuo paese, e spetta a tuo cognato riportare la cavalla. Io non manco di dartela insellata, quando ti accompagno nelle terre di Florinas. Se tuo cognato non farà il dover suo, aggiusterò io la faccenda!
E qui un altro vivo diverbio, che per fortuna fu sedato dai parenti, i quali mi diedero ragione. Il cognato di Cambilargiu riportò la cavalla, e la cosa passò liscia.
Poco tempo dopo, vennero rubate due bellissime cavalle dal villaggio di Santo Lussurgiu: l’una appartenente a Francesco Beccu, l’altra di proprietà di Andrea Sanna. Si sparse la voce che fossero in potere di Cambilargiu e di Antonio Spano — ed era vero.
La cavalla del Sanna, posseduta dallo Spano, era morta; l’altra del Beccu era quella che montava Cambilargiu, quando l’ebbi a compagno.
Non c’era verso ch’ei volesse restituirla; ed un bel giorno gli dissi a denti stretti:
— Senti: qui si tratta della roba d’altri, nè io voglio essere complice di furti, che detesto. Se tu non restituirai la cavalla al padrone, [337] io rinunzio al piacere d’esserti compagno. Separiamoci!
Cambilargiu si rassegnò a restituire la cavalla a Francesco Beccu, ma pretese da lui dodici scudi, dicendo che ugual somma aveva egli sborsato a chi gliela cedette.
Non era ancora trascorso un mese dalle dimostrazioni popolari ricevute a Florinas, quando Cambilargiu, sempre diffidente perchè si sentiva meno agile per l’età avanzata, prese a dirmi con bontà affettata:
— Con te, che mi sei figlio, non posso aver riguardi. Devo avvicinarmi ad Osilo per affari urgenti. Quando avrai bisogno di me, fammi sapere il luogo dell’appuntamento, e sarò sempre il tuo fido compagno.
Così dicendo, ci separammo. Parecchie volte lo invitai a venirmi a trovare nell’ovile di mio cognato, ma con mia sorpresa egli non si lasciò mai vedere. Era chiaro che la diffidenza lo aveva allontanato dal territorio di Florinas, temendo che i miei compaesani gli tendessero un’insidia.
Ma neppur io mi mossi per andarlo a trovare ad Osilo — nè più lo rividi.
Intanto, scaduto l’anno del barracellato di Florinas, venne fatto il riparto della raccolta, e toccarono a ciascun barracello settanta scudi di benefizio.
Quando ciò seppe Cambilargiu — quantunque [338] neanche una volta avesse prestato l’opera sua — mandò una lettera da Osilo a Don Ignazio Piras, ricordandogli che anche lui era un barracello di Florinas, e pretendeva la sua porzione. «Se non l’intiero (egli scriveva). voglio almeno una parte, perchè sono povero.»
Erano rimasti a fondo del Bilancio sei scudi, ed io consigliai di non darglieli; ma Don Ignazio, temendo la ferocia di quell’uomo, glie li mandò fino ad Osilo.
Continuai pertanto a interessarmi della barracelleria di Florinas, sempre fiero di venir consultato dai barracelli, che in me riponevano la loro fiducia.
Il capitano non dura in carica che un solo anno, e a Don Ignazio Piras era succeduto Gavino Pintus, il padre di Maddalena Bua.
Nominato capitano dal consiglio comunale, quest’ultimo non aveva voluto accettare; ed allora fu chiamato a Sassari dall’Intendente generale per conoscere le ragioni del rifiuto.
— Non accetto la carica di capitano — rispose il Pintus — perchè per contentare il paese dovrei ricorrere ai congiunti del bandito Giovanni Tolu — e non so se vostra eccellenza vorrà autorizzarmi a simile scelta!
L’Intendente gli disse:
— Va pure in paese, e nomina i barracelli che vuoi, purchè tu faccia il capitano.
Tornato Pintus a Florinas, si affrettò a comunicarmi [339] la risposta dell’Intendente. Io lo persuasi a fare il capitano; ed egli chiamò a far parte della compagnia i miei fratelli Peppe e Gio. Maria, nonchè Giuseppe Rassu, il più savio di quella famiglia malnata.
Quantunque io più non appartenessi alla compagnia barracellare, si volle ch’io fossi compreso nel riparto degli utili annuali. Mi si dava la porzione, senza ch’io la chiedessi.
Durante questa barracelleria erasi verificata la mancanza di due cavalle, per una delle quali fu inutile ogni ricerca. Trascorso quasi l’anno, ricevetti una lettera da un amico, il quale m’informava segretamente che la cavalla trovavasi a Mores. Egli mi sollecitava ad adoperarmi per farla restituire ai barracelli, che l’avevano già pagata al padrone.
Parlatone coll’ex capitano Pintus, questi mi consigliò di non occuparmene.
— No — gli dissi — ci va dell’onore della compagnia, e farò il mio dovere.
— Ebbene, se tu riescirai a ricuperarla, tienila per te!
Volli consultare i barracelli, i parenti e gli amici, e tutti si dichiararono contenti che la cavalla fosse mia. Ritiratala facilmente per mezzo di mio fratello, la tenni in stalla dall’ottobre al marzo, senza servirmene.
Avendo veduto la cavalla, alcuni malevoli misero in giro la voce che non era quella di Florinas, [340] ma bensì un’altra rubata in Campidano dalla combricola del bandito Bìcchiri.
La cavalla, infatti, non era quella di Florinas; ma io feci rispondere ai maldicenti, ch’ero pronto a restituirla al padrone, se me lo avessero indicato.
Un assessore comunale osò avvertirmi:
— Bada, Giovanni; non lasciar montare la cavalla da’ tuoi fratelli, poichè verrebbero arrestati e messi in carcere.
Io risposi di mala grazia:
— Senta: la cavalla che ho in istalla non è quella di Florinas. Se conoscessi il padrone vorrei intendermela con lui, poichè l’ho ingrassata a mie spese. Io però la prevengo, che chiunque osasse toccarmela — sia sindaco, brigadiere, o demonio — ci rimetterà la vita!
Nessuno mai venne a reclamare la cavalla. La tenni per un po’ di tempo, finchè la vendetti nella Nurra, dichiarando che avrei risarcito il padrone, se si fosse a me presentato[47].
[341]
***
Non avevo più riveduto Pietro Cambilargiu. Un giorno Don Ignazio Piras mi disse in confidenza, che il bandito osilese gli aveva mandato una lettera, chiedendogli con minaccie danaro.
— Che debbo fare?
— Non gli dia nulla.
— Uno è dirlo, l’altro è farlo. Tu sai ch’io vado spesso in campagna...
— Si affidi a me. Ci penserò io!
E infatti mandai a dire al mio antico compagno, che si guardasse bene dall’avvicinarsi al mio paese; poichè era un’azione indegna quella di estorcere danaro a persone, che aveva conosciuto per mio mezzo. Lui era stato educato nell’ergastolo di Villafranca, e voleva fare il brigante alla continentale — io invece preferiva fare il bandito alla sarda!
Non ebbi più notizia di lui, fino al giorno della sua morte, che narrerò brevemente.
Separatosi da me, Pietro Cambilargiu sentì il bisogno di aver nuovi compagni. Egli si accorgeva di essere diventato un po’ sordo e di vista debole.
Si era prima provato ad andar solo; in seguito ebbe a compagni i banditi Depalmas e Salvatore Fresu, dai quali si separava con frequenza, essendo anch’essi di età matura e poco [342] agili. A quel tempo Cambilargiu, quando a notte oscura usciva da un ovile, aveva bisogno di venir accompagnato fino a un luogo di rifugio da persona fida, e così pure i suoi nuovi amici Depalmas e Fresu. Condizione miseranda dei banditi, quando diventano vecchi!
Intanto il Governo, per potersi impadronire del famoso bandito osilese, aveva ricorso al maresciallo Scaniglia, il quale si era assunto l’impegno di consegnarlo, vivo o morto, e con qualunque mezzo, nelle mani della giustizia.
Lo Scaniglia, alla sua volta, aveva ricorso ad alcune spie; e, fra gli altri, era riuscito a raggirare Luigi Marceddu, lontano nipote di Cambilargiu. Costui, già proprietario pastore, era allora sotto una penale di 70 rasieri di grano, dovuto per contravvenzione nella viddazzone di Sennori.
Il maresciallo Scaniglia, non solo lo fece assolvere dalla penale, ma gli donò ottanta marenghi, a condizione che si adoperasse per dargli in mano, vivo o morto, lo zio Pietro Cambilargiu.
Trovandosi Luigi Marceddu nella vallata di Logulentu, in compagnia di Cambilargiu (che si fidava del nipote) riuscì ad ucciderlo. Datone subito avviso al maresciallo, questi accorse sul luogo con altri cinque carabinieri — e crivellarono di palle il cadavere del bandito..... [343] forse per allontanare i sospetti da una spia, sì abilmente guadagnata[48].
In tutta la provincia, e specialmente a Sassari, la notizia della morte di Pietro Cambilargiu fu accolta con vera gioia, e quasi con feste.
Non tardò il congiunto Marceddu a ricevere la paga del suo nero tradimento. Egli venne ucciso da un mugnaio — da certo Giomaria Ibba — ch’ebbi più tardi a compagno, e di cui parlerò a suo luogo.
[344]
Appena ucciso il negoziante sassarese Dionisio, il bandito Antonio Spano e i suoi amici si erano dati a spargere la voce che l’uccisore ero stato io.
A Sassari si trovava in quel tempo l’avvocato Todde, cagliaritano, professore all’università. Spinto dalla curiosità di vedermi da vicino, gli fui presentato in campagna, col pretesto d’una partita di caccia; ed egli si mosse a pietà delle mie sventure. Volle conferire con alcuni magistrati, e fu riconosciuta la necessità di chiamarmi con salvacondotto, per interrogarmi sull’uccisione di Dionisio, sperando di attingere nuovi schiarimenti.
Il prof. Todde, d’animo nobile e generoso, aveva preso impegno di farmi abboccare coi giudici, unicamente per mettere in chiaro la mia innocenza, smentendo le dicerie che correvano sul mio conto.
Consultatomi coll’avv. Piras, accettai il salvacondotto.
[345]
Il convegno mi fu dato in casa di Don Ignazio Piras, a Florinas, dove si recarono colla diligenza il giudice istruttore Murgia, il procuratore del re Costa ed un segretario. Furono tutti trattati con vero sfarzo in casa Piras; basti il dire, che nel pranzo offerto agli ospiti vennero presentati a tavola venti piatti caldi.
Comparso dinanzi a questi signori, il giudice Murgia chiese a Don Ignazio un libro di Evangeli per sottopormi al giuramento.
— Non importa — dissi — ho in tasca l’ufficio della Beata Vergine, che pur contiene alcuni brani del Vangelo. D’altra parte credo inutile ogni giuramento, perchè io deporrò il vero, secondo coscienza.
— Che cosa sai dell’uccisione di Giovanni Antonio Matti, detto Dionisio?
— So abbastanza. Mi trovavo di passaggio in un ovile della Nurra, dov’era una serva sassarese. Costei, giorni prima, era stata citata a Sassari come teste nella causa Dionisio. Ritornata all’ovile, le chiesi per curiosità notizie del processo; ed ella mi disse, che le avevano imprigionato il genero, per aver prestato ad Antonio Spano le sue vesti da muratore, colle quali si era mascherato per uccidere più facilmente Gio. Antonio Dionisio...
— Ed altro non sai? — mi chiese il giudice Murgia, alquanto sorpreso.
— Non c’è da saper altro. Il bandito Spano [346] ha ucciso il signor Dionisio, per vendicare l’insulto fatto al proprio fratello!
Mi furono fatte diverse altre domande, che forse avevano rapporto con qualche processo in corso od in vista. I giudici vanno sempre in cerca di nuovi fili, ma non sempre la loro tela è ben tessuta. Ond’è che questa (come lessi in un libro) rassomiglia ben sovente a quella dei ragni: prende i moscerini, ma lascia scappare i mosconi!
Prima di licenziarmi, il procuratore del re Costa mi chiese scherzando:
— Hai tu fiducia nei salvacondotti?
— E perchè no? Io credo che il Governo abbia il dovere di essere leale!
Confesso, nondimeno, che, prima di mettermi in viaggio per Florinas, avevo fatto vedere il salvacondotto ad una persona di fiducia — a don Luigi Nurra, fisco a Cagliari, e genero del generale Grondona di Tiesi, che si era ritirato a Cargeghe. Le precauzioni non sono mai troppe!
Fu questo il mio primo salvacondotto; in seguito n’ebbi altri, come dirò a suo tempo.
***
Ho già parlato di uno zio di Antonio Spano, a cui io e Cambilargiu tentammo un giorno di rubare una cavalla, in odio al nipote. Parlerò ora di un altro suo zio, Luigi Mudadu, già laborioso [347] ed onesto, ma divenuto in seguito sicario, perchè unitosi al nipote.
Un giorno, a Tissi, era avvenuta una grassazione a danno di un certo Sebastiano Selis e di sua moglie Rosalia Figos; i quali erano stati assaliti nella propria casa, e derubati di molto danaro e di molta biancheria. Denunziati i malandrini al tribunale, nessuno venne molestato, per mancanza di prove. Non mancò tuttavia chi risentì danno da questa denunzia, e pensò alla vendetta. Il mandato di sangue fu affidato a Luigi Mudadu, il quale, per danaro, tolse dal mondo Sebastiano Selis.
Un altro giorno Antonio Spano, insieme a Cambilargiu e ad altri quattro compagni, si recarono alla Nurra per dar l’assalto al noto sicario Francesco S*, nell’ovile di Rumanedda. Quantunque colpito da molte palle, il Francesco fu trasportato ad Ossi, e non tardò a guarire.
Non passò gran tempo, che Antonio Spano, col concorso di altri sei complici, ritentò il colpo su Francesco S*, assalendolo nella propria abitazione, ad Ossi. Le grida della sorella di costui diedero l’allarme, e gli assalitori dovettero rinunziare all’impresa.
Ai menzionati delitti, col braccio o col consiglio, non fu estraneo Luigi Mudadu.
I due ribaldi, zio e nipote, continuarono senza tregua nella via del misfatto, eccitati più dall’ingordigia del danaro, che dalla voce dell’odio [348] e della vendetta. Non li seguirò nelle loro scorrerie. Dirò solo, che l’ora della condanna era suonata per entrambi.
Antonio Spano, imprudentemente, aveva minacciato un giovane d’Ossi, prevenendolo che lo avrebbe ucciso. Costui andò a consultarsi con altro bandito compaesano, certo Andrea Sanna, che gli era amico.
Fu concertato, che entrambi si sarebbero appostati sotto una roccia, per spiare lo Spano, che con frequenza soleva recarsi a Muros.
— Se ci verrà incontro in campagna, noi lo uccideremo — aveva detto Sanna — se invece entrerà nel villaggio, lo faremo arrestare, perchè ci è nota la casa del suo rifugio.
Sull’imbrunire, non visti, essi scorsero Antonio Spano che prendeva il cammino di Muros.
Il bandito Sanna si fermò in campagna per assicurarsi che lo Spano non uscisse dal paese; il giovane invece andò di corsa a Sassari per dare avviso all’arma dei carabinieri.
Verso l’alba alcuni carabinieri giunsero a Muros travestiti da stacciai, e si aggirarono per il paese, fingendo vendere la loro mercanzia.
Si presentarono alla casa, in cui si supponeva fosse nascosto il bandito Antonio Spano, e si trattennero a lungo dinanzi alla porta, contrattando colle donne la vendita degli stacci, in attesa di altri sei carabinieri a cavallo, partiti da Sassari un’ora dopo, come d’intelligenza.
[349]
Come si accorsero che i compagni entravano in paese, i due stacciai si slanciarono di scatto nella stanza vicina, puntando le pistole al petto del bandito, che non ebbe il tempo di mettersi in guardia.
— Siamo carabinieri! Ti arrendi, o Antonio Spano?
Colto all’improvviso, quell’imbecille fissò come istupidito i due armati, e non ebbe il coraggio di far resistenza. Le due bocche delle pistole, rivolte contro al suo petto, lo impressionarono. Ebbe paura... e fu vile! Al suo posto io avrei lottato fino a farmi uccidere. Una palla di piombo è sempre la benvenuta, quando ci salva dalla forca!
Antonio Spano cedette le armi ai due stacciai, ed abbassò il capo con rassegnazione, mormorando a fior di labbro:
— Mi arrendo!
Fu ammanettato e tradotto alle carceri di Sassari.
Poco tempo dopo venne pur tratto in arresto lo zio, Luigi Mudadu, l’uccisore di Sebastiano Selis.
Il dibattimento dei due banditi ebbe luogo a Cagliari, e furono entrambi condannati alla morte.
Ordinata la traduzione a Sassari per esservi impiccati, i due prigionieri si posero in cammino a piedi, scortati da molti carabinieri a cavallo.
Strada facendo essi si misero d’accordo; e [350] riuscirono a comprare alcune scatole di zolfanelli, che tennero per più ore in infusione in un fiaschetto d’acqua. Approfittando di una sosta lungo il cammino, i due congiunti trangugiarono arditamente la bevanda, e si avvelenarono. Il nipote, di complessione piuttosto delicata, morì lo stesso giorno; lo zio, più robusto, sorvisse ancora tre giorni.
Ed ecco la fine di Pietro Cambilargiu e di Antonio Spano, i due più efferati banditi del Logudoro, ch’ebbi a compagni per un po’ di tempo. Il primo morì assassinato da un parente traditore; il secondo si salvò dalla forca col veleno!
FINE DEL PRIMO VOLUME
[351]
| Ai Lettori (Storia della Storia) | Pag. 5 | |
| Sui banditi del Logudoro (Pagine storiche) | 11 | |
| PARTE PRIMA | ||
| PRIMA DELLA COLPA. | ||
| Cap. | ||
| I. | Infanzia e prima giovinezza | 59 |
| II. | In cerca d’una moglie | 71 |
| III. | Alla festa di Mara | 78 |
| IV. | Ritorno dalla festa | 89 |
| V. | Fattucchierie | 96 |
| VI. | Convegni amorosi | 101 |
| VII. | Sponsali e luna di miele | 108 |
| VIII. | Prime nubi | 116 |
| IX. | Tentativi di pace | 127 |
| X. | L’attentato | 138 |
| PARTE SECONDA | ||
| IL BANDITO DI FLORINAS. | ||
| I. | Si torna agli esorcismi | 147 |
| II. | In casa di prete Pittui | 158 |
| III. | La famiglia Rassu | 167 |
| [352] | ||
| IV. | Si apre la campagna | 179 |
| V. | Chi nasce e chi muore | 193 |
| VI. | Duello a morte | 203 |
| VII. | Gli ultimi Rassu | 217 |
| VIII. | Agostino Alvau | 224 |
| IX. | Il bandito Derudas | 235 |
| X. | Giusta pena e pena ingiusta | 243 |
| XI. | La penna vale il fucile | 251 |
| XII. | Cambilargiu, Spano, Fresu | 260 |
| XIII. | I quattro banditi | 274 |
| XIV. | In bocca al lupo | 286 |
| XV. | A Monte Fenosu | 299 |
| XVI. | Questua per un fucile | 312 |
| XVII. | Ricettatori | 317 |
| XVIII. | Barracellato di Florinas | 323 |
| XIX. | Ancora Cambilargiu | 334 |
| XX. | Ancora Antonio Spano | 344 |
VOLUME PRIMO
| Ritratto di Giovanni Tolu | (frontispizio) |
| Lettera iniziale allegorica al banditismo | Pag. 13 |
| Testata allegorica sui personaggi della storia | 59 147 |
| Moglie tentatrice, e il villaggio di Florinas | 69 |
| Gli sposi uscenti dalla chiesa | 109 |
| Attentato contro il prete Pittui | 140 |
| Il bandito dal Rettore di Dualchi | 155 |
| Uccisione di Francesco Rassu | 215 |
| Il salto dalla roccia di Monte Fenosu | 307 |
1. Giovanni Tolu, fatalmente, morì a Portotorres, di carbonchio, nel pomeriggio dei 4 luglio 1896 — circa un mese dopo che avevo consegnato il mio manoscritto all’Editore Dessì. A proposito della sua morte il lettore troverà un’appendice in fondo a questo libro.
2. È ancor viva nel popolo la famosa carestia nel 1780, che provocò da per tutto disordini, specialmente a Sassari.
3. Nella famiglia di Giovanni Tolu furono comunissimi i parti doppi. Anche la figlia del bandito n’ebbe parecchi.
4. Florinas, a 15 Chilometri da Sassari, è un ameno paesello di circa 2200 abitanti. Dicesi costrutto sulle rovine di Figulina, oppido romano. Posto in altura, sopra un gruppo di pittoresche colline, vi si gode di un orizzonte vastissimo. Gli abitanti, industriosi, attivi, intelligenti, sono per la maggior parte dediti all’agricoltura. Questo comune, uno dei più lindi dell’isola, ha fatto notevoli progressi in questi ultimi tempi. Dal 1849 ed oggi il suo piano topografico si è quasi trasformato, poichè molte case furono demolite per la sistemazione delle vie e delle piazzette, che vi sono spaziose, arieggiate, pulitissime.
5. Non so a quali malifizî qui accenni il Tolu. Certo è, che prima del 1848 (ed anche dopo!) il volgo si lasciava trascinare a superstiziose credenze, alimentate dall’ignoranza o dalla furberia di chi aveva il dovere di combatterle.
6. Giovanni Tolu mi citava assai spesso i personaggi della Storia sacra e quelli dei Reali di Francia — letture sue predilette, dopo che fu bandito, come vedremo in seguito.
7. Era questa l’abituale espressione dell’ex bandito. Per mia opinione egli intendeva dir tutto: il mio parere, il mio desiderio, la mia volontà, il mio intendimento, la mia decisione, ecc. ecc.
8. La chiesa di Bonuighinu (Buon vicino) è sacra alla Vergine addolorata. Ha un bell’atrio quadrato, ed è costrutta su di un monte conico di difficile accesso, circondato da foreste, con ruderi di mura antiche, di una torre, e di due cisterne appartenenti al famoso castello omonimo, pur detto di Bonvhei. Questo castello, eretto dai Doria, fu da questi venduto a Mariano di Arborea; il quale, dopo averlo ceduto nel 1355 al re di Aragona, lo riebbe nel 1364. Tornò in seguito, nel 1388, agli aragonesi, e poi di nuovo ai Doria nel 1436.
La festa di N. S. di Bonuighinu, con fiera, ha luogo nella terza domenica di settembre, e vi accorre molta gente da ogni parte dell’isola, sebbene in minor numero e con minor entusiasmo di quella che vi accorreva prima del 1850.
9. Noti il lettore questo curioso amor proprio rusticano. La povertà era ritenuta un’umiliazione, anche dalla classe dei contadini!
Ha dell’incredibile la felice memoria di Giovanni Tolu sui fatti accaduti da oltre quarant’anni! Egli mi narrò molti altri particolari, che ho taciuto perchè insignificanti. Ripeto che l’ex bandito fu scrupolosissimo nella sua narrazione, nè accennò mai a fatti, senza declinare nomi di persone e di località.
10. Ricordi il lettore, che io riporto fedelmente, quasi parola per parola, la narrazione dell’ex bandito. Parrà certamente incredibile, che un uomo come Giovanni Tolu, assennato, pieno di buon senso, e d’una istruzione non comune, potesse prestar fede alle legature e ad altre simili fandonie. Eppure è così! Era una sua debolezza a molti ignota, e appena sfiorata nel processo svolto nelle Assise di Frosinone. Il Tolu mi parlava delle fattucchierie con profonda convinzione, e si mostrava offeso ogni qualvolta io le metteva in dubbio od in ridicolo. Rileverà il lettore, andando innanzi nella narrazione, altre stranezze dello stesso genere, ch’io riporterò fedelmente, senza commenti.
11. Non dovremo noi scusare la superstizione di Giovanni Tolu, quando la vediamo condivisa, o alimentata da sacerdoti così credenzoni? Poveri paesi, e poveri tempi!
12. Una volta per sempre devo dichiarare, che io riporto fedelmente la narrazione dell’ex bandito, e che non aggiungo una parola ai dialoghi, che sono tutti tuoi. Ripeto che non volli alterare l’originalità delle scene rusticane con slanci di rettorica convenzionale.
13. Forse l’avv. Racca, reggente allora l’intendenza Generale, dopo la partenza di De Monale. Il Racca fu Intendente di Alghero nel 1855, e Vice Governatore di Sassari dal 1859 al 1862.
Erano tempi d’inimicizie e di fucilate, e le Autorità cercavano ogni mezzo per togliere il pretesto ai sanguinosi conflitti, allora frequentissimi.
14. Specie di guardaboschi. Si era da un solo anno sotto la Costituzione, ma pare si continuasse a governare coll’autoritarismo del regime assoluto!
15. Lungo questa scarpa fu di recente costruito un parapetto.
16. Recipiente di forma cilindrica, intessuta di canne, per custodirvi il grano quando si ritira dall’aia.
17. Era allora Luogotenente, non Maggiore di piazza.
18. Pare che i preti e i frati d’allora attingessero la potenza dell’esorcismo alle illecite relazioni. È cosa che io ignoravo fino ad oggi!
19. Giovanni Tolu chiamava Perpetue tutte le serve dei preti.
20. Lo ripeto. Dovremo noi ridere della superstizione di Tolu, quando la vediamo incoraggiata in siffatta guisa da preti così ignoranti, o così furbi? Rimando il lettore alla nota apposta appiè della pagina 99.
21. Lascio a Giovanni Tolu tutta la responsabilità delle biografie contenute nella presente storia. Per quanto scrupoloso e veritiero egli fosse, noi dobbiamo pure ammettere che qualche volta l’ex bandito avrà giudicato gli uomini attraverso la lente del propri odî o delle proprie simpatie. D’altra parte il lettore non deve mai dimenticare il tempo in cui i nostri fatti accadono!
22. Badi il lettore che io riporto fedelmente, senza rispondere dei giudizi e delle asserzioni di Giovanni Tolu.
23. Fra Tolu e i Dore pare vi fosse ruggine antica. Vi ha un processo contro Tolu per insulti fatti a Giuseppe Dore mediante arma da fuoco, il 1. Giugno 1850 (era ammogliato da un mese e mezzo). — Gio. Tolu non me ne parlò; e forse l’accusa gli venne dal prete, indispettito per il matrimonio della sua servetta.
24. Narro il fatto colle precise parole del bandito, che non aggiunse altro. Era facile intendere, com’egli avesse preso di mira il suo nemico, fingendo far fuoco al par degli altri in direzione della costiera. Fu questo il primo uomo ucciso da Giovanni Tolu.
Quest’omicidio fu commesso il 19 maggio 1851, come risulta dal processo indiziario, che fu istruito a carico di Tolu.
25. La fede nei sogni era un’altra superstizione del Tolu.
26. Il ferimento avvenne il 19 aprile 1851. I sospetti caddero su Tolu, come mi risulta da un processo; però, con ordinanza del 17 dicembre 1852 fu dichiarato non farsi luogo a procedere. Sapremo più tardi la verità!
27. Pare che questa punizione fosse adottata nella sola Diocesi di Sassari.
28. Morì a Sassari il 21 agosto 1851, in età di 56 anni.
29. Il Tolu leggeva spesso i Reali di Francia, come vedremo in seguito.
30. Francesco Rassu fu ucciso il 4 gennaio 1853. Aveva 39 anni, come rilevai dai registri parrocchiali di Florinas.
31. Salvatore Rassu venne ucciso il 23 settembre 1854. Tolu mi fece comprendere di averlo ucciso lui, quantunque non si fosse istruito alcun processo, e molti ne dubitassero.
32. Altri disse, che una donna, complice del progettato assassinio, a un certo punto si era alzata dal tavolo per aggiustare il lucignolo di una lucerna, impedendo così all’Alvau di vedere Antonio Sento che armava il grilletto. Credo più veridica la versione del Tolu, che l’apprese della bocca degli stessi aggressori.
33. Il cadavere di Alvau fu portato sulle fascine a Sassari; venne subito esposto fuori Porta Sant’Antonio, e l’indomani in Piazza Castello.
34. Non era certamente il diavolo, ma era il dolore e l’onta per la condanna infamante, che avevano fulminato quel poveretto. Valga anche questo fatto per farci deplorare le pratiche edificanti di quei tempi!
35. Questa raffinatezza di ghiottoneria, inferocendo sulle povere bestie, farà arricciare il naso alla società protettrice degli animali, per i quali i pastori non nutrono certo la tenerezza dei cittadini civili. Questi, nondimeno, non cessano dal lagnarsi quando le carni non sono saporite!
36. Siamo giusti. Se la denuncia all’autorità giudiziaria fosse stata fatta da altri in odio a Tolu, non so se costui l’avrebbe trovata encomiabile!
37. Mancamento dicesi in sardo il bestiame mancante, denunziato ai barracelli dai proprietari.
38. Noti il lettore il prestigio che esercitavano i banditi sui pastori, e lo studio di questi per ingraziarseli.
39. Avrà notato il lettore i buoni accordi che correvano fra banditi e barracelli. Gli uni servivano gli altri.
40. Il fatto avvenne il 16 Settembre 1852. Fu ferito con arma da fuoco il brigadiere del cavalleggieri Giuseppe Andorno. Vi ha processo; ma con ordinanza del 30 dicembre si dichiarò non farsi luogo a procedimento.
41. Riassumo dagli atti del processo i fatti, secondo la relazione dei carabinieri e dei due contadini presenti.
«Il maresciallo dei cavalleggieri Teodoro Prelato, della stazione di Osilo, informato che Cambilargiu vagava nei dintorni, e specialmente a Nuzzi, il 10 giugno 1853 capitò nella vigna del medico Giorgio Vacca (figlio della vedova Chessa) insieme al brigadiere Gio. Leoni ed ai cavalleggieri Angelo Coas, Paolo Achenza, Giuseppe Dasara e Giuseppe Sassu. Entrarono nella casa rustica, dove subito accorsero i contadini Antonio e Francesco Vacca (fratelli del medico) che lavoravano nella vigna.
Il cavalleggiero Dasara aveva scaricato poco prima la canna del fucile, che teneva per dubbia. (Era questo lo sparo avvertito in precedenza dai due banditi).
Il maresciallo, udendo abbaiare il cane ed aprirsi il cancello, (distante dalla casa un 27 passi) era uscito fuori, seguito da Francesco Vacca, ed aveva riconosciuto, in uno dei due che entravano, Pietro Cambilargiu.
— Sei barracello, forse? — gli gridò.
— E tu sei maresciallo?
— Sì, lo sono!
— Vieni, cane, che ti metto la medaglia d’oro!
La lotta si era impegnata fra i due, che si fecero fuoco a vicenda. Il maresciallo ebbe spezzato da una palla il calcio della pistola. (Nessuno conosceva Tolu di persona.)
Corso il maresciallo dietro la casa per ricaricare l’arma, aveva gridato ai compagni: — Coraggio, c’è Cambilargiu!
Fu allora che i banditi uscirono prestamente dal cancello, lo rinchiusero, e vi appoggiarono un grosso sasso. Di là fecero due spari ed uccisero il cavalleggiere Sassu (con cinque ferite).
Fatti gli spari, i cavalleggieri corsero al cancello, ma non potendolo aprire, saltarono dall’alta siepe. I banditi si erano dileguati nè poterono inseguirli, poichè dinanzi alla vigna vi erano tre viottole, nè sapevano quale avessero presa.
Uno dei contadini disse, che Tolu fu ferito ad un dito ed ebbe spezzata la bacchetta del fucile.
Tolu niega che avessero messo il sasso dinanzi al cancello.
42. Vi ha processo per l’omicidio del carabiniere Antonio Rebichesu di Sassari, in atto di ribellione e resistenza; più per ferimento di altri due carabinieri, Antonio Contu e Francesco Sperone, mediante sparo. Si allude forse al carabiniere ferito accidentalmente al labbro dal maresciallo, ed a qualche altro colpito dal Tolu coi due spari fatti. Come mai costui, scaricando le due canne del fucile, poteva colpire tre persone in tre tempi diversi? C’è imbroglio nel processo; ed è forse perciò che si tacque di esso, mentre si portò alle Assise il solo scontro di Nuzzi, avvenuto due giorni prima di quello di Monte Fenosu.
43. Riporto le credenze di Tolu, senza commenti.
44. Anche gli Arcivescovi avevano paura dei banditi e cercavano di amicarseli!
45. L’anno del barracellato comincia coll’agosto, e termina collo stesso mese dell’anno susseguente.
46. La narrazione di Tolu, a proposito dei barracelli non deve sorprendere il lettore, poichè è un fatto che si verifica con molta frequenza. Certi latitanti (parrà strano!) erano, e sono tuttora ritenuti come una garanzia per le compagnie barracellari.
E fu così in ogni tempo. Il 6 dicembre 1730 (per citare un esempio) il Vicerè scriveva al Governatore di Sassari, autorizzandolo alla nomina di Francesco Farru a capitano della Compagnia, colla condizione imposta, di accettare i barracelli scelti da costui. Il Vicerè notava solo, che essendovi fra essi alcuni reos de delictos, non era bene accoglierli in un Corpo incaricato dell’estirpazione dei malandrini. — Eppure si doveva chiudere un occhio, e accettare i ladri per scongiurare i furti!
Della compagnie barracellarie si hanno nozioni fin dal tempo dei Giudici (nei secoli XII e XIII). Esse vennero stabilite in ciascun villaggio coll’obbligo di ricompensare, mediante retribuzione, qualunque danno sopportato nelle proprietà. Fu questa una delle ottime istituzioni sarde, conservate fino ad oggi, con qualche modificazione. Dopo il 1848 divennero volontarie, ed oggi sono rette dalla legge 22 maggio 1853.
47. Lo scambio delle due cavalle è un fatto misterioso; ma non posso fornire maggiori schiarimenti, poichè Tolu non me ne diede. Valga questa nota per altri punti un po’ oscuri della narrazione. L’ex bandito s’imbronciava quando io l’interrompevo per chiedere spiegazioni. Egli mi diceva secco:
— Scriva quanto le dico. Gli interessati mi comprenderanno!
Era un uomo singolare, un po’ testardo, e non bisognava insistere.
48. Fu ucciso nel pomeriggio del 23 giugno 1856 (vigilia di San Giovanni). L’indomani il municipio di Sassari fece un rapporto al Ministero, annunciando la morte di Cambilargiu, (pernicioso anche col solo prestigio del nome) ucciso da pochi carabinieri dopo viva resistenza. I cinque carabinieri, oltre lo Scaniglia, furono: Usai, Vargiu, Porqueddu, Pugioni e Catte.
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.
Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.